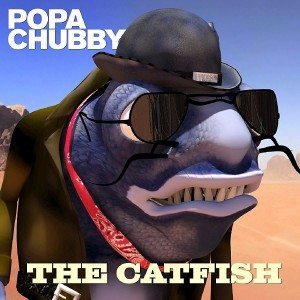Lee Ritenour – Dreamcatcher – The Players Club/Mascot Label Group
Diciamo che negli ultimi 30 anni (con l’eccezione del bellissimo album del 2010 Six String Therapy, ricchissimo di ospiti https://discoclub.myblog.it/2010/07/13/una-festa-per-gli-amici-della-chitarra-lee-ritenour-6-string/ ) avevo perso contatto con la musica di Lee Ritenour, anche se mi pare di avere recensito per il Busca anche un disco di Rit ancora negli anni ‘80. Prima un paladino del jazz nei suoi anni formativi, poi sessionman di lusso già da giovanissimo (come ricorda lui stesso uno dei suoi primi lavori, a 16 anni, fu con i Mamas And Papas), suonando con chiunque nel corso degli anni, tra jazz-rock e fusion, che sono rimaste le sue passioni, passando per i Pink Floyd di The Wall, e moltissimi artisti diciamo sul lato “morbido” della musica, totalizzando centinaia di collaborazioni, uno dei chitarristi più richiesti. Già a metà anni ‘70 ha iniziato una carriera solista che lo ha portato a registrare più di 30 dischi, oltre a 3 album con i Fourplay, sempre con il suo stile ricercato, dove confluiscono le molteplici influenze maturate negli anni, si diceva del jazz, ma anche funky, fusion e il cosiddetto smooth jazz, mellifluo e morbido, che ha molti estimatori, ma non mi fa impazzire.
Tecnica prodigiosa, grande gusto, ma un suono spesso un po’ troppo turgido e leccato, gli ultimi album registrati per la Concord nella prima parte della scorsa decade erano una sorta di ripasso delle puntate precedenti e album ricchi di ospiti. Dal 2015 non pubblicava più nulla, a causa di varie vicissitudini, prima l’incendio che ha distrutto la sua casa di Malibu, incluso il suo studio casalingo e quasi tutte le sue chitarre e amplificatori, poi, una settimana dopo l’incendio, un intervento alla valvola aortica, ma lentamente ha ripreso i fili della sua carriera, preparando il materiale per il nuovo album, fino allo scoppio del coronavirus: a questo punto ha deciso di fare qualcosa mai fatto prima, un album registrato in solitaria, solo lui, sette chitarre (va bene la sobrietà, ma evidentemente era il minimo sindacale), un’interfaccia di computer, e nel suo piccolo nuovo studio ha iniziato questo Dreamcatcher. Un po’ come è stato per l’ultimo Al DiMeola, dove però veniva rivisitata la musica dei Beatles https://discoclub.myblog.it/2020/03/15/anche-fatti-bene-da-al-di-meola-i-beatles-sono-pur-sempre-i-beatles-across-the-universe/ , Ritenour ha inciso tutte le parti, con varie stratificazioni di chitarre, andando a scovare vari generi musicali, molti raramente o mai esplorati nei suoi dischi passati, in un disco completamente strumentale.
Si parte con la title track, un brano dal profumo classicheggiante, con la nylon guitar accarezzata dolcemente da Lee, che fa sfoggio di grande tecnica all’acustica, comunque circondata da sovraincisioni varie che la rendono affascinante, Charleston, dedicata alla città del South Carolina, al centro di disordini e tensioni razziali per il Black Lives Matter, che Lee sostiene, anche se vuole ricordare pure la città com’era in occasione di altre sue visite nel passato, accenti più jazz, tocchi sudisti, per un brano suonato all’elettrica, raffinato ma anche più carnale. The Lighthouse fa riferimento ad un vecchio locale dove nella sua gioventù andava a vedere Wes Montgomery, una delle sue massime influenze, al quale ha dedicato un intero album in passato, brano dalla struttura più complessa, con l’uso di alcune percussioni e incentrato sulla Les Paul del nostro, che poi rivisita con Morning Glory Jam, un brano del 1977 del suo periodo fusion, qui più intimo e raccolto, per quanto sempre intricato. Starlight è addirittura un brano folk, solenne e sereno, nel solco dei grandi chitarristi acustici, Abbott Kinney è un famoso boulevard di Venice, California, che durante il Covid ha dovuto chiudere, nelle vicinanze del quale Lee ha all’improvviso udito il rombo di una elettrica volume 10, che ora nel disco riproduce con voluttà rock e anche sferzate di slide, che si stemperano nel finale.
Couldn’t Help Myself è una sorta di festival del multitracking, chitarre acustiche, elettriche, basso, percussioni, un sound tra il Pat Metheny Group e certo rock progressivo raffinato https://www.youtube.com/watch?v=s4MAJPR2ubo, molto piacevole anche la soffusa For DG, dedicata all’amico Dave Grusin, melodiosa e sinuosa, con Via Verde, un brano acustico che ricorda certe sonorità della Windham Hill, e anche Low Slow indugia su timbriche più tenui e malinconiche, con la danzante Storyteller che ha un retrogusto brasiliano e la conclusiva 2020, presentata come una sinfonia in tre parti, brano dal deciso mood jazzato che mette il suggello ad un ottimo disco, consigliato agli appassionati di chitarra.
Bruno Conti