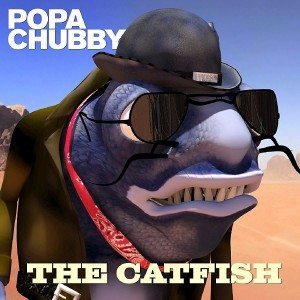The Everly Brothers – Down In The Bottom: The Country Rock Sessions 1966-1968 – RPM/Cherry Red 3CD
Nel 1966 la popolarità degli Everly Brothers era in deciso calo, specie se rapportata ai fasti di fine anni cinquanta/primi sessanta, in cui i fratelli Don e Phil Everly erano stati giustamente indicati come uno degli acts più influenti della loro epoca (per dirne una, senza di loro forse Paul Simon avrebbe intapreso lo stesso la carriera di cantautore, ma probabilmente senza Art Garfunkel): infatti i due non portavano un singolo nella Top 40 da ben tre anni, e addirittura da cinque se si passava agli LP. Il loro ultimo disco, Two Yanks In England, era praticamente un album degli Hollies (che erano autori di gran parte delle canzoni e comparivano anche come backing band) cantato dagli Everly, e non ebbe successo come i precedenti: i nostri pensarono quindi di operare qualche piccolo cambiamento nel loro suono, ed i tre dischi interessati da tale rinnovamento (The Hit Sound Of The Everly Brothers, The Everly Brothers Sing e Roots) sono riuniti in questo triplo CD in digipak targato Cherry Red ed intitolato Down In The Bottom: The Country Rock Sessions 1966-1968, tutti quanti con una buona dose di bonus tracks in parte inedite.
In effetti il sottotitolo di questa ristampa è leggermente inesatto, in quanto solo Roots si può definire propriamente country-rock: diciamo che i due lavori precedenti, che pur presentano qualche sonorità countreggiante anche se mescolata alle consuete pop songs del duo e perfino a qualche accenno di psichdelia, sono da considerare come una graduale transizione verso Roots, che uscendo nel 1968 tenterà di inserirsi nel filone country-rock allora in voga e che aveva Byrds e Flying Burrito Brothers come esponenti di punta.
The Sound Of (1967, ma le sessions risalgono al ’66, da qui dunque il titolo dell’antologia) è formato da cover di brani più o meno noti, con la produzione di Dick Glasser e l’ausilio di diversi membri della famosa Wrecking Crew, tra cui Larry Knechtel, Hal Blaine, Terry Slater e Glen Campbell, già noto quest’ultimo come artista in proprio. L’album non vendette molto, ma vide i nostri proporre arrangiamenti raffinati e con le solite splendide armonie vocali di classici del rock’n’roll (Blueberry Hill, riletta in veste countreggiante, Oh, Boy! e Good Golly, Miss Molly), del country (I’m Movin’ On, Sea Of Heartbreak, che sembra scritta su misura per loro, e (I’d Be A) Legend In My Time), due brani associati a Ray Charles (Let’s Go Get Stoned e Sticks And Stones), un po’ di “British Invasion” (Trains And Boats And Plains, di Burt Bacharach ma portata al successo da Billy J. Kramer & The Dakotas, e The House Of The Rising Sun, incisa tenendo presente l’arrangiamento degli Animals ed indicando addirittura Alan Price come autore del pezzo). Poi ci sono brani scritti da autori esterni apposta per Don & Phil, come la beatlesiana Devil’s Child e la melodiosa She Never Smiles Anymore, opera di un giovane ed ancora sconosciuto Jimmy Webb. Tra le cinque bonus tracks del primo CD spiccano Even If I Hold It In My Hand, unico pezzo a firma Don Everly, un’altra canzone scritta da Webb (When Eddie Comes Home) ed il demo di Bowling Green, che sarà il brano di punta del disco successivo.
Proprio Bowling Green, uno splendido e scintillante folk-rock, apre il secondo dischetto nonché l’album Sing (1967), prodotto ancora da Glasser e con più o meno gli stessi musicisti del precedente (ma con in più il grande James Burton, all’epoca chitarrista di Elvis), ed un approccio più spostato verso il pop psichedelico, termine da prendere comunque con le molle in quanto stiamo pur sempre parlando degli Everly. Quasi metà dei pezzi sono scritti dal bassista Slater, i migliori dei quali sono la già citata Bowling Green, A Voice Within, il cui sound è influenzato dalle band britanniche, e le psichedeliche all’acqua di rose Talking To The Flowers e Mary Jane; ci sono poi un paio di originali di Don (l’orecchiabile I Don’t Want To Love You, scritta insieme a Phil, e l’eterea ballata It’s All Over, già incisa in passato dai due), un pezzo roccato e coinvolgente (Deliver Me, di Danny Moore) ed il rifacimento di Somebody Help Me, grande successo dello Spencer David Group di Steve Winwood, pubblicata l’anno prima su Two Yanks In England. C’è anche la scelta bizzarra di includere una versione del superclassico dei Procol Harum A Whiter Shade Of Pale (non adattissima ai nostri), mentre è invece ottima Mercy, Mercy, Mercy, scritta dal non ancora leader dei Weather Report Joe Zawinul per il Cannonball Adderley Quintet. Le bonus tracks qui sono ben nove, tra cui sei sono brani usciti solo su singolo: da non perdere la bella rilettura della classica Love Of The Common People e la squisita Nothing But The Best di Rick Kemp.
E veniamo a Roots (1968), il migliore dei tre album presi in esame e quello che rappresenta la vera svolta nel suono dei fratelli, un disco che è anche una delle prime produzioni di un giovane Lenny Waronker, che nei seventies diventerà uno dei nomi più richiesti in cabina di regia, e che vede ancora i membri della Wrecking Crew con l’aggiunta delle tastiere di Van Dyke Parks. L’album vede dunque Don & Phil perfettamente calati nei panni di novelli cantanti country-rock, con cristalline versioni di classici come Mama Tried e Sing Me Back Home (le due canzoni più celebri di Merle Haggard), Less Of Me di Glen Campbell, T For Texas di Jimmie Rodgers e You Done Me Wrong di George Jones; un paio di pezzi sono scritti da Ron Elliott, leader dei Beau Brummels e collaboratore del disco (le folkeggianti Ventura Boulevard e Turn Around), mentre l’unico brano originale dei due fratelli, I Wonder If I Care As Much, è quasi psichedelico e non imperdibile (c’è anche una canzone, Living Too Close To The Ground, scritta dall’attrice Venetia Stevenson, all’epoca moglie di Don). Completano il quadro una pimpante rilettura del traditional Shady Grove in puro stile bluegrass ed un inedito del giovane Randy Newman, Illinois, brano già con l’impronta futura del pianista e cantante di Los Angeles. Sette le tracce bonus tratte dalle sessions, la maggior parte delle quali sono canzoni originali di Phil & Don (Omaha è la migliore), completata da due preziose cover di Mr. Soul (Neil Young) e In The Good Old Days (Dolly Parton) e da una bluesata e grintosa Down In The Bottom di Willie Dixon.
Con Roots, nonostante il perdurante insuccesso del disco, gli Everly Brothers sembravano lanciati verso una nuova carriera all’insegna del country-rock, e nessuno all’epoca poteva immaginare che come duo (quandi escluse le peraltro poche fatiche soliste) avrebbero pubblicato soltanto più cinque album durante il resto della carriera, due negli anni settanta e tre negli ottanta: un motivo in più per riscoprire le registrazioni incluse in questo triplo CD.
Marco Verdi