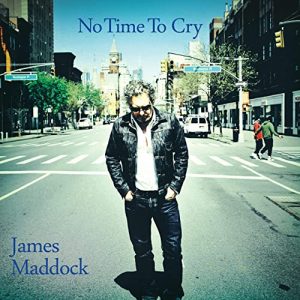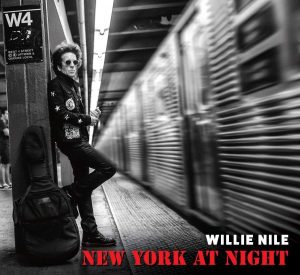The Weight Band – Live Is A Carnival – ContinentalRecord Services CD
The Band, uno dei gruppi più leggendari della storia del rock, fa parte di quegli acts per così dire “irriformabili”: Richard Manuel, Rick Danko e Levon Helm non sono più tra noi ormai da diversi anni, Robbie Roberston non ne ha mai voluto sapere di riprendere in mano il vecchio moniker e Garth Hudson, vero leader silenzioso del gruppo e musicista dalla preparazione stellare, è sempre stato nell’ombra e non ha certo voglia di diventare un band leader a 83 anni. Il testimone del glorioso gruppo canadese (anche se Helm era americano) da qualche anno è stato preso in mano con una certa legittimità da Jim Weider, chitarrista di Woodstock che negli anni novanta era entrato a far parte della reunion della Band ad opera di Helm, Danko e Hudson prendendo il posto di Robertson (non dal punto di vista compositivo però) negli ottimi Jericho e Jubilation e nel meno riuscito High On The Hog. In seguito Weider si era unito alla Levon Helm Band fino alla scomparsa del leader avvenuta nel 2012, ed in anni recenti si è ripresentato insieme ad alcuni musicisti che avevano suonato sugli album citati poc’anzi per formare The Weight Band, che vuole apparire come un omaggio al mitico quintetto di Music From Big Pink sin dal nome che cita appunto il loro brano più popolare.
Anche The Weight Band sono in cinque: oltre a Weider abbiamo Brian Mitchell (tastiere, fisarmonica e voce, anch’egli ex membro della Levon Helm Band), Matt Zeiner (pure lui tastiere e voce), Albert Rogers (basso e voce) e Michael Bram (batteria). Come vedete anche la loro conformazione rimanda alla Band, con un chitarrista, due tastieristi e la sezione ritmica, ma sbagliate se pensate ad un gruppo solamente derivativo o peggio ancora ad una cover band: i nostri hanno tutti un pedigree musicale notevole e sanno comporre brani più che validi, cosa tra l’altro riscontrabile sul loro unico album di studio pubblicato finora, il riuscito World Gone Mad del 2018. Ora i nostri pubblicano un lavoro ancora più stimolante, un album dal vivo che fin dal titolo, Live Is A Carnival, è un chiaro tributo alla Band: Weider e soci dimostrano con questo CD di essere un gruppo coi controfiocchi e dal suono molto caldo e ricco di feeling, e di possedere una certa personalità, ma nasconderei la verità se non affermassi che la parte più interessante del concerto è costituita dalle loro versioni dei classici dell’ex gruppo guidato da Robertson, la cui resa non è ovviamente superiore agli originali ma neppure così distante. Registrato alla Brooklyn Bowl di New York il 26 gennaio del 2019, Live Is A Carnival ci fa dunque tornare per circa settanta minuti ad assaporare le atmosfere di un tempo, e se chiudiamo gli occhi quasi non ci accorgiamo che a suonare non sono “quelli là” (voci a parte): un gran bel dischetto quindi, con una setlist che si commenta da sola ed un profluvio di momenti strumentali in cui chitarra, organo e pianoforte si prendono il centro della scena con una serie di assoli sopraffini.
Ci sono quattro pezzi originali scritti da Weider, a partire dalla pimpante World Gone Mad, un folk-roots elettrificato e godibile tra antico e moderno, cantato a più voci, per poi proseguire con Heat Of The Moment, una rock song vigorosa ma non particolarmente originale, l’elettrica e cadenzata Bid Legged Sadie, con la chitarra sugli scudi, e la roccata e convincente Common Man, un rock-blues scritto assieme a Helm che è anche la migliore delle quattro. Nel concerto trovano spazio anche tre cover “esterne” alla Band, due delle quali sono comunque legate allo storico gruppo: si tratta dell’opening track Don’t Do It (di Marvin Gaye e pubblicata da Robertson e compagni sul live Rock Of Ages), qui in una strepitosa e funkeggiante versione ricca di groove e trascinante al punto giusto, ed una superba Atlantic City di Bruce Springsteen (era uno dei brani cardine di Jericho), con il mandolino di Weider e la fisa di Mitchell a guidare le danze; la terza cover è una bella e coinvolgente rilettura in puro stile southern-errebi del classico Deal di Jerry Garcia, sempre un bel sentire.
Dulcis in fundo, ecco i brani targati The Band: dopo la relativamente meno nota To Kingdom Come, un pezzo decisamente sanguigno dal sapore sudista, abbiamo una serie di capolavori suonati con grande classe ed immenso rispetto per gli originali, con titoli come Stage Fright, Rag Mama Rag, Ophelia, la straordinaria The Night They Drove Old Dixie Down ed il gran finale con una Life Is A Carnival di otto minuti e mezzo e l’immancabile The Weight di altri sette minuti. Forse l’unica mancanza di rilievo è almeno un brano di Bob Dylan, ma alla fine Live Is A Carnival si rivela un disco dal vivo riuscito e coinvolgente, che ha il merito non indifferente di farci rivivere seppur in minima parte la fantastica epopea di The Band.
Marco Verdi