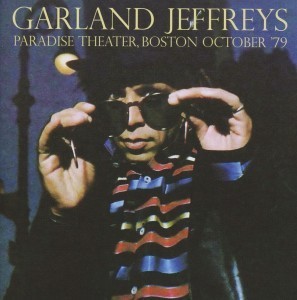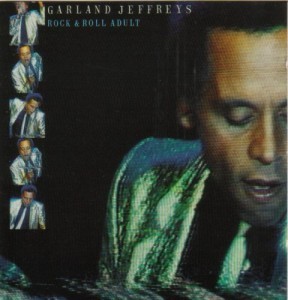Chris Forsyth & The Solar Motel Band – The Rarity Of Experience – 2 CD No Quarter Records
Chris Forsyth è un chitarrista americano, in azione già dagli anni ’90, quindi non un pivellino: uno che agli inizi della sua carriera si muoveva in territori alternative folk, drone music, improvvisazione allo stato puro, anche in ambito quasi avanguardistico e post-rock (pensate a cose tipo Glenn Branca, LaMonte Young e altri, che comunque un aggancio sia pure flebile con rock e blues ce l’hanno), collaborazioni con Steve Gunn e Meg Baird, poi ha “scoperto” Grateful Dead e Quicksilver, Television, Richard Thompson e un certo approccio più rock, fondando la Solar Motel Band, un quartetto che esordisce con un Live nel 2013, poi pubblica Intensity Ghost a fine 2014 https://www.youtube.com/watch?v=YEZJmN31CZs ed ora, con un nuovo chitarrista in formazione, Nick Millevoi, approda a questo doppio The Rarity Of Experience, dove vengono confermati il bassista Peter Kerlin (anche alla chitarra quando serve) e l’ottimo batterista Steven Urgo, oltre alle tastiere di Shawn Edward Hansen. Diciamo che si tratta di uno dei soliti doppi CD “brevi”, intorno ai 72 minuti di durata, probabilmente per aderire alla mistica dell’album doppio, un classico del rock, 10 brani in tutto, di cui tre oltre i dieci minuti di durata, prettamente strumentali, con le parti cantate che se arrivano ai due minuti in tutto l’album è già tanto.
Per il resto chitarre, chitarre, e ancora chitarre, ma di quelle da gustare a fondo, quasi sempre in modalità improvvisativa o di ricerca sonora, in quello stile che fu caro appunto alle band psych-rock della fine anni ’60, ma anche a band come i Television, di cui il gruppo esegue dal vivo una poderosa Little Johnny Jewel (con citazione iniziale di Hendrix), o a solisti come Richard Thompson, del quale i Solar Motel ci regalano una fedele cover di Calvary Cross, come traccia conclusiva di questo The Rarity Of Experience. E chi legge questo Blog sa quanto ami il chitarrista inglese di cui considero quel brano uno delle punte di diamante della sua scintillante opera, soprattutto in ambito solistico, con un assolo tra i più lancinanti ed intensi mai regalati alla storia del rock https://www.youtube.com/watch?v=R8i61cG8Glk . Forsyth e Millevoi fanno del loro meglio per riprodurre quella memorabile cavalcata chitarristica, anche se la prima parte, specie all’inizio, quando il testo del brano viene più che altro recitato, è un piccolo passo falso poi riscattato dalla feroce veemenza della parte strumentale. Veemenza solista che viene subito a galla nel disco, fin dalle prime note di Anthem I, un pezzo dove il sound dei Television di Verlaine e Lloyd sembra la stella polare delle twin guitars di Forsyth e soci, che poi si espandono ed elaborano il loro approccio nella gloriosa Anthem II, dove il mood del brano pesca anche nel bacino della psichedelia pura californiana dei Quicksliver di Cipollina e Duncan, dove la chitarra lancinante e acida di Chris Forsyth, ben sostenuta dal vorticoso drumming di Urgo, ci riporta in territori sonori che credevamo dimenticati da anni. E questo, a ben vedere, è rock, di quello di grande qualità, pure se, non sempre di facile fruibilità, ma quando funziona, come in questi brani, e nelle due parti di The Rarity Of Experience, di cui la seconda parte, con il suo riff ciclico, è una sorta di Marquee Moon per i nostri giorni, è una vera gioia per i padiglioni auricolari.
Non tutto è “semplice” e facilmente fruibile, The First Ten Minutes Of Cocksucker Blues, una sorta di colonna sonora per la famosa pellicola “vietata” degli Stones https://www.youtube.com/watch?v=9DDHj-TUOVA , già nel loro repertorio Live, è, per dirla alla Sacchi o Trapattoni di Mai Dire Gol, tra l’ostico e l’agnostico, pura improvvisazione jazz dove il sax e la tromba di Daniel Carter aggiunti alle chitarre, sfidano la pazienza dell’ascoltatore, anche se in questo ambito ci sta. Però in brani più complessi come come la lunga High Castle Rock si percepiscono anche echi di Grateful Dead e dei primi Pink Floyd, sempre movimentati dallo stile percussivo quasi alla Keith Moon di Urgo, che lancia nella stratosfera le lunghe improvvisazioni dei due chitarristi, anche all’unisono a tratti, con le tastiere a creare un tappeto soffice di coloritura sonora. Harmonius Dance è un’oasi di serena e tranquilla musica quasi pastorale, sempre a cavallo tra scorribande sonore e segmenti che possono ricordare il miglior rock progressivo, quello più ricercato, etereo e sognante, dove le chitarre reiterano continuamente gli stessi giri d’accordi in una sequenza quasi circolare che continua a rincorrersi. Boston Street Lullaby potrebbe addirittura ricordare il sadcore rarefatto di band come i Red House Painters o i Sun Kil Moon di Mark Kozelek, in una sorta di dream pop minimale. Prima di arrivare alla conclusiva The Calvary Cross incontriamo il lento e solenne crescendo di Old Phase una ulteriore occasione per incontrare di nuovo le deliziose traiettorie incrociate delle due chitarre soliste, veramente splendide nelle loro sonorità sognanti ed aggressive, a seconda dei momenti. Senza dimenticare che il tutto viene offerto con indubbia perizia tecnica allo strumento e un gusto particolare per la ricerca di sonorità spesso raffinate ed eleganti.
Bello ed affascinante, da sentire!
Bruno Conti