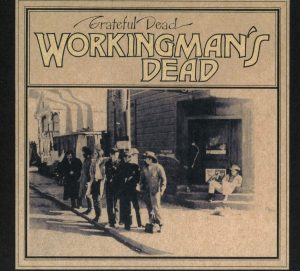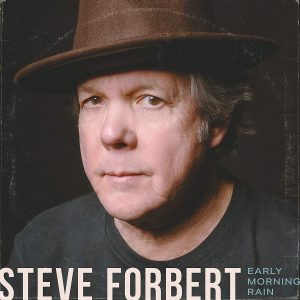Jerry Garcia/Merl Saunders – Garcia Live Volume 15 – ATO 2CD
A pochi mesi dal bellissimo quattordicesimo volume acustico, riprende la fortunata serie Garcia Live dedicata appunto ai migliori concerti solisti del grande Jerry Garcia: l’episodio numero 15 vede di nuovo il nostro nella più abituale dimensione elettrica, anche se in uno show abbastanza unico rispetto ai precedenti. Intanto stiamo parlando di una delle prime serate in assoluto in cui Jerry si è esibito lontano dai Grateful Dead, il 21 maggio del 1971 al Keystone Korner di San Francisco, e poi il nostro divide il cartellone con il bravissimo tastierista/organista Merl Saunders, con il quale collaborerà parecchio nella prima metà degli anni settanta (famosi i loro concerti del ’73 al Keystone, che non è lo stesso locale del doppio CD di cui vi parlo oggi ma una location più grande aperta dallo stesso proprietario a poca distanza). Il fatto che questa uscita non sia accreditata solo a Garcia ha perfettamente senso, in quanto Saunders durante lo show assume spesso il ruolo di co-protagonista accanto a Jerry, deliziando i presenti con una performance assolutamente strepitosa in cui rock, jazz, blues e psichedelia si fondono alla grande, ed in cui la tendenza alla jam tipica del barbuto chitarrista dei Dead viene amplificata all’ennesima potenza.
Infatti i concerti solisti di Garcia che abbiamo ascoltato negli anni sono sempre stati basati sulle canzoni (spesso più cover che originali), certo dilatate oltremodo nella lunghezza ma sempre mantenendo la struttura di base, mentre qui accanto a brani più canonici troviamo delle vere e proprie jam sessions in cui i nostri (coadiuvati solamente da Bill Vitt alla batteria e, in cinque pezzi, da Martin Fierro al sax) danno veramente il meglio di loro stessi. Dieci brani per due ore totali di musica (e questo la dice lunga sulla durata delle singole canzoni), manca stranamente solo Deal che era stata suonata come unico bis. Lo show parte alla grande con Man-Child, favolosa jam di 17 minuti in cui Jerry e Merl si destreggiano da veri maestri con i rispettivi strumenti, con Saunders forse addirittura un gradino più su del collega: il brano è un piacere per le orecchie, con la sua andatura insinuante e fluida che ricorda certe cose di Santana ed un finale quasi free jazz https://www.youtube.com/watch?v=UC_S1D6tnKs . Ma la serata è anche all’insegna del blues, dal momento che il secondo pezzo è una sinuosa rilettura di One Kind Favor di Blind Lemon Jefferson, con Jerry che mostra di essere anche in forma vocale più che buona (quella chitarristica non ve lo dico neanche) e Merl che ricama con sonorità clade, ed il terzo è una strepitosa I Know It’s A Sin di Jerry Reed, lenta, soffusa e di gran classe: Garcia non è mai stato un bluesman ma con quella chitarra poteva suonare qualsiasi cosa senza perdere un grammo del suo feeling.
I Was Made To Love Her è un brano di Stevie Wonder, pretesto per un’altra straordinaria e vibrante jam di dieci minuti in cui anche Fierro fa la sua parte (sembra di sentire i primi Chicago); a proposito di improvvisazioni, che dire di Keystone Korner Jam? Più di sedici minuti tra rock, jazz e psichedelia, musica libera, creativa, di grande forza ma fruibile al tempo stesso, con Jerry che lascia a Merl i suoi spazi confermando che in questo concerto è meno solista e più “uomo-squadra” https://www.youtube.com/watch?v=G4YMdXfhVJw . Il primo dischetto termina con un’ottima versione di The Night They Drove Old Dixie Down di The Band, che nel 1971 è vecchia di due soli anni ma è già un classico (ed il nostro la manterrà in repertorio fino agli ultimi spettacoli con la Jerry Garcia Band negli anni novanta) https://www.youtube.com/watch?v=bMx4oRFMDiQ . Il secondo CD inizia con Save Mother Earth, altra superba prova di puro jazz-rock che di minuti ne dura 25 (ma la noia non affiora mai), con Jerry e Merl che riempiono alla grande gli spazi che uno lascia all’altro ed ai quali si aggiunge il contributo prezioso e quasi indispensabile di Fierro https://www.youtube.com/watch?v=2JqGY7os8q8 . Ed il bello è che il brano è completamente diverso da qualsiasi cosa proposta in carriera da Garcia, sia prima del ’71 che dopo. Ancora blues con una solida That’s All Right di Jimmy Rogers, con Jerry e Fierro in cattedra, seguita da una rarissima The Wall Song di David Crosby (proposta addirittura due anni prima dell’originale, che uscirà nel 1973 sul primo album di David in coppia con Graham Nash) https://www.youtube.com/watch?v=qJkZJH-Hn4E , in assoluto la più “deadiana” del lotto; chiusura con una scoppiettante Mystery Train di Elvis Presley, perfetta per chiudere la serata in quanto anch’essa dotata di una struttura decisamente blues.
Uno dei migliori episodi della serie.
Marco Verdi