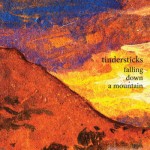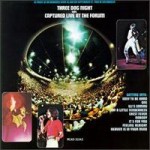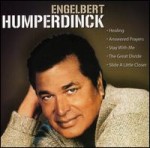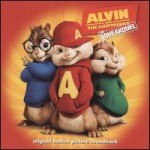Sade – Soldier Of Love – Epic/SonyBmg
Dieci anni di attesa (lo so, lo so, otto se contiamo anche l’album dal vivo) ed ecco il nuovo CD del gruppo Sade, loro si definiscono così, Stuart Matthewman, Paul Denman, Andrew Hale e Sade Adu, i soliti collaboratori storici sparsi per il mondo si sono riuniti negli studi Real World di Peter Gabriel (magari avrebbero potuto dare una ascoltatina negli studi limitrofi!) ed il risultato è questo Soldier Of Love che terrete tra le vostri mani, se volete, il giorno 5 febbraio in Italia e l’8 nel resto del mondo.
Mah?!?
Dieci brani molto uniformi nella loro vellutata sequenza, e questa è stata sempre caratteristica comune anche degli album precedenti, il ritmo è quasi sempre simile, creato con batterie elettroniche e programmazioni varie che sono le vere protagoniste del disco, aldilà della voce della protagonista che rimane sempre uno strumento sensuale, immutata dagli anni (sono 51 anche per lei).
Il risultato finale, se devo essere franco, varia tra il noioso e l’irritante (con le dovute eccezioni, poche): un sound spettrale incentrato su questi ritmi artificiali creati dalla programmazione della batteria, con pochissime variazioni, che a lungo andare diventa tedioso e irritante, mi ripeto. Non mi creerò molti amici ma mi sembra che la formula che inizialmente funzionava, soprattutto nei primi albumi (Promise e Diamond Life rimangono dei signori album nel loro genere), comincia a mostrare la corda: qualche eccezione c’è, la conclusiva The Safest Place, dalle atmosfere rarefatte e sospese, senza batterie elettroniche a rompere i ministri, chitarre acustiche ed elettriche appena accennate, archi veri o virtuali che siano (odo un cello?), la voce raddoppiata di Sade, pochi elementi ma ben delineati, una direzione “acustica” da perseguire. Anche In Another Time con il suo easy jazz pianistico, supremamente cool, una elettrica con un leggero vibrato, un sax, una chitarra acustica e un violino che si inseguono nei loro assoli intrecciati al sax che ritorna e Sade suadente al meglio delle sua capacità.
Skin sembra Smooth Operator 25 anni dopo ma senza la sorpresa della novità e con quella batteria elettronica veramente irritante, Babyfather, dai toni leggermente reggae (secondo me il programmatore aveva schiacciato il mode Why can’t We live together di Timmy Thomas ma il computer è andato in tilt), con i suoi coretti con bimbi raggiunge dei momenti veramente imbarazzanti, volendo essere tenera ma risultando scontatissima. The Moon and the sky e la title-track dai toni vagamente marziali si appiattiscono su queste sonorità da supermarket radiofonici, risultando poco memorizzabili e memorabili.
Cosa rimane? Morning Bird con la sua delicata introduzione pianistica e percussioni non invasive si inserisce nell’elenco dei brani riusciti che ti comunicano qualcosa e sono tipici della produzione più riuscita di Sade, idem per Long Hard Road, sostituite una chitarra acustica al piano, una sezione di archi a sottolineare la voce della cantante anglo-nigeriana e voilà i giochi son fatti. Non male anche Be that easy, un bel contrabbasso, una melodia molto dolce, un arrangiamento vocale curato nei minimi particolari e il brano scorre piacevole (d’altronde il termine smooth sta per vellutato, liscio, scorrevole, sinuoso).
Quindi, in definitiva è brutto quesco disco? No! Ma non è neanche bello. fate vobis.
Bruno Conti