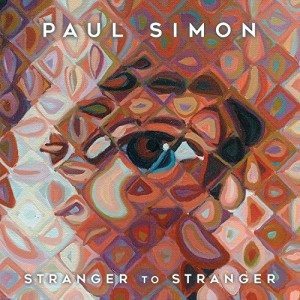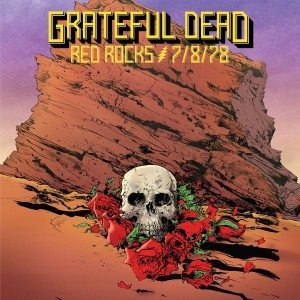Paul Simon – Stranger To Stranger – Concord/Universal
Quell’occhio, benevolo ma inquietante, che ti scruta dalla copertina di questo nuovo Stranger To Stranger è quello di un signore di 75 anni (a metà ottobre) che, a differenza per esempio di Dylan, ha preferito rivolgere il suo sguardo verso il “futuro”, con un album costruito su sonorità “moderne”, forse con più grooves e ritmi rispetto alle melodie del passato, ma sempre ricco di fascino e complessi intrecci sonori. Che poi ci riesca completamente magari è soggetto ai diversi punti di vista degli ascoltatori, ma sicuramente ci prova. Questo disco in fondo è “solo” il tredicesimo album di studio in una carriera solista iniziata nel lontano 1972 (e contando anche il Paul Simon Songbook, pre-Simon & Gafrunkel, del 1965 e la colonna sonora di One Trick Pony): quindi non una carriera particolarmente ricca di prove discografiche, e in questo senso ogni nuovo CD di Paul Simon è un evento. Il precedente album So Beautiful Or So What era un buon disco, magari non un capolavoro (http://discoclub.myblog.it/2011/04/10/temp-d60b04cfdc8f0c74be0a93f5c8899c81/), e, a mio modesto parere, neppure questo Stranger To Stranger lo è, pur se superiore a quel disco e non così formidabile come lo sta dipingendo la parte della critica musicale mondiale che ne ha già parlato.
Nell’ambito della “modernità” dei suoni è sicuramente superiore a Surprise, il disco del 2006 registrato con Brian Eno, che non aveva retto alle aspettative della strana coppia, e come contenuti musicali a You’re The One, il disco del 2000 e al pasticciato musical Songs From The Capeman, quindi forse il miglior disco di Simon dai tempi di The Rhythms Of The Saints, ma comunque nettamente inferiore sia a quel disco, come ai capolavori Graceland e Hearts & Bones (quello che prediligo in assoluto). A proposito di modernità per l’occasione Simon rispolvera l’ottuagenario Roy Halee, il produttore ed ingegnere del suono dei suoi dischi migliori, non più avvezzo al suono di pro-tools ed altre diavolerie elettroniche (e Paul ha dovuto fargli da tramite verso le nuove tecnologie) ma che non sembra avere perso il tocco magico nel fondere nuovi suoni con il calore del suono analogico. Come al solito (da cui il titolo del post) Paul Simon non ha perso il vizio di sperimentare ardite e, in parte, riuscite aggregazioni di diverse sonorità: lo spirito folk e melodico della sua tradizione, la musica popolare di diversi paesi e continenti, dal folklore del Perù al flamenco della Spagna, passando per l’amata Africa, e anche i beat elettronici dell’italiano Clap! Clap (Digi D’Alessio, con la D, all’anagrafe Stefano Crisci da Firenze), oltre all’utilizzo di strumenti mutuati dalla musica contemporanea di Harry Partch e alla batteria di Jack De Johnette e la voce di Bobby McFerrin, da un ambito jazz. Ed ecco quindi apparire, nei vari brani, strumenti come il gopichand, la Hadjira, la trombadoo, il Big Bong Mbira, il chromelodeon, lo zoomoozophone, accanto a glockenspiel, celeste, marimba e flamenco dancing (prego?!?).
Ebbene sì, perché è il groove, l’afflato ritmico, quello che vince in questo Stranger To Stranger, ogni tanto la volontà di sperimentare nuovi suoni va a scapito della melodia, spesso in passato protagonista principale delle canzoni più belle di Paul Simon, e qui ce ne sono comunque alcune notevoli. Però, andando a stringere, due brani sono strumentali, The Clock, che è un breve sketch di un minuto per orologio, mbira e chitarra acustica e la delicata e deliziosa In The Garden Of Edie, dedicata alla moglie Edie Brickell, una sorta di ninna nanna pastorale sussurrata a bocca chiusa su uno strato di strumenti suonati dallo stesso Paul. Poi ci sono i tre brani dove appare l’elettronica di Clap! Clap!, molto presente ma non troppo invasiva, utilizzata con giudizio ed un certo gusto: nell’iniziale The Werewolf dove viene incorporata in un maelstrom di percussioni etniche, batterie elettroniche, fiati, organo, celeste, chitarra slide, battiti di mano, schiocchi di dita, inserti di fiati e mille altri particolari che la rendono affascinante e unica. Wristband, molto ritmata, viaggia sul suono del basso di Carlos Henriquez, strumento sempre molto amato da Paul, gli inserti vocali di Keith Montie, i fiati di Andy Snitzer e CJ Camerieri e di mille percussioni, per un altro intreccio non inconsueto nella musica del nostro, mentre la breve Street Angel è costruita solo sul groove di vari strumenti e percussioni, il campionamento delle voci del Golden Gate Quartet (che qualcuno ha inserito tra i musicisti del disco, peccato che quelli originali non esistono più da una cinquantina di anni), ma mi sembra più irrisolta rispetto alle due precedenti.
La title-track Stranger To Stranger è una canzone splendida, sognante ed avvolgente, un classico di Simon, con la chitarra intrigante del fedele Vincent Nguini, l’apporto ritmico del bravissimo batterista (e polistrumentista) Jim Oblon, il flauto di Alex Sopp e gli inserti dei fiati di C.J. Camerieri, oltre al flamenco dancing sinuoso di Nino De Los Reyes, affascinante. Particolare anche la breve In A Parade (uno dei quattro brani che faticano ad arrivare ai due minuti), solo la voce di Paul e le percussioni di Oblon, canzone che è “interpretata” dallo stesso carattere del brano Street Angel, ma non mi acchiappa particolarmente nella sua sequenza di liriche di cui non afferro a fondo il senso. Proof Of Life, viceversa, è un altro brano splendido, intenso ed incalzante, ma al tempo stesso soffuso, con un cantato tipico di Simon ed una ricca strumentazione, dove fiati, percussioni e tratti orchestrali si integrano perfettamente con le chitarre del nostro e di Vincent Nguini, questa volta alle acustiche. Molto bella anche Riverbank, una canzone vivace ed elettrica, caratterizzata da un doppio basso, acustico ed elettrico, dalla chitarra circolare dello stesso Simon e dal tocco magico della batteria di Jack De Johnette, che si unisce ai mille percussionisti impiegati nel disco, con viola e cello, oltre alla marimba, a dare tocchi di colore al sound. E splendida Cool Papa Bell, dove ci rituffiamo nei suoni e nei ritmi africani di Graceland, di nuovo con la chitarra elettrica di Vincent Nguini a menare le danze, il basso tuba di Marcus Rojas a fornire la quota New Orleans del sound e tutti gli strati di percussioni che avvolgono, questa volta senza soffocarla o nasconderla troppo, la melodia della canzone. Ottima anche la conclusiva, dolcissima Insomniac’s Lullaby, di nuovo una ninna nanna minimale, costruita intorno alla chitarra e alla voce di Paul Simon, circondate comunque da mille strumenti appena accennati e dalla voce di McFerrin, impegnati a dare profondità e spessore al suono.
Esiste anche una immancabile e costosa versione Deluxe (singola) che aggiunge altri cinque brani: Horace and Pete, l’unico inedito, Duncan ( Live) bellissima https://www.youtube.com/watch?v=IPjzRZCCAPA , Wristband ( Live), entrambi registrati nel febbraio del 2016 nella nota trasmissione televisiva A Prairie Home Companion, Guitar Piece 3 ( un altro breve brano strumentale), e New York is My Home con Dion, già apparso nell’omonimo disco del cantante newyorkese. Quindi, concludendo, un bel disco, a tratti ottimo, ma, almeno per il sottoscritto, non un capolavoro assoluto. Poi ce lo dirà il tempo, se rimarrà come questa canzone https://www.youtube.com/watch?v=T0tmgmBBm4E
Esce oggi 3 giugno.
Bruno Conti