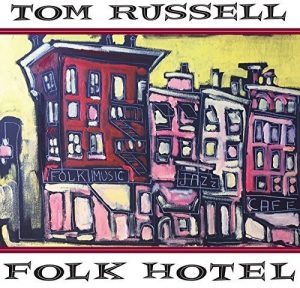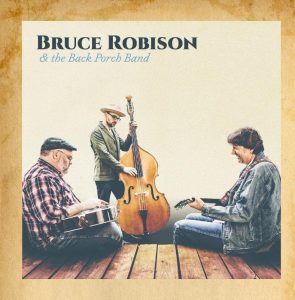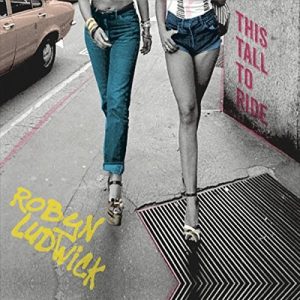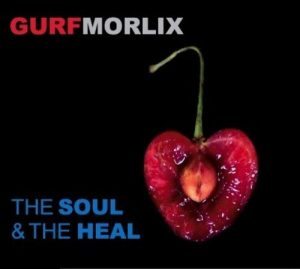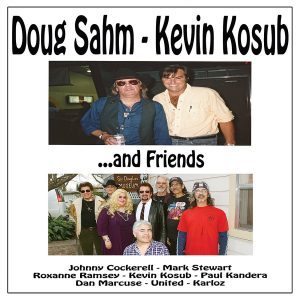Tom Russell – Folk Hotel – Frontera Records/Proper Deluxe Edition
Tom Russell, nella sua lunga carriera, ha sfornato diversi “concept album” di sicuro interesse, uno dedicato alle “western songs” Indians Cowboys Horses Dogs (04), e soprattutto la bellissima, e in parte innovativa, “trilogia” iniziata con The Man From God Knows Where (una saga familiare che narra la storia della famiglia Russell (99), proseguita con Hotwalker (un viaggio a ritroso nella memoria e nella storia dell’America (05), e conclusa (per ora) con l’affascinante The Rose Of Roscrae (una saga popolare che parte dall’Irlanda e raggiunge il Canada (15) http://discoclub.myblog.it/2015/04/29/epica-saga-del-west-lunga-quarantanni-tom-russell-the-rose-of-roscrae-ballad-of-the-west/ . Alcuni puntualmente recensiti su queste pagine: fino ora ad arrivare a questo nuovo lavoro Folk Hotel, un intrigante album, ricco di argomenti su personaggi e storie della provincia americana, raccontate al Chelsea Hotel di New York (raffigurato sulla cover del disco, dipinta dallo stesso Russell), tanto caro al grandissimo Leonard Cohen (di cui sentiamo la mancanza), e ad altri artisti di quel periodo. Folk Hotel come consuetudine è stato registrato ad Austin in Texas presso lo studio Congress House, e il buon Tom (che suona anche parte degli strumenti), è aiutato dalla presenza di illustri musicisti della scena “roots” americana, come il mitico e amico fisarmonicista Joel Guzman (Joe Ely e Los Lobos fra i tanti suoi “clienti”), Mark Hallman alle percussioni e bouzouki, Redd Volkaert alle chitarre, Augie Meyers al pianoforte e voce, Hansruedi Jordi alla tromba, e come graditi ospiti i nostri Max De Bernardi e Veronica Sbergia rispettivamente alla chitarra e washboard e armonie vocali, nonché con Joe Ely e la brava Eliza Gilkyson a duettare con lui, il tutto prodotto dallo stesso Russell con Mark Hallman.
La canzone d’apertura Up In The Old Hotel (si riferisce al famoso libro di Joseph Mitchell) è una dolce ballata con l’intro della tromba di Jordi e dove si sente subito l’impronta di Guzman, per poi passare subito alle atmosfere “messicane” di una spumeggiante Leaving El Paso, cantata in duetto con Eliza Gilkyson, a seguire le trame acustiche di una accorata e soave I’ll Never Leave These Old Horses (dedicata al leggendario Ian Tyson), e poi ancora un duetto con la Gilkyson nell’elegia musicale The Sparrow Of Swansea (scritta con Katy Moffatt e dedicata al poeta inglese Dylan Thomas), con una bella melodia che ricorda vagamente Streets Of London di Ralph McTell. Le narrazioni “antiche” di Tom continuano con l’intro recitativo di All On A Belfast Morning (da una poesia del poeta di Belfast James Cousins), a cui fanno seguito il moderno bluegrass” di una “agreste” Rise Again, Handsome Johnny, dove fa una bella figura il duo italiano Max De Bernardi e Veronica Sbergia. Ci inchiniamo davanti alla bellezza di Harlan Clancy, dettata dalle note del pianoforte di Augie Meyers e dell’armonica di Tom, mentre The Last Time I Saw Hank è la classica ballata texana, che tanti presunti nuovi “fenomeni” probabilmente non saranno mai in grado di scrivere. Con The Light Beyond The Coyote Fence e The Dram House Down In Gutter Lane, Russell propone la parte più acustica del lavoro (brani perfetti da suonare sotto le stelle del Texas), a cui fa seguito il secondo recitativo di un’altra poesia totale come The Day They Dredged The Liftey / The Banks Of Montauk / The Road To Santa Fe-O, per poi volare col cuore in Danimarca per una struggente e triste The Rooftops Of Copenhagen (dedicata al navigatore danese Ove Joensen).
L’edizione deluxe è ampliata da una riscrittura di Just Like Tom Thumb’s Blues (del premio Nobel Bob Dylan *NDB Nella stessa pagina del Blog oggi trovate anche l’anticipazione del nuovo cofanetto di Bob, il vol. 13 delle Bootleg Series Trouble No More, un fil rouge perfetto), che Tom canta in duetto con Joe Ely, accompagnati entrambi dalla magica fisarmonica di Guzman, e dal blues acustico di Scars On His Ankles, un commovente incontro immaginario tra lo scrittore Grover Lewis e il grande cantante e chitarrista blues Lightnin’ Hopkins, due canzoni piuttosto lunghe, una di sei e una di nove minuti, quindi non dei riempitivi, anzi. Come nei dischi citati inizialmente, questo ultimo Folk Hotel come sempre è un gesto di grande affetto verso storie e personaggi che Tom Russell (romanziere, criminologo, oltre che artista e cantautore) ha certamente amato, dando vita a questa bella raccolta di canzoni, che ci confermano un cantautore ancora in piena forma (e anche prolifico visto il recente omaggio con Play One More: The Songs Of Ian & Sylvia http://discoclub.myblog.it/2017/05/29/un-sentito-omaggio-da-parte-di-un-grande-musicista-ad-un-grande-duo-tom-russell-play-one-more-the-songs-of-ian-sylvia/ ), ed in grado di emozionare con ballate dirette che hanno la forza e la capacità di raccontare la sua America, ma soprattutto di scavare nella nostalgia della gente.
Tino Montanari