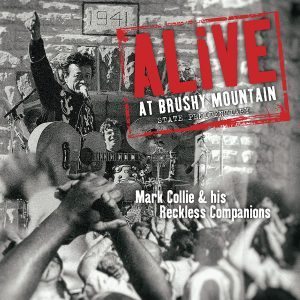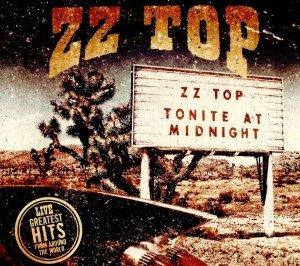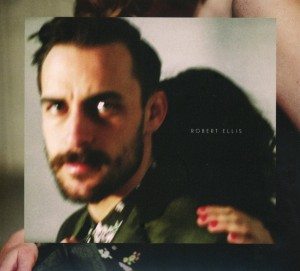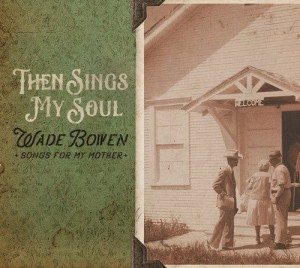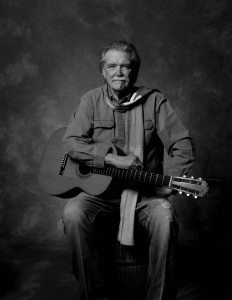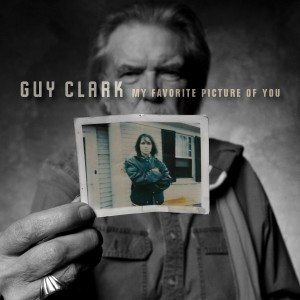Mark Collie & His Reckless Companions – Alive At Brushy Mountain State Penitentiary – Wilbanks Entertainment CD
Spero che mi perdonerete la battutaccia del titolo, ma era difficile resistere… Non so quanti di voi si ricordano di Mark Collie, country singer-songwriter di Nashville abbastanza popolare negli anni novanta, autore di ben cinque album dal 1990 al 1995, con una bella serie di canzoni decisamente elettriche e poco inclini ai compromessi, tra honky-tonk, cover di pezzi rock, qualche ballata di buona fattura e soprattutto tanta energia e brani di sano country moderno. Le vendite non erano neanche male, ma all’improvviso, all’indomani di Tennessee Plates (1995), il silenzio, totale e lunghissimo, interrotto soltanto nel 2006 con la pubblicazione di Rose Covered Garden, un lungo periodo di inattività che non ha fatto certo bene alla sua carriera. Per fortuna le notizie più recenti lo darebbero (il condizionale è d’obbligo) in procinto di tornare nel giro, ma intanto l’appetito viene stuzzicato con la pubblicazione di questo live, il primo per lui, intitolato Alive At Brushy Mountain State Penitentiary, registrato nel 2001 nell’omonima prigione del Tennessee (che ha chiuso i battenti nel 2009), ma messo sul mercato soltanto oggi.
La registrazione di dischi dal vivo nelle prigioni è una vecchia pratica, non solo nel country: gli esempi più noti sono i leggendari album alla Folsom Prison e poi a San Quentin da parte di Johnny Cash, ma anche il disco inciso da B.B. King alla Cook County Jail; anche Mark, che nel 2001 era ancora relativamente popolare, ha pensato di allietare la dolorosa permanenza dei carcerati della prigione di Brushy Mountain, e per farlo si è presentato con una super band. Lo accompagna infatti in questa serata gente come David Grissom, grande chitarrista già al servizio di John Mellencamp e Joe Ely, il tastierista Mike Utley, da decenni nella Coral Reefer Band di Jimmy Buffett, il bassista Willie Weeks (Rolling Stones, Eric Clapton e molti altri), il chitarrista e violinista Shawn Camp (produttore e partner musicale del grande Guy Clark) ed il batterista Chad Cromwell (Neil Young, Mark Knopfler): un gruppo dal pedigree eccezionale, perfetto per accompagnare il nostro nelle sue scorribande elettriche e decisamente coinvolgenti, canzoni che in questa veste live si spostano ancora di più verso il rock; come ciliegina, abbiamo anche un paio di graditi ospiti, e cioè la brava Kelly Willis in tre pezzi e, alla chitarra e voce in Someday My Luck Will Change, il grande bluesman Clarence “Gatemouth” Brown, quattro anni prima della sua scomparsa.
Un gran bel disco di puro country-rock, vigoroso e vibrante, con un leader decisamente in palla ed un pubblico prevedibilmente caldo (anche perché non è che serate come questa fossero frequenti in quel luogo), che risponde spesso con ovazioni ai testi delle canzoni, scelte con cura tra originali e cover in modo da offrire quasi solo brani a tema per così dire carcerario (e quindi non ci sarebbe stata male una bella The Devil’s Right Hand di Steve Earle, uno che in galera c’era pure stato). Attacco potente con One More Second Chance, un rockin’ country (molto più rockin’ che country) ad alto tasso elettrico, gran ritmo e Grissom subito in prima fila a macinare note; I Could’ve Gone Right è una orecchiabile country song che parte lenta ma poi, quando entra la band, fa salire la temperatura, con un motivo diretto ed altro ottimo assolo chitarristico (ma anche Utley fa sentire le sue dita sulla tastiera), Maybe Mexico, che parla della nazione del titolo come possibile luogo di destinazione per un fuggitivo, è un country’n’roll tutto da godere, con il pubblico che si fa sentire al termine di ogni ritornello. Heaven Bound, di e con Kelly Willis, mette in primo piano la bella voce della bionda cantante, per una country song limpida e deliziosa, mentre Got A Feelin’ For Ya (scritta da Dan Penn con Chuck Prophet), ha un ritmo più cadenzato ed elementi quasi soul, con la voce della Willis che si adatta al brano con ottima duttilità.
La fluida On The Day I Die vede Mark tornare al centro del palco, ed è una rock ballad fatta e finita, di country ha poco, e rientra alla perfezione nella categoria di certe canzoni stradaiole di John Mellencamp, mentre la tonica Dead Man Runs Before He Walks ha un buon sapore di country blues elettroacustico sudista; la bella Rose Covered Garden, un folk tune cantautorale di grande presa (una delle migliori composizioni di Mark), precede un’intensa cover di Why Me Lord di Kris Kristofferson, ancora con l’aiuto di Kelly, un’ottima versione che piacerà di certo anche al vecchio Kris. La roccata e ficcante Do As I Say prelude all’arrivo di Clarence “Gatemouth” Brown, che con Someday My Luck Will Change sposta la serata su territori decisamente blues, uno slow notturno di gran classe per sei minuti decisamente caldi e sudati, con la chitarra del bluesman a farla da padrone (ma anche l’hammond di Utley non scherza); il concerto si avvia al termine, il tempo per una Folsom Prison Blues più roccata di quella di Johnny Cash (anche per via dell’assolo di Grissom), e per le conclusive Reckless Companions, altro scintillante country-rock, tra i migliori della serata, e Gospel Train, che come da titolo ci fa spostare di botto in una chiesa dell’Alabama, grazie soprattutto alle voci del Brushy Mountain Prison Choir, grandi protagoniste del brano.
Un gran bel live, ma adesso è tempo che Mark Collie torni del tutto con un disco nuovo al 100%.
Marco Verdi