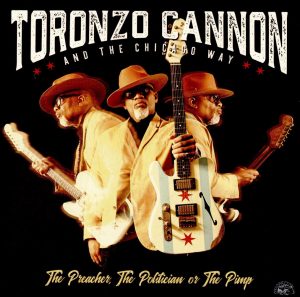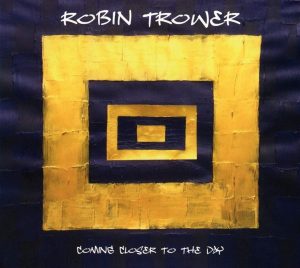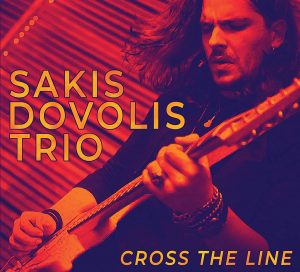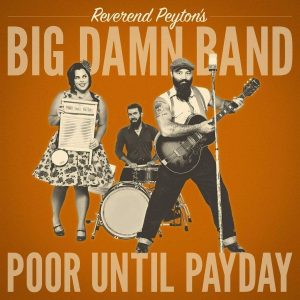Too Slim And The Taildraggers – The Remedy – Vizztone Label Group
Negli ultimi tempo, più o meno regolarmente ogni due anni, Tim Langford e soci ci regalano una nuova prova a nome Too Slim And The Taildraggers: il menu è sempre a base di blues rock robusto con elementi roots, proposto nella classica formula triangolare. Il leader, voce e chitarra, nonché autore dei brani, il bassista Zach Kasik, nel cui studio Wild Feather Recording di Nashville è stato registrato l’album, e il batterista Jeff “Shakey” Fowlkes, con la produzione del CD gestita collettivamente, sono i protagonisti. Stessa formazione del precedente High Desert Heat e anche stessa formula e stile https://discoclub.myblog.it/2018/06/30/il-calore-del-deserto-non-smorza-il-poderoso-rock-blues-chitarristico-di-langford-e-soci-too-slim-the-taildraggers-high-desert-heat/ : Last Last Chance è un boogie and roll, tra Chuck Berry e ZZ Top, con la voce roca e vissuta di Langford a guidare la band in un brano che ricorda anche gli Stones primi anni 70, rock tirato ma eseguito con classe e senza esagerazioni.
In She’s Got The Remedy il suono si indurisce, la voce viene filtrata ed il risultato forse non soddisfa del tutto, troppo carico, anche se l’assolo di wah-wah del buon Tim è veramente gagliardo, Devil’s Hostage è un bel rock-blues della scuola Billy Gibbons, anche a livello vocale, tempo cadenzato e chitarra tagliente, per un ottimo esempio di southern rock vecchia scuola, e l’assolo è veramente notevole, fluido e ruggente. Reckless, robusto groove alla Bo Diddley (più Mona che Who Do You Love), una armonica (Jason Ricci?) a doppiare la chitarra, in un drive che ricorda stranamente anche i primi Jethro Tull, Kasik alla voce, vira decisamente verso il blues, sempre con un eccellente lavoro di Langford che rilascia un altro assolo di quelli tosti https://www.youtube.com/watch?v=XlbQziHCUco ; Keep The Party Talkin’ cambia armonicista, qui Sheldon Ziro, e il riff, siamo dalle parti dei Canned Heat di On The Road Again, ma non la grinta e il tiro della band, che nella parte centrale accelera e lancia il nostro verso un altro assolo poderoso https://www.youtube.com/watch?v=KYRODR3bO0M .
Too Slim non scherza neppure quando si arma di bottleneck come nella cover di Sunnyland Train di Elmore James, dove va di slide alla grande, mentre in Sure Shot, con banjo d’ordinanza e atmosfere sospese ed inquietanti, si vira verso un sound decisamente più rootsy, con finale chitarristico di grande appeal https://www.youtube.com/watch?v=P4oLOMBwODE . Platinum Junkie, di nuovo cantata da Kasik, ha un ritmo decisamente funky, ancora con l’armonica in bella evidenza a duettare con la solista di Langford, sempre in agguato, mentre in Snake Eyes ancora con il banjo aggiunto alle operazioni, si torna al rock desertico del precedente album, con la solista che questa volta lavora di fino in continui rimandi, Think About That, con armonica sempre presente, è nuovamente orientata verso un blues elettrico dove la chitarra di Slim regna sovrana, e la conclusiva Half A World Away è l’unica concessione verso una ballata, diciamo più un mid-tempo consistente, che conferma la varietà di temi impiegati nell’albumda Too Slim And The Taildraggers, al momento una delle migliori band in ambito rock-blues. Gli amanti del genere sono avvisati.
Bruno Conti