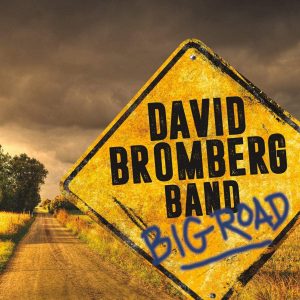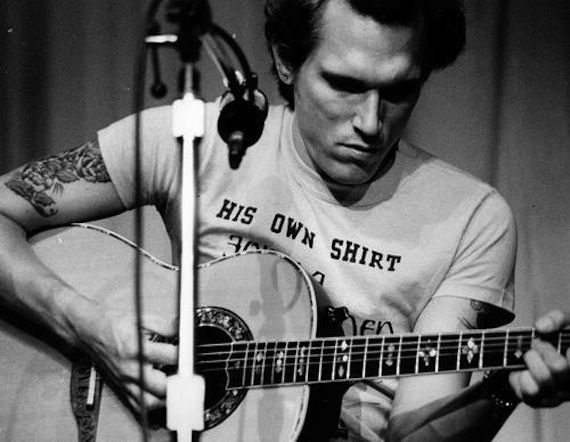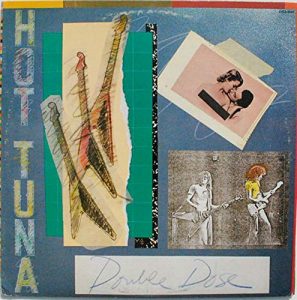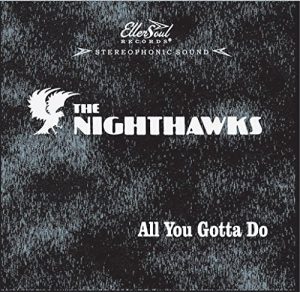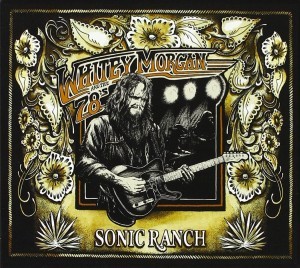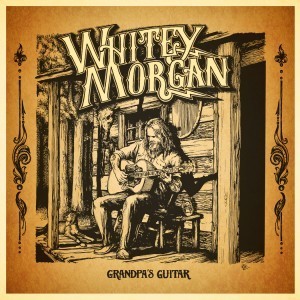David Bromberg Band – Big Road – Red House CD/DVD
Il maledetto Covid-19 ha completamente stravolto, oltre alle nostre vite, anche il mercato discografico, con album che dovevano uscire a breve e che sono stati rimandati ad estate inoltrata o a data da destinarsi ed altri che sono stati anticipati ma solo in formato download. Per quanto riguarda le uscite “fisiche” (almeno quelle che interessano a noi) il mese di aprile è stata un’ecatombe, con i nuovi lavori di Joe Bonamassa e Lucinda Williams come uniche novità di un certo livello (oltre al CD di cui mi occupo tra poco), e maggio non si presenta sotto i migliori auspici, con Willie Nile, Steve Earle e Jimmy Buffett tra le poche “release” di rilievo al momento confermate (oltre ai già recensiti Dream Syndicate, usciti il primo del mese corrente) https://discoclub.myblog.it/2020/04/21/un-album-spiazzante-sicuramente-difficile-ma-affascinante-the-dream-syndicate-the-universe-inside/ , mentre negli anni passati il bimestre appena citato necessitava di un extra budget per gli acquisti. Tra gli album pubblicati in questo periodo c’è anche questo Big Road, nuovissimo lavoro del grande David Bromberg e della sua band, il quinto da quando l’esimio musicista e musicologo nativo di Philadelphia si è rimesso a fare musica dopo quasi due decadi di assenza durante i quali si era reinventato come produttore e venditore di strumenti musicali a corda.
L’acustico Try Me One More Time del 2007 aveva sancito il ritorno di Bromberg a 18 anni da Sideman Serenade, ma la vera e propria rentrée David l’aveva fatta con gli elettrici e splendidi Use Me e Only Slightly Mad, due album ai livelli eccelsi dei primi anni settanta, mentre l’ultimo CD uscito nel 2016, The Blues, The Whole Blues And Nothing But The Blues, era come da titolo un’ottima full immersion nelle varie sfaccettature delle dodici battute https://discoclub.myblog.it/2016/10/25/il-titolo-dice-quasi-poi-ci-pensa-david-bromberg-band-the-blues-the-whole-blues-and-nothing-but-the-blues/ . Il nuovo Big Road vede invece il nostro alle prese con i vari generi con i quali ci ha abituato a trattare, essendo lui una vera e propria enciclopedia ambulante in materia di folk, blues, rock’n’roll, country, bluegrass, gospel, R&B e chi più ne ha più ne metta, in pratica un tesoro nazionale per quanto riguarda la musica americana, che andrebbe salvaguardato nella Biblioteca del Congresso: ai suoi livelli di cultura e competenza musicali ho sempre visto solo Ry Cooder, ed infatti uno dei miei sogni nel cassetto (che temo rimarrà tale) è sempre stato un album collaborativo tra i due. Nel frattempo quindi “accontentiamoci” di Big Road, ennesimo lavoro splendido di una carriera che non ha mai visto una pubblicazione sottotono, anche se qui siamo parecchio vicini ai suoi album più leggendari come Demon In Disguise, Wanted Dead Or Alive e Midnight On The Water, e come minimo sullo stesso piano sia di Use Me che di Only Slightly Mad se non addirittura un gradino più in alto.
Per la terza volta consecutiva la produzione è nelle sapienti mani di Larry Campbell, ormai un nome sul quale contare ad occhi chiusi per quanto riguarda un certo tipo di musica roots, ed il gruppo che accompagna David è formato dai soliti musicisti formidabili che rispondono ai nomi di Mark Cosgrove (chitarre e mandolino), Nate Growler (mandolino e violino), Josh Kanusky (batteria) e Suavek Zaniesienko (basso), mentre contribuiscono al suono anche lo stesso Campbell alla steel, il pianista e organista Don Walker ed una sezione fiati di quattro elementi. Ma il vero protagonista è chiaramente Bromberg, che ci delizia per quasi un’ora con la sua proverbiale abilità di polistrumentista e con il consueto mix di brani originali (pochi, solo due su dodici) e cover di brani che hanno diverse decadi sulle spalle, non molto noti ma riletti in maniera straordinaria e con gli interplay strumentali tra i vari musicisti che sono uno spettacolo nello spettacolo. Il disco si apre con la title track, un brano di Tommy Johnson che Bromberg aveva già inciso su Try Me One More Time ma che sentiva il bisogno di rifare con una band alle spalle: aveva ragione, in quanto ci troviamo davanti ad un blues potente che in un certo senso riprende il cammino interrotto con l’album precedente, con il leader che canta con voce grintosa e la sezione ritmica che non manca di pestare con una certa forza, mentre violino e fiati aggiungono un sapore di old time music.
Di tenore completamente diverso Lovin’ Of The Game (brano di Pat e Victoria Garvey già inciso in passato da Jerry Jeff Walker e Judy Collins), splendida canzone country & western dal ritmo sostenuto e melodia deliziosamente tipica, con goduriosi assoli di steel, mandolino e fisarmonica: Bromberg non ha mai fatto un disco totalmente country, ma sono convinto che se lo facesse il risultato finale si avvicinerebbe molto alle fatidiche cinque stelle. Just Because You Didn’t Answer, scritta da Thom Bishop, è un lentaccio romantico e malinconico in puro stile sixties, un genere atipico per David che però se la cava alla grande (sembra quasi che la voce migliori col passare degli anni), rilasciando anche uno squisito assolo chitarristico subito doppiato dal violino di Grower e dal pianoforte di Walker: davvero brillante. George, Merle & Conway, uno dei due brani firmati da Bromberg (e dedicato ovviamente a George Jones, Merle Haggard e Conway Twitty), è uno strepitoso honky-tonk classico suonato con un feeling incredibile dalla DBB, con la steel di Campbell che si unisce al giubilo generale e David che canta con tono da consumato countryman e ci regala anche un efficace assolo acustico: uno splendore; Mary Jane è un traditional poco noto che vede il nostro esibirsi in perfetta solitudine, voce e chitarra, per una folk tune delicata ed intensa, mentre la breve Standing In The Need Of Prayer è un vecchio gospel per sole voci con Bromberg leader e gli altri quattro membri del gruppo ai cori e battito di mani ritmico, e per un attimo siamo trasportati in una chiesa del profondo Mississippi.
The Hills Of Isle Au Haut è un capolavoro: si tratta di un’oscura folk song di Gordon Bok che David trasforma in un fantastico country-rock elettroacustico guidato da un motivo splendido ed un train sonoro formidabile (Campbell si è davvero superato alla produzione), ottenendo una delle canzoni più belle uscite quest’anno. E’ la volta di un medley strumentale nel quale i nostri passano da Maiden’s Prayer, uno squisito honky-tonk dall’andamento malinconico e con ottimi assoli di mandolino, violino e chitarra acustica, a Blackberry Blossom e Katy Hill, due fiddle tunes che aumentano notevolmente il ritmo e portano il CD su territori bluegrass, con la particolarità che in Katy Hill il violino è sostituito da un trio di mandolini suonati all’unisono. E veniamo al “piece de resistance” del disco (e secondo brano scritto da David), ovvero Diamond Lil, un pezzo epico della durata di dieci minuti che il nostro aveva già pubblicato nel 1972 su Demon In Disguise ma che qui trova la sua veste definitiva: una rock ballad dal motivo toccante con chitarre, piano e violino in evidenza ed uno sviluppo fluido e rilassato, dove si nota il piacere del gruppo nel suonare ed improvvisare insieme (piacere che ovviamente si trasmette alle nostre orecchie).
L’album non molla un attimo, e con Who Will The Next Fool Be? (di Charlie Rich) siamo in una terra di mezzo tra blues e jazz, una raffinata ballata suonata con grande classe e potenziata dai fiati che qui assumono il ruolo di co-protagonisti, mentre Take This Hammer è una prison song scritta da Leadbelly che i nostri tramutano in un irresistibile e ritmato bluegrass, dandoci uno dei pezzi più coinvolgenti del CD; chiusura con Roll On John (canzone del 1946 che Bromberg ha imparato da John Herald quando era membro dei Greenbriar Boys), un incantevole brano che mescola folk e country e presenta due deliziosi interventi di mandolino e fisarmonica. Big Road è più di un grande disco, è un viaggio imperdibile nel cuore della musica americana, con una guida come David Bromberg a rendere la gita ancora più magica: avete presente le cinque stelle di cui parlavo prima? Bene, qui non siamo molto distanti.
Marco Verdi
P.S: il CD esce con allegato un DVD che comprende un documentario sulle sessions e la performance live in studio di cinque brani del disco: anche l’occhio vuole la sua parte!