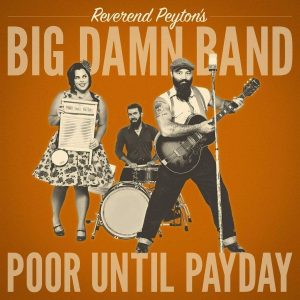The Pretty Things – Bare As Bone, Bright As Blood – Madfish/Snapper CD
Quando nel mese di febbraio ho recensito The Final Bow, bellissimo cofanetto che documentava lo show londinese dei Pretty Things che sanciva il loro addio alle scene https://discoclub.myblog.it/2020/02/18/cofanetti-autunno-inverno-18-lultimo-ruggito-di-una-piccola-grande-band-the-pretty-things-the-final-bow/ , non avrei pensato che dopo pochi mesi avrei dovuto parlare ancora di loro a causa della scomparsa per complicazioni sopravvenute dopo una banale caduta dalla bicicletta del cantante Phil May https://discoclub.myblog.it/2020/05/17/dopo-lultimo-saluto-il-commiato-definitivo-e-morto-phil-may-leader-dei-pretty-things/ , unico membro fondatore ancora nel gruppo oltre al chitarrista Dick Taylor (May e Taylor, proprio come i componenti rimasti in un’altra band inglese “leggermente” più popolare). Fortunatamente i nostri avevano fatto in tempo a completare un nuovo album in studio, il primo da cinque anni a questa parte ed appena il quarto negli ultimi quarant’anni: e Bare As Bone, Bright As Blood, a parte la copertina che sembra la locandina di un film horror, è senza mezzi termini un grande disco, un commiato splendido per una band che non ha mai avuto troppi riconoscimenti nel corso della carriera.
I PT infatti sono sempre stati considerati una band di seconda o terza fascia, fin dagli esordi in stile rhythm’n’blues ed anche durante il loro periodo psichedelico in cui hanno prodotto i loro due dischi più noti, S.F. Sorrow (considerata la prima “rock opera” della storia) e Parachute, ed anche le vendite non sono mai state esaltanti, ma con questo ultimo album May e Taylor si sono superati consegnandoci un lavoro profondo, sofferto, scarno nei suoni ma dal feeling molto alto, un disco decisamente improntato sul blues, che è stato il loro primo amore (il nome Pretty Things è preso da un brano di Bo Diddley). Dedicato a May (ricordato con parole commosse nel booklet interno dal produttore ed ex membro della band Mark St. John), Bare As Blood, Bright As Blood è come suggerisce il titolo un disco dalla veste sonora spoglia ed essenziale, ma con una serie di canzoni di una bellezza cristallina: ci sono solo due originali (non composti però dai due leader) e dieci cover di brani originariamente non solo blues, con una divisione netta tra pezzi antichi e moderni.
Dicevo della strumentazione parca: Taylor si occupa di quasi tutte le parti di chitarra, siano esse acustiche, elettriche o slide, coadiuvato qua e là dalle sei corde di Sam Brothers (anche all’armonica), Henry Padovani e George Woosey ed occasionalmente dal violino di Jon Wigg. Tutto qui, non ci sono neanche basso e batteria, ma le eventuali mancanze sonore sono ampiamente bilanciate dalla bravura e dal sentimento che i nostri mettono in ogni canzone contribuendo così ad una perfetta chiusura del cerchio, terminando cioè la carriera con un omaggio al genere musicale (il blues) che era la loro passione di gioventù. Il CD inizia con due blues tradizionali: Can’t Be Satisfied (resa popolare da Muddy Waters), introdotta da una goduriosa slide acustica subito doppiata dalla voce di May che assume tonalità da vero bluesman, un brano puro e rigoroso ma eseguito col cuore, e Come Into My Kitchen, un pezzo solitamente associato a Robert Johnson che ha la medesima veste sonora del precedente ma è più lento e quasi strascicato, con un’eccellente performance di Taylor e May che sembra che non abbia mai fatto altro che cantare il blues (e l’armonica dona il tocco in più). Ain’t No Grave è un’antica gospel song (l’ha incisa anche Johnny Cash, e dava anche il titolo al suo sesto album degli American Recordings, uscito postumo), ma qui viene trasformata in un puro blues del Delta, ancora per sola voce, chitarra ed armonica: se non fosse per il timbro di May sembrerebbe di ascoltare un vecchio LP di Mississippi John Hurt.
Love In Vain è uno dei brani più noti tra quelli scritti da Robert Johnson, e qui viene proposto in maniera fedele ma non scolastica, con un ottimo interplay chitarristico tra Taylor e Brothers. La sofferta Black Girl è un vecchio pezzo che Lead Belly ha reso famoso col titolo di In The Pines, ed è l’unica a presentare una percussione a scandire il tempo (suonata da St. John), mentre I’m Ready è il brano più noto tra quelli “antichi” essendo uno dei classici di Willie Dixon, ed i nostri la rifanno in maniera vivace e grintosa nonostante l’assenza della sezione ritmica. E veniamo ai pezzi moderni, che iniziano con la scelta più sorprendente, cioè la cover di Faultline del gruppo alternative rock Black Rebel Motorcycle Club, una canzone radicalmente trasformata in un bluesaccio elettroacustico teso come una lama, molto diretto pur nel suo essere spoglio strumentalmente: una rielaborazione creativa e decisamente riuscita. Redemption Day è invece un brano di Sheryl Crow in cui i nostri abbandonano momentaneamente il blues per regalarci una ballata folk elettrificata suggestiva e dal notevole impatto emotivo, con almeno tre chitarre e la voce di May più cavernosa che mai; rimaniamo in ambito folk con la splendida The Devil Had A Hold On Me, canzone di Gillian Welch che ha già di suo le caratteristiche di un vecchio traditional, ma il pathos cresce ulteriormente in questa rilettura da brividi che mi ricorda addirittura i Led Zeppelin quando facevano brani elettroacustici: tra gli highlights del CD.
Bright As Blood è scritta per i Pretty Things dal loro chitarrista Woosey, una folk tune d’altri tempi con la voce di Phil accompagnata da chitarra acustica, banjo e violino, un perfetto esempio di brano tradizionale appalachiano composto però ai giorni nostri. Concludono un disco puro, bellissimo e perfino sorprendente To Build A Wall (del misconosciuto cantautore Will Varley), ballata acustica dalla melodia struggente cantata con un feeling davvero rimarchevole, e la nuova Another World (scritta da tale Pete Harlen), un lento rilassato e disteso caratterizzato da uno script solido e profondo. Forse i Pretty Things non sono mai stati una band indispensabile, almeno se paragonati ai gruppi contemporanei degli anni sessanta, ma questo loro album di congedo è una zampata da veri fuoriclasse e, molto probabilmente, il punto più alto della loro discografia.
Marco Verdi