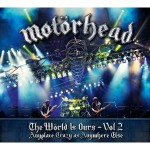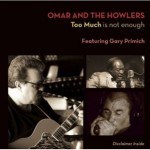Ian Siegal & The Mississippi Mudbloods – Candy Store Kid – Nugene Records
Ormai Ian Siegal sembra avere preso gusto per queste trasferte americane, alle radici della musica blues, nel Nord Mississippi e dintorni. Quella dello scorso anno, per l’album The Skinny, in compagnia dei Youngest Son, gli ha fruttato la nomination come Miglior Disco di Blues Contemporaneo ai premi annuali della Blues Foundation del 2012, la prima volta di sempre per un musicista inglese. Ma non è la sola “prima” per Siegal, anche il premio assegnatogli dalla rivista Mojo per il disco Broadside come Blues Album Of the Year, accadeva per la prima volta con un artista non americano (anche se per onestà, all’epoca d’oro dei Bluesmen britannici Mojo non esisteva). Visto il successo del disco dello scorso anno, il buon Ian ha deciso di ripetere il “trucco” di registrare l’album sulle colline del Mississippi, e questa volta non si è portato dietro neppure la sua abituale sezione ritmica. Candy Store Kid è stato realizzato con musicisti locali, amici importanti, qualche “figlio di…” come nel disco precedente e alcune new entry.
Quindi troviamo Cody Dickinson, alla batteria, tastiere e chitarra anche, nella traccia iniziale, la poderosa Bayou Country, il fratello Luther, chitarre, sitar, mandocello e basso in parecchi brani. Il basso, in effetti, viene democraticamente affidato a diversi musicisti a seconda dei brani, Garry Burnside e Alvin Youngblood Hart lo suonano in parecchie tracce, anche se, soprattutto il secondo, è alla chitarra in molte canzoni. Lightnin’ Malcom, altro musicista del giro North Mississippi, compone un brano, So Much Trouble, nel quale è pure la seconda voce. E a proposito di voci, purtroppo solo in tre brani, perché sono strepitose, appare un terzetto di voci femminili Stephanie Bolton, Sharisse Norman e Shantelle Norman, che aggiungono una patina soul e R&B che scalderà le vostre fredde serate invernali, oltre a ricreare in parte quel tipo di sound che Luther Dickinson frequenta nel suo “altro” gruppo, i Black Crowes (uno degli altri gruppi, diciamo)!
Naturalmente per Ian Siegal suonare questa musica e con siffatti musicisti è un po’ come entrare in un “Negozio di canditi”: quelli particolarmente gustosi e succulenti, come nell’iniziale Bayou Country, scritta da un paio di musicisti minori nativi della Lousiana, Bardwell e Veitch, che una quarantina di anni fa lavoravano con Tom Rush. Il brano, oltre al bayou, ha il ritmo e la consistenza delle canzoni di Joe Cocker con i Mad Dogs o dei Delaney & Bonnie con Clapton, nelle linee sinuose della solista, mentre le tre ragazze in sottofondo caricano il brano con la loro esuberanza vocale, per un inizio esaltante. Loose Cannon è un rock-blues sporco e cattivo da juke joint, come quelli frequentati dai babbi di alcuni dei musicisti presenti, con le chitarre e le voci, spesso distorte, che aggiungono intensità ad un brano gagliardo. I Am The Train ha ritmi incalzanti da soul revue sudista, con un slide che si insinua nel groove del tessuto della canzone e la miriade di altre chitarre che imprimono anche il loro marchio di qualità. So Much Trouble, con il sitar di Luther Dickinson in evidenza, è quella che più ricorda il sound ipnotico e ripetitivo dei vecchi maestri della Fat Possum, ma è impreziosita da piccole (o grandi) coloriture sonore, oltre al sitar, la slide, un organo in sottofondo e, Lightnin’ Malcolm e le tre ragazze che ogni tanto si fanno sentire nel reparto voci.
Kingfish è una collaborazione tra Luther e Ian Siegal, con la voce paludosa e profonda di quest’ultimo che si spinge in territori più chiaramente Blues, fiancheggiata dalla solita miriade di strumenti a corda, sia elettrici che acustici. In The Fear la voce di Siegal va in cantina a raggiungere quelle di Cohen e Waits, anche se il brano è talmente attendista che quando finisce siamo ancora lì ad aspettare che si apra in qualche modo. Earlie Grace Jr. sembra un brano perduto dei Creedence cantato dal fratello minore del Waits giovane e con Harrison alla chitarra. La Green Power l’hanno usata per nutrire un wah-wah tostissimo che propelle una cover super-funky di un brano di Little Richard scritto da tale H.B. Barnum che non penso sia l’inventore del circo ma di sicuro del funky era tra i contribuenti, inutile dire che le tre vocalist di colore sono nel loro “ambiente”. Strong Woman è una breve e poderosa iniezione rock-blues firmata con Burnside che svergogna quasi tutto il repertorio di Lenny Kravitz. The Rodeo è una bella ballata campagnola che evidenzia la “parentela” di intenti con il Tom Waits di Jersey Girl. Hard Pressed (what da Fuzz?) è un altro funkaccio cattivo e il “fuzz” ovviamente è nella chitarra, cattiva quanto basta. Bravo e bello (scusate, guardo la foto): direi bravo e basta!
Bruno Conti