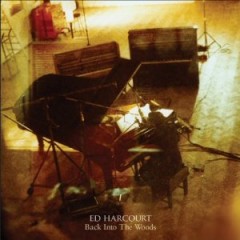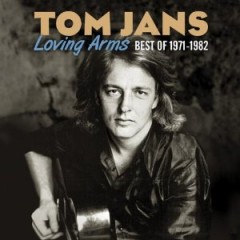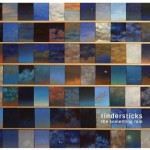Dayna Kurtz – Secret Canon Vol. 2 – Kismet Records 2013
Domandona per i molti lettori (spero) di questo blog: Chi conosce Dayna Kurtz? La signora proviene dal New Jersey, ha una lunga carriera alle spalle (è in pista dai primi anni duemila) e da quel periodo bazzica locali e sale, e porta in giro negli States (e in altri Paesi, tra cui l’Italia) le sue canzoni. Il sottoscritto ha avuto il piacere di conoscerla e sentirla in un concerto tenuto nel “mitico” locale Spazio Musica in quel di Pavia (2008), dove ha dimostrato una grinta notevole ed una grande voglia di comunicare le proprie sensazioni. L’esordio, per la sua Kismet Records, avviene con Postcards From Downtown (2002), a cui fanno seguito un bellissimo DVD Live in Concert From Amsterdam(2003), Beautiful Yesterday (2004) Another Black Feather (2006) e più recentemente il notevole American Standard (2009) e il primo volume di Secret Canon dello scorso anno (per completare la discografia devo menzionare un CD preso al concerto Otherwise Luscious Life – Dayna Kurtz Live di difficilissima reperibilità).
Questo secondo capitolo di Secret Canon, prosegue il discorso del primo, pescando una serie di oscure “cover” di brani jazz e blues scelti tra gli anni ’40 e ’60 (oltre a canzoni scritte dalla “rossa” Dayna), avvalendosi di compagni di viaggio di indubbio talento, partendo dal co-produttore Randy Crafton, il contrabbassista David Richards, Peter Vitalone e Jon Cowherd al piano, Jon Gros all’organo e la sezione fiati composta da Jason Mingledorff al sax, Craig Klein al trombone, Barney Floyd e John Bailey alle trombe, che sono indubbiamente il valore aggiunto del lavoro.
Immaginate di essere seduti al famoso Rick’s Bar di Casablanca (in dolce compagnia) e spente le luci , partono le note di I Look Good In Bad (scritta dalla stessa Kurtz, ma potrebbe essere anche benissimo un brano cantato da Bessie Smith), cui fa seguito una So Glad del cantante pianista di New Orleans Edwin Bocage (1930-2009) dallo swing inarrivabile, mentre la bellissima ed emotiva ballata Reconsider Me (me la ricordo in una versione di Johnny Adams) è cantata con il profondo dell’anima da Dayna. Il tempo di sorseggiare un buon bourbon e si riparte con le note di One More Kiss, pescata dal repertorio di Johnny “Guitar” Watson, la raffinata Same Time, Same Place della coppia Isaac Hayes e David Porter con in sottofondo la tromba vellutata di Barney Floyd, mentre la seguente If You Won’t Dance With Me è un altro splendido brano originale della stessa Kurtz.
Il piano di Jon Cowherd introduce le effusioni vocali di All I Ask Is Your Love (brano apparso nella splendida colonna sonora di Una canzone per Bobby Long, eseguita da Helen Humes), si prosegue con il gospel-blues di Go Ahead On, e con una sofisticata e jazzata I’ve Had My Moments, che era nel repertorio del grande Frank Sinatra. Il colpo di grazia arriva con la conclusiva I’ll Be A Liar (la perla del disco) di Bert (Russell) Berns (1929-1967), un pioniere del rock e soul degli anni sessanta (morto d’infarto a soli 38 anni, autore di brani come Here Comes The Night, Piece Of My Heart e Twist and Shout), con piano e tromba ad accompagnare una performance vocale da brivido di Dayna.
Il genere di Dayna Kurtz, è forse troppo complesso per i nostri giorni, (artista errabonda che ha passato anni in giro per i palchi e le bettole di mezza America ), e per incidere i dischi che sognava, ha dovuto crearsi un etichetta propria, la Kismet Records, e forse per questo, ancora adesso non è molto conosciuta, ma se i risultati sono questi… Secret Canon Vol. 1 e 2 sono due lavori notturni che fanno bene all’anima, imprescindibili per gli amanti del genere, che fanno della Kurtz una tra le più brave e intriganti voci femminili degli ultimi anni, abilitata a cantare nei più famosi Rick’s Bar del mondo!
Tino Montanari