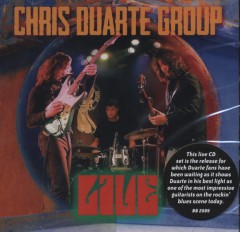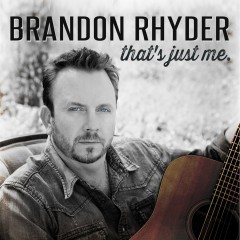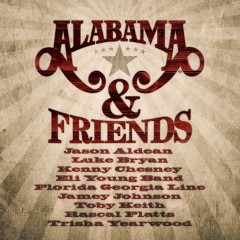The Wild Feathers – The Wild Feathers – Warner Bros Records
“Ho visto il futuro del Rock and Roll e il suo nome è The Wild Feathers”! Esagerato? “Ho visto il presente del R&R e il suo nome è Wild Feathers”! Sempre troppo? Che ne dite di: ho visto una band tra presente e passato del rock and roll, si chiamano le Piume Selvagge, un nome gagliardo che ricorda quasi una tribù di pellerossa. Sono texani di Austin e vengono da Nashville. Scusa? Nel senso che sono originari del Texas ma vivono a Nashville, tutto chiaro? E aggiungo che sono una di quelle classiche band che eseguono una serie di canzoni che sembrano delle cover, ma con dei titoli nuovi (?!?). Mi spiego meglio, le canzoni ricordano, più o meno tutte, a tratti, brani scritti da altri, Allman Brothers, Tom Petty, la Band, Jayhawks, Stones, Neil Young, Ryan Adams, che è un altro tra i “giovani” che assorbe miriadi di influenze e le rimodella nella sua musica, ma non canzoni specifiche, però la struttura, l’atmosfera, il sound sono quelli del rock classico, nelle sue mille sfaccettature, e anche se non si sfiora mai il plagio, ci sono miriadi di melodie, di riff, che galleggiano nell’etere e ogni tanto si posano sulle chitarre e nelle ugole di musicisti più “originali” e bravi di altri.
E’ il caso dell’esordio di questo quintetto americano, perché i musicisti degli States sono meno sfacciati delle loro controparti britanniche nell’ispirarsi a quanto di buono viene dalla musica del passato, per riproporla sotto forma di canzoni destinate ad un pubblico giovane (sempre più ristretto, ma ancora voglioso di buona musica) e ai “vecchi marpioni” del rock, appassionati e critici che hanno già visto e sentito tutto, ma non per questo non apprezzano le nuove forze emergenti, salvo gli inguaribili cinici e bastian contrari che sono spesso inflessibili. Le dodici canzoni dell’omonimo esordio dei Wild Feathers scorrono tutte d’un fiato, si ascoltano con grande piacere nella loro alternanza anche di elementi folk, rock, country e blues, su una base di musica rock. Come dite, la chiamano Americana? Potrebbe essere, perché no, anche se loro preferiscono essere definiti una “american” band.
Dalla riffatissima Backwoods Company che potrebbe essere un incrocio tra Tom Petty ed Allman Brothers, musica sudista con chitarre, armonica e tastiere in primo piano, alle ricche armonie vocali di un brano come American, dal titolo programmatico, sempre con una impressione di già sentito, ma che non ti impedisce di gustare gli intrecci di chitarre elettriche ed acustiche, le voce filtrate e le melodie molto seventies, non a caso tra gli autori c’è anche un certo Gary Louris. E I Can Have You dalla ritmica scandita e la doppia voce solista non può non ricordare proprio gente come i Jayhawks. che a sua volta si rifaceva al country-rock classico di Young, era Buffalo Springfield, con le sue chitarre grintose e organo e piano elettrico che si fanno largo tra le pieghe della canzone. Tall Boots è una bella power ballad dal suono avvolgente, gli Eagles li avevamo citati?
Mentre la lunga The Ceiling potrebbe venire dal repertorio di una band come gli Avett Brothers, con notevoli intrecci strumentali e vocali che arricchiscono l’impianto sonoro di un brano che ha anche le stimmate della buona musica pop che ti resta in testa, un singolo da sei minuti e oltre dimostra che vogliono prendersi i loro rischi. La bellissima Left My Woman con il suo lento crescendo e la voci dei vari Feathers che si alternano, non saprei dirvi chi sia Ricky Young, chi Joel King, Taylor Burns o Leroy Wulfmeier, le voci dei quali entrano una alla volta e poi tutte all’unisono, ma impareremo a conoscerli, la canzone con il suo ritornello di “All My Money’s Gone” ricorda la dura realtà della vita sulla strada e il break della chitarra nella parte centrale del brano è pressoché perfetto.
I’m Alive di Joel King ha ancora quell’aria scanzonata power pop da anni ’60, con organetti e chitarre che si fanno largo tra le acustiche. Hard Wind potrebbe essere un brano di Petty accompagnato dalle chitarre incattivite dei Crazy Horse o degli Allman, scegliete voi, seguita dal pop più dolce di If You Don’t Love Me, firmata da Ricky Young, che ne è l’esatto apposto, a segnalare l’eclettismo del gruppo. Hard Times, sempre con i pregevoli incroci delle voci dei componenti del gruppo, nuovamente oltre i sei minuti, è l’altro tour de force del disco, con chitarre, organo e piano che iniziano a jammare di gusto con qualcosa di stonesiano o anche à la Black Crowes e un finale acustico alla CSN. Anche Got It Wrong ricorda i migliori Jayhawks, sentita mille volte ma non per questo meno piacevole, con quella abilità innata per le belle melodie, chiamatelo neo-revisionismo, ma a me piace. E How è un’altra di quelle ballatone in crescendo chiaroscuro, ricco di soul, che non puoi fare a meno di apprezzare: segnatevi il nome, The Wild Feathers, questi sono bravi!
Bruno Conti