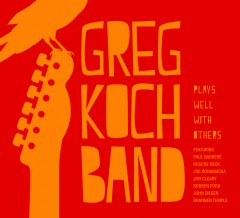Robben Ford – A Day In Nashville – Mascot/Provogue Uscita 04-02-2014 EU/ITA 04-03-2014 USA
La “solita anteprima” per Robben Ford!
Il disco uscito lo scorso anno, Bringing It Back Home, era stato registrato in “ben” tre giorni http://discoclub.myblog.it/2013/02/15/una-anteprima-a-lunga-gittata-19-febbraio-2013-il-nuovo-albu/ ! Per questo nuovo A Day In Nashville, come recita il titolo, per le procedure di registrazione si è utilizzato un solo giorno. E in tempi di moderne tecnologie si tratta di una sorta di ritorno alle vecchie metodologie degli anni ’60 e ’70, quando, volendo, ma anche allora non era facile, si registrava un intero LP in un lasso di tempo brevissimo, anche se un giorno è quasi un record. Una volta il problema era dovuto soprattutto ai costi di uno studio di registrazione, si registrava anche di notte e a rotazione con altri musicisti per spremere il massimo dalle poche ore a disposizione http://www.youtube.com/watch?v=HyqQgnW_S8g .
Poi è diventata una questione di perfezionismo, spesso gli studi sono di proprietà dei musicisti, che vi ci si trastullano per periodi quasi biblici, per dare libero sfogo alle proprie manie o semplicemente per necessità perché l’ispirazione latita. Nel caso di Robben Ford invece tutto è stato pianificato: all’inizio il progetto prevedeva un disco dal vivo registrato durante il tour dello scorso anno, poi nella fase finale della tournée, ad ottobre, il chitarrista ha avuto dei problemi al polso e molte delle date sono state annullate e rinviate http://www.youtube.com/watch?v=sByZvhy8u2o . Nel periodo di inattività cosa ti pensa il vulcanico musicista? Perché non prenotare il Sound Kitchen Studio, uno dei migliori di Nashville (ma niente paura non è un disco country, anche se sarebbe stato interessante), dove dà appuntamento ai musicisti che fanno parte della sua attuale touring band, ai quali erano stati inviati dei demo solo voce e chitarra, su cui il gruppo avrebbe potuto improvvisare all’impronta http://www.youtube.com/watch?v=zK39bL9F7U0 .
Ma non solo, messa da parte momentaneamente l’idea di un disco dal vivo, Ford ha scritto anche sette canzoni nuove di zecca, insieme a due cover assolutamente poco note. E il risultato è un disco che conserva la qualità e la varietà di temi di quello dello scorso anno (che era veramente bello), con una ulteriore freschezza dovuta all’approccio molto libero dato dalla possibilità, anzi direi dalla necessità, di improvvisare. Il sound è quello classico dei dischi migliori di Robben, dalla Ford Blues Band ai Blue Line, passando per le collaborazioni con Witherspoon e Musselwhite, c’è molto blues, ma non mancano abbondanti dosi di funky e soul, rock, un pizzico di jazz e la sua immensa tecnica chitarristica http://www.youtube.com/watch?v=4kln-Kuq6mE . I musicisti utilizzati per questo A Day In Nashville sono ottimi: dal tastierista Ricky Peterson, per lunghissimi anni spalla di David Sanborn e prima anche con Prince, al bassista Brian Allen (che ha un recente passato con Jason Isbell e Jamey Johnson, ma ha suonato anche con Scofield e le touring bands di Temptations e Four Tops, aumentando la quota soul del gruppo); provvista pure da Wes Little, il batterista, uno che suonato con Sting e Stevie Wonder. Per bilanciare la quota rock l’ultima aggiunta è Audley Freed, ex dei Black Crowes e quella jazz è provvista dal trombonista Barry Green (uno strumento già utilizzato nel precedente album e “scoperto” da Robben Ford negli ultimi tempi).
Si diceva sette pezzi nuovi e due cover. Partiamo da queste ultime: Cut You Loose è un blues scritto dal grande armonicista James Cotton, qui trasformato in un fluido veicolo per la voce e la chitarra di Ford, veramente in grande forma, mentre duetta con l’organo di Ricky Peterson, aiutato dalla spinta della sezione ritmica e con un bell’assolo anche del trombone di Green; alla fine il brano è una ulteriore variazione sul tema del “blues according to Robben Ford”, non c’entra moltissimo con l’originale, ma non puoi fare a meno di apprezzare uno che suona la chitarra in modo così divino. Poor Kelly Blues viene da ancora prima, dal periodo della grande guerra, scritta da Big Maceo Merryweather e scoperta probabilmente grazie all’enciclopedica conoscenza acquisita nella band con i fratelli, qui siamo nel blues più duro e blues, i ritmi e la scansione sono quelli classici, sempre spazio per gli altri solisti ma anche una maggior grinta e voglia di improvvisare.
Subito evidente fin dall’iniziale Green Grass Rain Water che ha un afflato rock and soul molto più immediato rispetto alle abitudini più raffinate del nostro. Midnight Too Soon è uno di quegli slow blues con chitarra lancinante che sono nel DNA di Ford mentre Ain’t Drinkin’ Beer No More ha un approccio più rilassato, quasi jazzato, con la presenza marcata del trombone e dei fiati e il tipico divertente coretto da avvinazzati di chi si è fatto qualche birra di troppo. Top Dawn Blues, nonostante il titolo, è un funky-soul strumentale, sempre con uso di fiati, con tutta la band che improvvisa alla grande mentre Different People è una bellissima mid-tempo ballad dalle ricche melodie, cantata benissimo e suonata anche meglio. Detto delle due cover che sono posizionate a questo punto del CD, rimangono una Thump And Bump, altra traccia strumentale che evidenzia le propensioni funky dei musicisti, evidenziate dal loro CV, ben suonata ma più per “Fordofili” jazz fusion. Conclude Just Another Country Road, un altro di quei blues sincopati tipici del repertorio di Robben Ford. L’ho sentito in fretta e in streaming, un po’ all’ultimo minuto (ma il giusto), e se dovessi dire, mi sembra leggermente inferiore al precedente Bringing It Back Home, ma è l’impressione del momento!
Bruno Conti