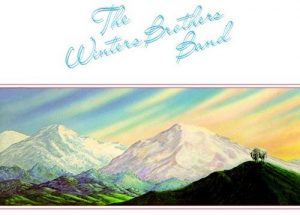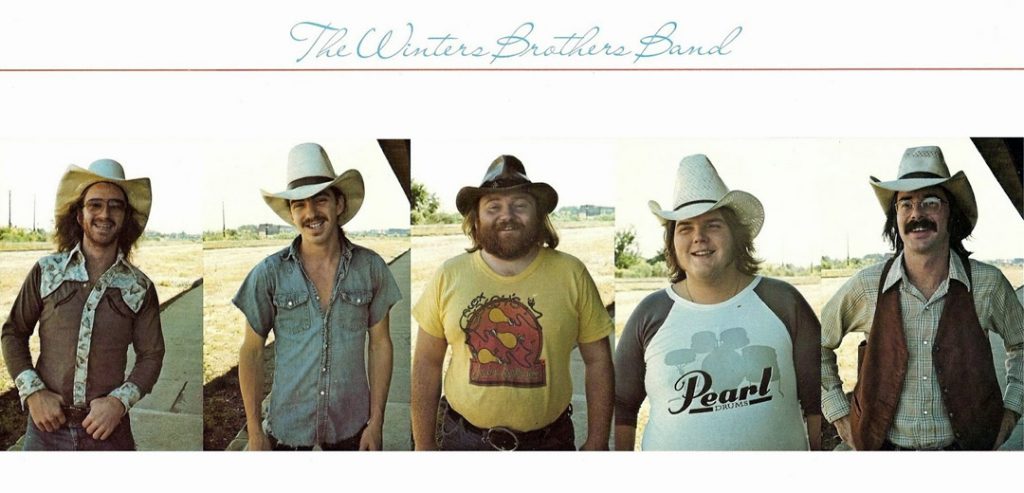Black Stone Cherry – Family Tree – Mascot Records
I Black Stone Cherry si formano ufficialmente nel giugno del 2001 a Edmonton, Kentucky dall’incontro tra il chitarrista e cantante Chris Robertson e il batterista John Fred Young, un musicista cresciuto a pane e (country) rock, visto che il padre e lo zio di Young, anche loro chitarrista e batterista, erano tra i membri fondatori dei Kentucky Headhunters, storica formazione southern rock statunitense. Occorre dire che prima di approdare all’omonimo esordio discografico, pubblicato solo nel 2006, i BSC hanno fatto la lunga classica gavetta fatta di lunghi tour, culminata con un contratto con la Roadrunner, etichetta specializzata soprattutto in hard-rock e heavy metal nelle sue varie guise, anche alternative ed elementi sudisti carpiti dai Kentucky. Insomma i nostri amici non ci sono mai andati giù molto leggeri con il loro rock, anche se alcune cover disseminate nei vari album indicano la tendenza a buoni ascolti: Shapes Of Things degli Yardbirds, Can’t You See della Marshall Tucker Band, ma anche War di Edwin Starr e Mississippi Queen dei Mountain https://www.youtube.com/watch?v=NXNnYKqxy9g , entrambe presenti su Kentucky, il loro debutto per la Mascot del 2016, segnalano che il gruppo vorrebbe aprire anche altri orizzonti sonori. Poi spesso tra il dire e il fare, come si usa dire, c’è di mezzo il mare, visto che anche questo Family Tree è “duretto” anziché no, e i quattro “ragazzi” nel loro studio Barrick Recording, in quel di Glasgow, Kentucky, amano sempre picchiare di gusto, ma con costrutto.
Ben Wells è un secondo chitarrista di buona sostanza, come pure John Lawhon un bassista solido e centrato, e l’unico ospite presente nel disco, Warren Haynes, indica che la band comincia a godere di una buona reputazione tra i colleghi. Dancin’ In The Rain in effetti sembra un brano di quelli più cattivi dei Gov’t Mule, con la voce maschia e potente di Robertson che duetta con quella di Haynes, mentre un muro di chitarre si eleva massiccio, tra slide, wah e wah e soliste ovunque, secondo i migliori dettami del southern rock più sanguigno. In definitiva i poster dei vari Cream, Led Zeppelin, Uriah Heep, Stones, Montrose e Faces che Young e soci dicevano di vedere sulle pareti dello spazio prove dei Kentucky Headhunters, alla fine sono serviti a qualcosa. A ben vedere ci sarebbe anche un altro ospite nell’album, il figlio di 5 anni di Robertson, alle “armonie vocali” nella cattiva You Got The Blues, il rock è sempre hard ma ci sono pure sostanza e buone vibrazioni nella musica dei Black Stone Cherry. Come spesso capita sto ascoltando l’album parecchio tempo prima dell’uscita, quindi vado a sensazioni: la band tiene fede al proprio stile fatto di riff granitici, chitarre fumanti e ritmi molto tirati, dal funky-rock bruciante dell’iniziale Bad Habit che profuma di rock anni ’70, con un cambio di tempo a metà brano che rimanda ai Led Zeppelin più ingrifati, mentre le chitarre di Robertson e Wells imperversano con buoni risultati e pure nella successiva Burnin’ non si bada molto alle sottigliezze, non si fanno prigionieri, tra chitarre, chitarre e ancora chitarre, cosa andiamo ad ascoltare è piuttosto chiaro, però c’è anche della classe nell’intermezzo delle twin guitars, siamo di fronte a del sano R&R ben fatto.
Con un pianino aggiunto nella saltellante New Kinda Feelin’, qualche tocco iniziale di percussione nell’”antemica” Carry Me On Down The Road, Robertson vocalmente mi ricorda un poco il giovane Jimmy Barnes, mentre la band tira alla grande con le chitarre che si intrecciano nei canali dello stereo; in My Last Breath fa capolino anche un piano elettrico e una slide tangenziale per una hard ballad di eccellente fattura, tra coretti e derive southern per nulla scontate. Southern Fried Friday Night, con un talk box minaccioso che non si sentiva da anni e una grassa atmosfera funky-groove, sa di Black Crowes, alle prese con la oro collezione di Stones, Faces e Zeppelin; Ain’t Nobody di nuovo con slide d’ordinanza in evidenza è ancora southern-rock misto hard, forse già sentito mille volte, ma questo non impedisce di lasciare andare il piedino con goduria https://www.youtube.com/watch?v=gi7nuWlxPwI . James Brown, niente soul nonostante il titolo, è un altro gagliardo esempio del poderoso rock dei BSC, a tutto riff e chitarre ed atmosfere ingrifate, e pure I Need A Woman non apporta molte variazioni al menu, se rock deve essere così sia, alzare il volume a 11 e procedere, come anche nella scandita Get Me Over You, altra ottima occasione per fare dell’air guitar davanti allo specchio, con pose alla Jimmy Page. Inutile dire che pure nella conclusiva Family Tree, con organo Hammond aggiunto, non c’è tregua, ancora rock duro come non ci fosse domani. Ma il disco esce oggi! E con questo concludiamo la giornata del rock.
Bruno Conti