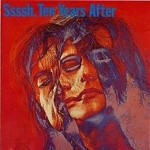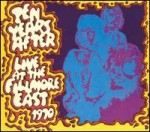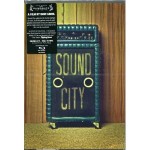Quando la sera del 17 agosto 1969, poco dopo le 20, nella terza serata del Festival di Woodstock, Alvin Lee sale sul palco per la sua esibizione con i Ten Years After, non immagina due cose: che sarà una “serata di merda” e che, in seguito, cambierà completamente il corso della sua carriera. A causa della fortissima umidità della serata gli strumenti, ed in particolare la chitarra del leader, avranno una miriade di problemi, andando di continuo fuori accordatura, costringendoli a frequenti pause durante il loro set, come se non bastasse anche la troupe che riprendeva l’evento, per i medesimi problemi, riuscirà a riprendere solo il brano finale dell’esibizione, il bis, I’m Going Home. Ma in quella serata era comunque presente all’incirca mezzo milione di persone e quando l’anno successivo appare il film, la scena in cui lo schermo si divide prima in due e poi in tre parti ed appare un biondo chitarrista inglese con una Gibson rossa fiammante che attacca a velocità supersonica il riff di I’m Going Home, fa sì che nell’immaginario collettivo dell’epoca nasca la leggenda del “chitarrista più veloce del mondo”. Probabilmente, anzi sicuramente, non era vero, ma a quei tempi chitarristi più tecnici come John Mclaughlin, Larry Coryell, Ollie Halsall e molti altri, che basavano la loro “velocità” sulla costruzione di scale musicali mutuate dal jazz e non sui riff del rock and roll, erano noti solo a pochi aficionados e quindi anche sulla scia del triplo album che uscì l’anno successivo molte “leggende” del rock nacquero in quella occasione. Lo spastico dondolio di Joe Cocker, l’incazzoso Pete Townsend che distrugge la sua chitarra durante l’esibizione degli Who (già “provato” a Monterey un paio di anni prima), il vaffanculo collettivo di Country Joe McDonald, l’assolo di batteria di Michael Shrieve durante l’esibizione dei Santana, la trance quasi mistica di Richie Havens mentre canta Freedom, il bombardamento al napalm della chitarra di Jimi Hendrix durante l’esecuzione dell’inno nazionale americano, si dividono con l’inno al rock and roll e al blues dei Ten Years After di Alvin Lee il titolo di momenti indimenticabili del film e del disco, anche se ovviamente c’era tantissima altra buona musica, meno legata ad un particolare effetto audiovisivo!
Lee nasceva Graham Alvin Barnes il 19 Dicembre 1944, durante le ultime propaggini della IIa Guerra Mondiale, a Nottingham, per noi italiani, la patria dello sceriffo di Robin Hood. Già nel corso della sua giovinezza, con l’amico Leo Lyons, sviluppa un amore per il jazz e il blues (che rimarrà una costante nella sua carriera, soprattutto nella parte iniziale) ma è l’incontro con il R&R a dargli la spinta a diventare un musicista. Il suo primo gruppo sono i Jaybirds, che passano dallo Star Club di Amburgo un paio di anni dopo i Beatles, nel 1962. Ma è quando approdano a Londra, verso la metà anni ’60, che persa prima la s e poi mutato il nome in Blues Yard, finalmente, nel 1966, arrivano alla ragione sociale definitiva di Ten Years After (esattamente dieci anni dopo “l’avvento” di Elvis Presley, da cui il nome) e ai concerti al Marquee che li porteranno a firmare un contratto con la Decca/Deram e alla pubblicazione dei primi dischi.
I primi tre dischi, l’omonimo Ten Years After ***, il live Undead ***1/2 e Stonedhenge ***1/2, tutti ristampati in CD con varie bonus, sono quelli che li aiutano a costruirsi una certa fama nel periodo del British Blues Revival di quegli anni, in embrione ci sono moltissimi dei brani che costituiranno il corpo delle loro esibizioni dal vivo dell’epoca e successive, compresa quella di Woodstock. Usciti nel 1967, 1968 e 1969 ci presentano un gruppo, e soprattutto, il loro leader, Alvin Lee, ancora impegnati in uno stile asciutto e influenzato sia dal blues quanto dal jazz, dallo swing e dalle big bands alla Woody Herman, altro grande amore musicale di Alvin. Nel primo album ci sono già le prime versioni di I Can’t Keep From Cryng, Sometimes, la canzone di Al Kooper, scritta per i Blues Project, che costituirà poi il canovaccio per il lunghissimo brano dal vivo, eseguito anche a Woodstock, dove i TYA citavano praticamente tutta la storia del rock, del blues e dei grandi chitarristi passati e presenti, con un medley di dimensione spesso pantagrueliche. C’è anche Help Me, lo slow blues di Sonny Boy Williamson, che è tuttora uno dei cavalli di battaglia in concerto di Van Morrison.
In Undead si trova la prima versione di I’m Going Home, dal vivo al Klooks Kleeks di Londra nel maggio del 1968, è una ancora una versione “breve”, poco più di 6 minuti, più jazzata e legata a boogie, blues e swing, ma il brano di Al Kooper citato poc’anzi è già nel suo formato monstre da oltre 17 minuti (nelle bonus del CD, all’epoca non lo si conosceva ancora) con la Extension On One Chord che era la lunga parte centrale dedicata all’improvvisazione. Il gruppo esegue Woodchoppers’s Ball di Woody Herman e Summertime, ma anche Rock Your Mama, Spoonful e Standing At The Crossroads che già segnalano la prossima svolta verso il rock-(blues). L’anno successivo esce Stonedhenge che già dal titolo ci parla di questo incrocio tra cerchi magici e strane cose “fumate”: è un disco particolare, quasi psichedelico, leggermente sperimentale ed improvvisato, ma contiene un paio di classici Hear Me Calling e Speed Kills, oltre alla lunga Boogie On (oltre 14 minuti), sempre tra le bonus, che riportano anche la versione del singolo, abbreviata, di I’m Going Home.
La successiva fase è quella che potremmo definire dei Chrysalis Years 1969-1972, Think About The Years è il titolo di una bella antologia tripla uscita in CD nel 2010, con inediti e rarities, che copre questo periodo, che si può definire il migliore per i dischi di studio, anche se all’epoca i dischi uscirono ancora per la Deram e il solo A Space in Time, negli USA uscì per la Columbia. Occorre precisare che nessuno dei dischi dei Ten Years After si può definire memorabile, ci sono tre o quattro brani molto buoni e il resto meno, ma se ne dovessimo scegliere due o tre, i migliori vengono da questo periodo. Ssssh.***1/2uscito ancora nel 1969, nello stesso mese di Woodstock, in poco più di 37 minuti presenta la svolta rock-blues chitarristica che avrebbe fatto la fortuna del gruppo: Good Morning Little Schoolgirl, eseguita anche al Festival, era una feroce rivisitazione di un classico, sempre dal repertorio di Sonny Boy Williamson, Bad Scene, Two Time Mama e I Woke Up This Morning sono tra le migliori del loro repertorio e Stoned Woman è un altro inno allo “sballo”, figlia del periodo.
Anche il successivo Cricklewood Green***1/2 è tra i migliori in assoluto della discografia e contiene Love Like A Woman, il veicolo per uno dei migliori assolo della carriera di Alvin Lee, oltre ad una serie di brani solidi e vibranti, mentre Watt*** è un mezzo passo falso, uscito come il precedente nel 1970, perché in quegli anni se ne pubblicavano almeno due per anno, risentito oggi è comunque meglio di come lo ricordavo, My Baby Left Me, She Lies In The Morning e un altro R&R primo amore, Sweet Little Sixteen dal vivo, fanno la loro porca figura. A Space In Time***1/2 del 1971, è l’album della svolta pop-rock, alla ricerca del mercato americano, I’d Love To Change The World è un ottimo singolo elettroacustico, che sarà il loro maggior successo, e anche gli altri brani introducono questo suono delle chitarre acustiche, probabilmente influenzato dal sound dei Led Zeppelin di quell’anno, che mescolava il rock a momenti più intimisti.
Da qui in avanti, peraltro solo per due album, Rock And Roll Music To The World del ’72 e Positive Vibrations del 1974, inizia la china discendente prima dello scioglimento nello stesso anno, inframmezzata da sempre eccellenti esibizioni live (anche al Palalido di Milano, mi pare nella primavera del ’71, io c’ero e lo ricordo, apriva la Mick Abrahams Band, ma qualche pirla mi aveva ciulato il posto numerato sul parterre per cui è una memoria agrodolce). In ogni caso il doppio Recorded Live ***1/2, uscito nel 1973 e Recorded Live At Fillmore East 1970****, pubblicato postumo nel 2001 su CD, sono assolutamente da avere, come l’ottimo disco solo country-rock-blues-gospel On The Road To Freedom***1/2 in coppia con Mylon LeFevre, pubblicato nel 1973 e bissato nel 2012 con Still On The Road to Freedom, l’ultimo disco bello della sua discografia, dopo una lunga serie di album, anche piacevoli, compresa qualche reunion, guidati soprattutto dal mestiere.
Ed ora, il 6 marzo del 2013 ci ha raggiunto la notizia della sua morte, per le complicazioni dopo una operazione di routine (si dice così) che solo da poco si è scoperto essere avvenuta in Spagna. Possiamo solo dirgli grazie di tutto e Rest In Peace.
Bruno Conti