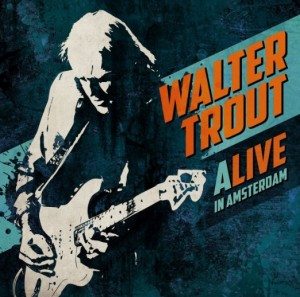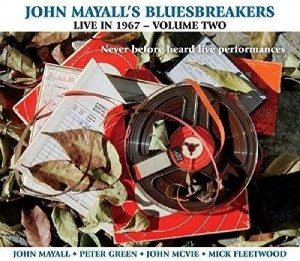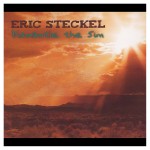John Mayall – The First Generation 1965-1974 – Madfish/Snapper 35CD Box Set
Verso la fine del 2020 era uscito l’annuncio che la Madfish, etichetta inglese specializzata in cofanetti retrospettivi di gran lusso (ricordo di recente quelli dedicati a Gentle Giant e Wishbone Ash), avrebbe pubblicato all’inizio di quest’anno The First Generation 1965-1974, enorme box di 35 CD che riepiloga i primi dieci anni di carriera (cioè i migliori) del grande John Mayall. Non credo sia il caso di descrivere ancora una volta l’importanza di Mayall nella storia della musica: definito a ragione “The Godfather of British Blues”, oltre ad essere un notevole musicista a 360 gradi (cantante, armonicista, pianista, chitarrista ritmico e songwriter) e ad aver pubblicato più di un album passato giustamente alla storia, è stato anche capace di scovare talenti ospitandoli a suonare sui suoi dischi spesso prima che questi diventassero famosi. I casi più eclatanti sono quelli di Eric Clapton, Peter Green e Mick Taylor ben prima che si facessero un nome rispettivamente con Cream, Fleetwood Mac e Rolling Stones, ma negli anni John ha suonato anche con John McVie (anche lui da lì a poco fondatore dei Fleetwood Mac), Larry Taylor e Harvey Mandel poi nei Canned Heat, il noto batterista Aynsley Dunbar, il chitarrista Jon Mark ed il sassofonista Johnny Almond (che nei seventies avranno un buon successo come duo a nome Mark/Almond) ed anche in breve con Jack Bruce e Mick Fleetwood: per una disamina più dettagliata della discografia ufficiale di John vi rimando però all’ottima retrospettiva di Bruno pubblicata su questo blog nel 2019 https://discoclub.myblog.it/2019/05/20/john-mayall-retrospective-il-grande-padre-bianco-del-blues-parte-i/ e https://discoclub.myblog.it/2019/05/21/john-mayall-retrospective-il-grande-padre-bianco-del-blues-parte-ii/ .
Sinceramente sono stato combattuto per alcune settimane se acquistare o no questo box, più che altro per il prezzo di 275 sterline (più spedizione ed impostazione) dato che io di Mayall possedevo i lavori più recenti e solo un paio di cose risalenti alla “golden age”. Devo dire però che il sacrificio economico non è stato vano (tra l’altro il box, stampato in 5000 copie, è ancora disponibile su uno dei due canali ufficiali, ma occhio ai vari siti dove viene rivenduto quasi al doppio), in quanto The First Generation 1965-1974 è un manufatto formidabile, un cofanetto importante anche nelle dimensioni, con un bellissimo libro rilegato di 168 pagine pieno di foto, scritti e note, alcuni pezzi di memorabilia e, come ciliegina, una foto autografata dallo stesso Mayall. I CD della sua discografia ufficiale sono stati tutti rimasterizzati e presentati in confezioni simil-LP, in molti casi con bonus tracks aggiunte (non inedite, ma le stesse già presenti in precedenti ristampe), un paio di CD singoli che riportano altrettanti 45 giri di inizio carriera (I’m Your Witchdoctor/Telephone Blues e Lonely Years/Bernard Jenkins) ed il raro EP All My Life registrato con Paul Butterfield, che se non erro è la prima volta che esce su CD come entità a sé stante.
A parte la retrospettiva di Bruno di cui sopra, lasciatemi aggiungere che qui per un neofita c’è da godere assai, in quanto tra i vari album ci sono almeno due capolavori assoluti (il famoso Blues Breakers con Clapton, e A Hard Road con Green) e tanti altri dischi da non meno di quattro stellette (Crusade, Bare Wires, Blues From Laurel Canyon, gli strepitosi live The Turning Point e Jazz Blues Fusion), oltre ai classici “personal favorites” (The Blues Alone, Empty Rooms, Back To The Roots). In questa recensione vorrei soffermarmi principalmente sul materiale inedito del box, che consiste in uno strepitoso doppio CD intitolato BBC Recordings ed in una serie di concerti mai pubblicati prima che occupa i sette dischetti finali. BBC Recordings è, come accennato poc’anzi, un mezzo capolavoro, che chi non ha comprato il box perché già possedeva tutta la discografia ufficiale di Mayall meriterebbe di vedere pubblicato a parte (ma con la Madfish so già che non sarà così).
Si tratta di sessions inedite registrate presso gli studi della mitica emittente britannica dal 1965 al 1968 e messe in onda in programmi popolarissimi come Saturday Club e Top Gear, dove ritroviamo insieme a Mayall parecchi dei nomi citati ad inizio recensione: Clapton, Green, Taylor, Bruce e McVie, oltre ai noti batteristi Colin Allen e Keef Hartley. Due ore complessive di musica, registrata perlopiù in mono, con un suono che varia dal discreto al buono anche se qualche incisione sotto la media c’è. Nel primo CD ci sono ben 13 brani con Clapton alla solista, tra i quali spiccano la vivace Crawling Up A Hill, con un breve ma ficcante assolo di Manolenta, la sinuosa Crocodile Walk, la coinvolgente Bye Bye Bird, con una prestazione maiuscola di Mayall all’armonica, una Hideaway di Freddie King ricca di swing e con Eric che arrota da par suo, il magnifico slow blues Tears In My Eyes, che vede Clapton in modalità “God” https://www.youtube.com/watch?v=kHeJ1lHh2jo , la classica All Your Love di Otis Rush e la pimpante Key To Love. In mezzo abbiamo cinque pezzi con alla chitarra il poco noto Geoff Krivit ma con Jack Bruce al basso: da segnalare l’arrochita Cheatin’ Woman, https://www.youtube.com/watch?v=qefVuAMu2Eo una strepitosa Parchman Farm di Mose Allison, con il basso di Bruce come strumento solista, e la jazzata Nowhere To Turn.
Il primo dischetto si chiude così come si apre il secondo, e cioè con Peter Green come axeman (sette brani totali): imperdibili il saltellante country-blues Sitting In The Rain, l’ottimo strumentale Curly (in due diverse versioni), scritto da Green stesso e con le sue dita grandi protagoniste e le splendide Ridin’ On The L And N (Lionel Hampton) e Dust My Blues (Elmore James), entrambe con Greeny alla slide. Le restanti canzoni vedono Mick Taylor alla solista ed in molti casi una sezione fiati a dare più corpo al suono, e qui il meglio lo abbiamo con la suadente e sensuale Worried Love, il potente rock-blues strumentale Snowy Wood, la lenta e raffinata Another Man’s Land, con il sax di Chris Mercer a duettare con la slide di Mick, il blues-jazz Knockers Step Forward, che vede il futuro Rolling Stone rilasciare un assolo sensazionale e la roboante Long Gone Midnight, con la chitarra in modalità wah-wah.
Infine veniamo alle dolenti note del box (le magagne del titolo), che riguardano gli ultimi sette dischetti riportanti altrettanti concerti dal vivo, o parti di essi (nel dettaglio: Bromley Technical College 1967, Live 1967, registrato in varie locations, 7th National Jazz & Blues Festival 1967, Gothenburg 1968, Berlin 1969, Bremen 1969 e Fillmore West 1970). Tutti show reputati di altissimo profilo…peccato che si faccia una fatica boia ad ascoltarli! Sì perché, in nome del caro vecchio “valore storico”, il box ci propina una serie di CD registrati letteralmente coi piedi (per non dire di peggio), un suono da bootleg di bassissima qualità che rende praticamente impossibile quando non fastidioso l’ascolto, e siccome non stiamo parlando di album di dubbia legalità tratti da concerti radiofonici ma di un cofanetto che viene fatto strapagare, mi sento anche un po’ preso per il culo (possibile che negli archivi non ci fosse qualcosa di inciso meglio?).
In tutta onestà devo dire che questo discorso si applica sicuramente per i primi cinque CD (quello di Gothenburg all’inizio mi aveva dato qualche speranza, peccato però che la voce non si senta quasi per niente), mentre quelli di Brema e Fillmore West sono incisi in maniera più che accettabile, e quindi sono gli unici che sono riuscito ad ascoltare senza farmi venire la voglia di gettare il CD dalla finestra, apprezzando una stratosferica Parchman Farm di 14 minuti dallo show tedesco e, da quello di San Francisco, i 21 minuti totali della lenta e cadenzata What’s The Matter With You e del puro blues Travelling Man. Un cofanetto che, a parte la macchia indelebile di gran parte dei contenuti inediti che anche se restavano tali era meglio, contiene una bella fetta di storia del blues, anche se il tutto viene fatto pagare a carissimo prezzo.
Marco Verdi