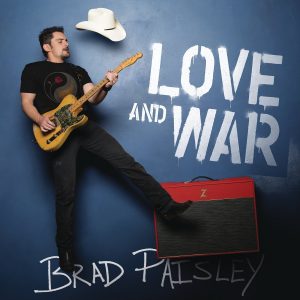Chip Taylor – Last Chance: The Warner Bros Years – Train Wreck 2 CD+DVD
James Wesley Voight, per tutti Chip Taylor, è il fratello dell’attore Jon Voight e quindi lo zio di Angelina Jolie, ed è stato, nelle sue varie vite musicali, prima autore di canzoni di grande successo negli anni ’60, due per tutte, Angel Of The Night, portata al successo da Merrilee Rush una prima volta nel 1967 e poi di nuovo nel 1981 da Juice Newton, e l’anno precedente Wild Thing, cantata dai Troggs, ma celebre anche nella versione memorabile di Jimi Hendrix al Monterey Pop Festival. Però in effetti la carriera di Chip Taylor è soprattutto legata alla musica country, anche se iniziò a pubblicare 45 giri di R&R come Wes Voight and the Town Three già nel 1958. Originario di Yonkers, New York, la sua carriera solista si avvia proprio all’alba degli anni ’70 con un paio di album in trio, a nome Gorgoni, Martin & Taylor, pubblicati dalla Buddah Records nel 1971 e ’72, più orientati sul country/folk, poi il suo primo disco solo Gasoline, sempre del 1972 su Buddah, dove c’era la sua versione di Angel Of The Morning. A questo punto arriva la proposta di un contratto dalla Warner Bros che vorrebbe lanciare una propria divisione country (e il “successo” arriderà con Emmylou Harris) e Chip Taylor, che aveva pronte molte canzoni decisamente orientate su quel genere, si trova uno studio di registrazione, non a Nashvile, ma a Fayville, Massachussetts e registra quello che con una notevole dose di autoironia (e rassegnazione) si chiamerà Chip Taylor’s Last Chance.
https://www.youtube.com/watch?v=ICP1Y9FUPpY
Quasi tutti conoscono Taylor per la terza fase della sua carriera, quella iniziata a metà anni ’90, dopo lunghi anni passati come giocatore d’azzardo professionista, e culminata in una splendida serie di album pubblicati, prima in coppia con Carrie Rodriguez e poi in proprio, e che prosegue tuttora con eccellenti risultati, alla ragguardevole età di 77 anni. Comunque quei tre album erano già ottimi, oltre a quello citato, uscito nel 1973, Some Of Us del 1974 e This Side Of The Big River del 1975, con uno stile influenzato dall’outlaw country in auge all’epoca, ma anche vicino a cantautori come Townes Van Zandt, Jerry Jeff Walker e Guy Clark, e pure a livelli qualitativi ci siamo. Come racconta lo stesso Chip nelle esaustive, affettuose (e divertenti) note riportate nel libretto di questo triplo (ma attenzione i primi due dischi sono stati ristampati in un 2in1 anche dalla Morello Records nel 2016), Taylor rischiò, e in parte ci riuscì, di diventare una sorta di superstar country in Svezia ed in Olanda; nella nuova edizione, molto bella, pubblicata dalla Train Wreck, oltre ai dischi troviamo anche un DVD inedito, registrato all’ Armadillo World Headquarters di Austin, Texas nel 1973 (presumo recuperato da qualche vecchia VHS dei tempi, visto che il filmato è in bianco e nero e la qualità è quasi ai limiti della decenza, con le immagini che ogni tanto partono per la tangente, anche se la musica è ottima). Nei tre dischi di studio Chip Taylor è accompagnato da una band eccellente, dove brillano John Platania, in quegli anni chitarra solista anche nei dischi di Van Morrison, il bravissimo Pete Drake, alla steeel guitar, che suonava all’epoca con tutti, da Bob Dylan e Simon & Garfunkel alle stelle del country, nonché a David Grisman al mandolino e ai Jordanaires ai cori.
https://www.youtube.com/watch?v=YaZzUGoi6HA
I tre album sono tutti molti buoni, costellati da bellissime canzoni, il suono è a tratti splendido e se dovessi esprimere una preferenza opterei per Last Chance, con ballate veramente evocative, in cui il nostro ha sempre brillato, come Son Of A Rotten Gambler, The Coal Fields Of Shikshinny, I’m Still The Same, la struggente Family Of One ed il valzerone della title track, degno delle più belle canzoni dell’epoca di Willie Nelson, oltre a splendide country songs più mosse, quasi ai limiti dell’honky tonk, con i tre solisti citati spesso in evidenza, anche in quelle che all’epoca si chiamavano “answer songs”, per esempio 101 In Cashbox, sulla storia di Angel Of The Morning, e ancora (I Want) The Real Thing che ricorda il sound di Jim Croce, oppure I Read It In Rolling Stone, una outlaw soung che Waylon Jennings e Johnny Cash avrebbero cantato a meraviglia, del tutto pari a quanto scriveva Kris Kristofferson in quei tempi. E comunque anche gli altri due dischi sono decisamente buoni: Me As I Am, Early Sunday Morning, Something ‘Bout The Way This Story Ends, Comin’ From Behind, If You’re Ever In Warsaw, da Some Of Us, anche se a tratti appesantite dagli archi sono comunque belle canzoni, e pure Big River, l’unica cover, dal repertorio di Johnny Cash, tratta dal terzo album, oppure la deliziosa Same Ol’ Story, il quasi gospel malinconico di Holding Me Together, la delicata Gettin’ Older Looking Back, la conclusiva splendida You’re Alright Charlie o un’altra bellissima ballata alla Nelson come Sleepy Eyes testimoniano di un cantautore che faceva della country music di qualità già allora, sia pure meno “roots” di quella odierna e che quindi meriterebbe più di un ascolto dagli appassionati del genere (e di Chip Taylor).
Bruno Conti