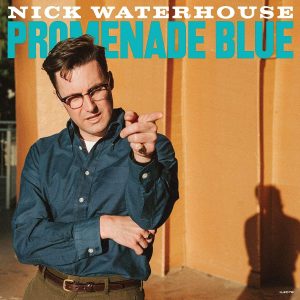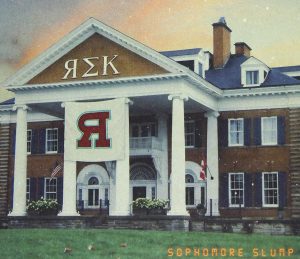Nick Waterhouse – Promenade Blue – Innovative Leisure CD
Nick Waterhouse è un singer-songwriter californiano di Santa Ana attivo più o meno dal 2010, al quale però mi sono avvicinato solo nel 2019 grazie al suo quarto album, l’omonimo Nick Waterhouse, un piacevole e riuscito dischetto che mescolava sonorità vintage passando dal soul al rockabilly al pop al rhythm’n’blues con grande disinvoltura. Promenade Blue, il suo nuovissimo lavoro, è ancora meglio: Nick è uno di quei musicisti idealmente fermi ancora agli anni 60, e le sue canzoni riflettono in toto tale influenza. Cantante valido ed espressivo ed autore di vaglia, Waterhouse in Promenade Blue accentua ulteriormente il discorso intrapreso con il suo penultimo album, proponendo undici deliziose canzoni in bilico tra blue-eyed soul, errebi e pop con un pizzico di rock’n’roll ed una spruzzata di jazz e swing, un tipo di musica che a modo suo risulta californiana al 100%. Anzi, io mi immagino di ascoltare il disco su una terrazza che si affaccia sul mare della California del sud al tramonto, con in mano un bel cocktail variopinto (in mancanza di ciò, lavorate di fantasia come ho fatto io).
Registrato a Memphis e co-prodotto da Nick insieme a Paul Butler (dietro la consolle nei lavori di Michael Kiwanuka), Promenade Blue vede sfilare una lunga schiera di musicisti proprio come si usava fare nei sixties (tutti nomi peraltro abbastanza sconosciuti), con sezione ritmica, chitarre, piano, organo, marimba e la presenza sia di una sezione fiati che una di archi. Una sorta di muro del suono di ispirazione spectoriana, come nell’iniziale Place Names, incantevole pop song dove tutto profuma di anni 60, dalla melodia romantica alle backing vocalist femminili fino al sapiente uso degli archi. La saltellante The Spanish Look sembra, non scherzo, una outtake dei Coasters appena riscoperta, un piccolo gioiello tra errebi e doo-wop con un tocco jazzato che rimanda alla stagione d’oro dei vocal groups; Vincentine è puro soul, con Nick che mostra di avere una duttilità vocale non indifferente e la band lo segue che è una meraviglia, con i fiati a comandare il suono. Con Medicine siamo dalle parti di Ben E. King, un pezzo con il basso in primo piano, una chitarrina con riverbero d’ordinanza, cori maschili e sax come ciliegina: davvero, se non sapessi cosa sto ascoltando penserei di avere per le mani qualche vecchio padellone targato Motown o Atlantic.
Very Blue cambia registro, in quanto è una maestosa pop song alla Roy Orbison, con lo stesso tipo di pathos delle incisioni di “The Big O” anche se l’estensione vocale è ovviamente diversa, mentre con Silver Bracelet torniamo in territori black con un’altra perfetta soul song dalla melodia d’altri tempi che vede sassofono e piano sugli scudi. Proméne Bleu è l’unico strumentale del CD, un raffinatissimo pezzo lounge-jazz da nightclub con la chitarra elettrica protagonista ed il sax che arriva per chiudere la canzone; con Fugitive Lover e Minor Time si torna dalle parti dei gruppi vocali di colore con un brano coinvolgente dalla ritmica accesa nel primo caso ed una sorta di gospel cadenzato nel secondo, con la presenza quasi esclusiva di voci e percussione. Finale con la pimpante B. Santa Ana, 1986 (il pezzo più “moderno”, quasi un rock’n’roll con organo alla Doors) e con la gustosa To Tell, in cui il nostro manifesta di avere anche Dion & The Belmonts tra le sue influenze.
Marco Verdi