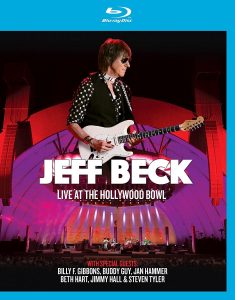Eric McFadden – Pain By Numbers – Whiskey Bayou Records
Intrigato dal bellissimo album di Damon Fowler, prodotto da Tab Benoit per la propria etichetta Whiskey Bayou Records https://discoclub.myblog.it/2018/11/13/uno-dei-dischi-rock-blues-piu-belli-dellanno-damon-fowler-the-whiskey-bayou-session/ , mi sono andato a vedere il piccolo catalogo della etichetta di New Orleans, e tra i 5 nomi sotto contratto (forse) uno di quelli che mi ha incuriosito più era il nominativo di Eric McFadden, cantante e chitarrista di colore con una cospicua carriera discografica alle spalle ( e anche in ulteriore sviluppo, visto che in questo periodo ha pubblicato per una etichetta francese anche un piacevole e raffinato tributo acustico agli AC/DC https://www.youtube.com/watch?v=VTa0Aq2qrLo ), del quale mi pareva di avere recensito qualcosa in passato per il Buscadero. Lo stile dei dischi precedenti, al di là di qualche disco acustico, di solito è un alternative rock abbastanza tirato con elementi blues e jam, in virtù di sue collaborazioni varie con musicisti del giro Fishbone, Widespread Panic, Mars Volta, Cake, ma anche collaborazioni passate con George Clinton e con Eric Burdon, oltre a diversi tour con Anders Osborne, il musicista svedese che è una delle glorie della attuale New Orleans.
Quindi forse è sembrato quasi inevitabile che McFadden unisse le forze con Tab Benoit, altro cittadino di New Orleans. per registrare un disco rock-blues e a tratti anche roots oriented, benché sempre con venature rock molto energiche, per quanto sempre di buona qualità e perciò con un sound abbastanza differente da quello di Fowler. Ovviamente negli orientamenti sonori di Eric c’è anche una buona dose di funky, una passione per il rock hendrixiano e il blues “sporco”, ma nell’insieme, anche grazie al lavoro di produzione di Benoit, che suona pure l’organo in tutto il disco, il risultato è piacevole: poi il resto lo fa un power trio poderoso, dove il bassista Doug Wimbish, giro Living Colour, ma uno che ha suonato dal rap al funk al metal con chiunque, e il batterista Terence Higgins della Dirty Dozen Brass Band, come pure in azione con Ani DiFranco e Warren Haynes, sono una sezione ritmica versatile in grado di spaziare in generi diversi. Le canzoni sono firmate tutte dallo stesso McFadden, con qualche aiuto qui e là, e vanno dal rock-blues roccioso e cattivo dell’iniziale While You Was Gone, dal ritmo cadenzato e con le folate della solista ingrifata di Eric, che potrebbero rimandare ad un altro rocker “colored” come Eric Gales, passando per il roots-rock raffinato di Love Come Rescue Me, dove grazie all’organo “scivolato” di Benoit, gli elementi di soul e Americana music sono più evidenti e la chitarra lavora di fino. In The Girl Has Changed il trio torna a picchiare di gusto a tutto riff, dopo l’interlocutoria Long Gone, mentre la lunga Skeleton Key è un altro hard blues massiccio di quelli hendrixiani, con la chitarra in overdrive e interscambi infuocati con il basso di Wimbish.
I Never Listened To Good è un’oasi gentile con l’acustica arpeggiata di McFadden che racconta di rimpianti e lezioni imparate duramente, a tempo di folk-blues; So Hard To Leave è il classico slow torrido che non può mancare in un disco prodotto da Benoit, che con il suo organo sostiene anche le evoluzioni vibranti della solista del nostro amico https://www.youtube.com/watch?v=fymsqwRrOxU . If I Die Today è un boogie-rock sudista spinto a tutta velocità dalle parti di ZZ Top, di Johnny Winter o dei Supersonic Blues Machine di Lance Lopez, altro chitarrista che predilige il blues-rock duro e cattivo, Fool Your Heart è un rock più leggero ed orecchiabile, quasi radiofonico, ma comunque di buona fattura. The Jesus Gonna See You Naked è un altro pezzo rock con qualche elemento gospel, su una scorza sempre dura benché con qualche apertura più melodica, con la successiva Don’t Wanna Live, una vorticosa cavalcata che potrebbe ricordare il Ben Harper o l’Anders Osborne più rock, anche dalle parti dei North Mississippi Allstars e con la chitarra in vena di numeri solistici non indifferenti, mentre la ritmica lavora in modo turbolento https://www.youtube.com/watch?v=aSxEbr8zzlM . In chiusura Cactus Juice, un pezzo strumentale in simil flamenco di impronta elettroacustica, che se non c’entra un tubo con tutto il resto conferma le notevoli doti di virtuoso della chitarra di Eric McFadden, in ricordo dei suoi anni passati in Spagna a studiare la materia. Nel complesso comunque un buon album, se amate il genere,
Bruno Conti