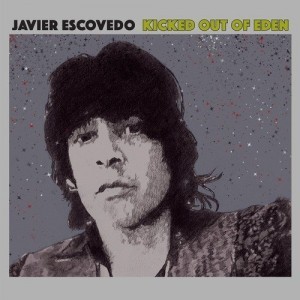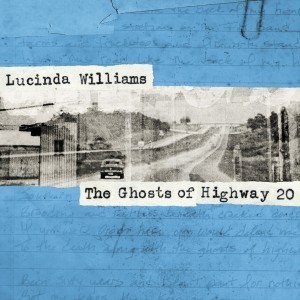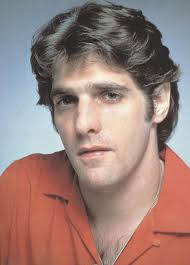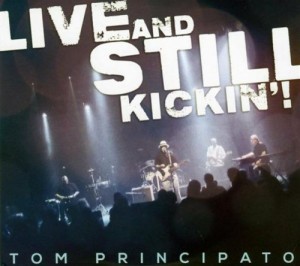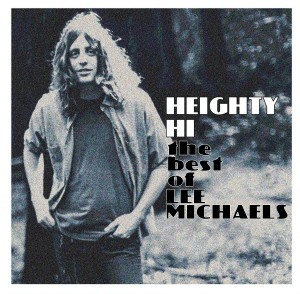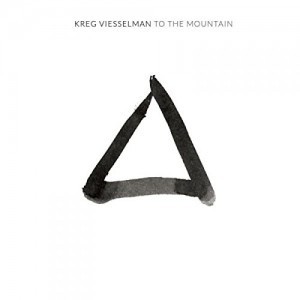 Kreg Viesselman – To The Mountain – Appaloosa / IRD Dopo il meraviglioso (e inaspettato) The Pull (07), e il successivo If You Lose Your Lighjt (13) di cui si era parlato a suo tempo su questo blog http://discoclub.myblog.it/2014/01/28/storyteller-fuga-verso-il-freddo-nord-kreg-viesselman-if-you-lose-your-light/ , arriva sul mio lettore il nuovo lavoro di questo bravo cantautore originario del Minnesota, ormai da anni adottato artisticamente dalla Norvegia, un paese che è diventato l’esilio dorato anche per altri artisti di spessore come Eric Andersen, Chip Taylor, il Tom Russell di Atzec Jazz (registrato con la Norwegian Wind Ensemble), e altri della nuove e ultime generazioni, tipo Chris Mills http://discoclub.myblog.it/2014/02/08/la-fuga-verso-il-freddo-nord-continua-chris-mills-the-distant-stars-alexandria/ oltre al suddetto Kreg Viesselman. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura, troviamo la sua attuale band, una line-up formata da Anne Lise Frokedal alla chitarra acustica, elettrica e voce, Sondre Meisfjord al basso, il fidato Oystein Hvamen Rasmussen alla batteria e percussioni, Bard Ingebrightsen alle tastiere, Goran Grini al piano, Mari Persen al violino, con il contributo di Peter O’Toole (dei grandi e non dimenticati Hothouse Flowers) al bouzouki, e la brava Ingrid Berge alle armonie vocali, con la produzione del duo Kristiansen e Ingerbrightsen negli studi Klang di Oslo. https://www.youtube.com/watch?v=NdRKmfmgmE0 Chiariamo subito che, a mio parere, To The Mountain non è al livello di The Pull, e forse nemmeno del “sound” con chitarra e piano in evidenza di If You Lose Your Light, ma a Greg bastono poche e suadenti note per catturare e affascinare l’ascoltare, a partire dal trittico iniziale di brani: prima con il folk moderno di Garland, il duetto con Anne Lise Frokedal in una tenue e medioevale David, i coretti soul che accompagnano una Crazy Horse che ricorda il suo amico Ray LaMontagne, passando poi alla melodia acustica di Honeycomb, e cambiando ritmo con il folk arioso di Our Sun Rose, e la trascinante The Disciple Song (Summer Leaves), senza dubbio il brano più intrigante del lavoro. Se i brani sono toccanti, il merito è anche della voce fumosa e malinconica di Kreg, per esempio nella breve I Speak Loud (You Speak Louder) e nella deliziosa pop-song In The Summer In Oslo, con un bel lavoro di piano e tromba, nell valzer lento e cadenzato di The Inefficiency Waltz, andando infine a chiudere con la melanconica Demons e la bucolica title-track To The Mountain, dove i violini accompagnano il tessuto sonoro complesso della canzone. https://www.youtube.com/watch?v=K1kGklJwKuw Leggo su molte riviste di settore che il buon Kreg viene assimilato al “primo” Van Morrison, ma (per chi scrive) del “grande vecchio” di Belfast mi sembra abbia pochino, piuttosto mi sembra più giusto segnalare che la sua musica rimanda a vecchi maestri folk come Bob Dylan, Tim Buckley e Tim Hardin, ma con le sonorità e le tematiche contemporanee che rispondono anche ai cantautori delle nuove generazioni (uno su tutti che mi viene in mente e si è perso per strada, Eric Wood). https://www.youtube.com/watch?v=wp8rb3gWyw0 Kreg Viesselman negli anni è cresciuto passo dopo passo, diventando un artista di culto in paesi come Olanda, Germania e in misura minore anche in Italia, con canzoni che non hanno nulla di innovativo, ma hanno abbastanza anima di scaldare il cuore agli amanti della buona musica. NDT: Come sempre la meritoria Appaloosa, in esclusiva per il mercato italiano, pubblica il disco con tutti i testi e le traduzioni accluse. Tino Montanari
Kreg Viesselman – To The Mountain – Appaloosa / IRD Dopo il meraviglioso (e inaspettato) The Pull (07), e il successivo If You Lose Your Lighjt (13) di cui si era parlato a suo tempo su questo blog http://discoclub.myblog.it/2014/01/28/storyteller-fuga-verso-il-freddo-nord-kreg-viesselman-if-you-lose-your-light/ , arriva sul mio lettore il nuovo lavoro di questo bravo cantautore originario del Minnesota, ormai da anni adottato artisticamente dalla Norvegia, un paese che è diventato l’esilio dorato anche per altri artisti di spessore come Eric Andersen, Chip Taylor, il Tom Russell di Atzec Jazz (registrato con la Norwegian Wind Ensemble), e altri della nuove e ultime generazioni, tipo Chris Mills http://discoclub.myblog.it/2014/02/08/la-fuga-verso-il-freddo-nord-continua-chris-mills-the-distant-stars-alexandria/ oltre al suddetto Kreg Viesselman. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura, troviamo la sua attuale band, una line-up formata da Anne Lise Frokedal alla chitarra acustica, elettrica e voce, Sondre Meisfjord al basso, il fidato Oystein Hvamen Rasmussen alla batteria e percussioni, Bard Ingebrightsen alle tastiere, Goran Grini al piano, Mari Persen al violino, con il contributo di Peter O’Toole (dei grandi e non dimenticati Hothouse Flowers) al bouzouki, e la brava Ingrid Berge alle armonie vocali, con la produzione del duo Kristiansen e Ingerbrightsen negli studi Klang di Oslo. https://www.youtube.com/watch?v=NdRKmfmgmE0 Chiariamo subito che, a mio parere, To The Mountain non è al livello di The Pull, e forse nemmeno del “sound” con chitarra e piano in evidenza di If You Lose Your Light, ma a Greg bastono poche e suadenti note per catturare e affascinare l’ascoltare, a partire dal trittico iniziale di brani: prima con il folk moderno di Garland, il duetto con Anne Lise Frokedal in una tenue e medioevale David, i coretti soul che accompagnano una Crazy Horse che ricorda il suo amico Ray LaMontagne, passando poi alla melodia acustica di Honeycomb, e cambiando ritmo con il folk arioso di Our Sun Rose, e la trascinante The Disciple Song (Summer Leaves), senza dubbio il brano più intrigante del lavoro. Se i brani sono toccanti, il merito è anche della voce fumosa e malinconica di Kreg, per esempio nella breve I Speak Loud (You Speak Louder) e nella deliziosa pop-song In The Summer In Oslo, con un bel lavoro di piano e tromba, nell valzer lento e cadenzato di The Inefficiency Waltz, andando infine a chiudere con la melanconica Demons e la bucolica title-track To The Mountain, dove i violini accompagnano il tessuto sonoro complesso della canzone. https://www.youtube.com/watch?v=K1kGklJwKuw Leggo su molte riviste di settore che il buon Kreg viene assimilato al “primo” Van Morrison, ma (per chi scrive) del “grande vecchio” di Belfast mi sembra abbia pochino, piuttosto mi sembra più giusto segnalare che la sua musica rimanda a vecchi maestri folk come Bob Dylan, Tim Buckley e Tim Hardin, ma con le sonorità e le tematiche contemporanee che rispondono anche ai cantautori delle nuove generazioni (uno su tutti che mi viene in mente e si è perso per strada, Eric Wood). https://www.youtube.com/watch?v=wp8rb3gWyw0 Kreg Viesselman negli anni è cresciuto passo dopo passo, diventando un artista di culto in paesi come Olanda, Germania e in misura minore anche in Italia, con canzoni che non hanno nulla di innovativo, ma hanno abbastanza anima di scaldare il cuore agli amanti della buona musica. NDT: Come sempre la meritoria Appaloosa, in esclusiva per il mercato italiano, pubblica il disco con tutti i testi e le traduzioni accluse. Tino Montanari
Archivio mensile:gennaio 2016
Del Sano Rock Americano Da Un Nome “Familiare”! Javier Escovedo – Kicked Out Of Eden
Javier Escovedo – Kicked Out Of Eden – Saustex Records
Ovviamente quello familiare, in questo caso, è il cognome; Javier Escovedo fa parte di una sorta di dinastia, i fratelli Pete e Coke, entrambi percussionisti, il secondo a lungo con i Santana, la nipote Sheila E., che grazie alla liaison con Prince ha avuto i suoi 15 minuti di notorietà, ma soprattutto l’altro fratello Alejandro, il più famoso (e anche il più bravo) con cui ha fondato, più o meno a metà anni ’80, i True Believers, una delle band più interessanti e sfortunate del periodo, dalla storia discografica travagliatissima, che non ripercorriamo per l’occasione https://www.youtube.com/watch?v=lF0TUs361Ik . I due fratelli Escovedo venivano entrambi da un background punk, Alejandro, prima nei Nuns e poi con il cow-punk dei Rank And File, Javier con i Zeros, anche loro tra i precursori del movimento punk della West Coast. Nei True Believers i due fratelli si dividevano i compiti sia alla chitarra come alla voce, con una front line poi ampliata dall’ingresso di Jon Dee Graham, e Javier era un “socio” alla pari: bella voce, chitarra “pesante”, buona penna, anche se poi allo scioglimento del gruppo si sono perse le sue tracce per vari problemi legati alle sue dipendenze da sostanze varie. Agli inizi degli anni 2000, dopo un periodo di “riabilitazione”, finalmente riesce ad eliminare i suoi demoni, ma prima di pubblicare il suo primo album solista bisogna arrivare al 2012 quando esce City Lights, un buon disco di rock californiano alternativo, di cui francamente mi ero perso l’uscita.
Ora, ad inizio 2016, esce questo Kicked Out Of Eden, 9 brani per circa mezz’ora di musica, ma l’aria di famiglia non si è persa: tra sventagliate rock, riff granitici, ma anche ballate di spessore Javier Escovedo si conferma (o meglio si rivela) come autore e rocker da tenere d’occhio, niente di indimenticabile, solo del sano rock da gustare con piacere in questo inizio d’anno: coadiuvato da una band dove il chitarrista è Brad Rice, uno che ha suonato nella Keith Urban Band, ma anche con Jason Boland e nei Whiskeytown, al basso si alternano Joe Bass (con quel nome), già con Posies, Walkabouts e Lake Street Dive, e Tom Kitsos e Michael Traylor, Matt Hubbard, che forse qualcuno ricorda nei 7 Walkers, è alle tastiere, dove si alterna con Brian Le Barton, pure lui con una lista di collaborazioni lunga come le pagine gialle, se ci fossero ancora. e non abbiamo citato i batteristi, ce ne sono tre, di cui il più noto è Hector Nunoz, presente in quasi tutti i dischi di fratel Alejandro. Aggiungiamo i cantautori Eric Hisaw e Chrissy Flatt e il risultato è un disco disco solido che si apre sulla tiratissima Downtown, dal riff che ti becca sui denti a tempo di boogie e rock, grazie al dualismo chitarra-piano e alla voce grintosa di Javier, tra Georgia Satellites e i gloriosi True Believers, ancora più evidente quando le chitarre cominciano a ruggire nella parte centrale del brano, e anche It Ain’t Easy non scherza a livello rock, una slide si aggiunge, con un tocco bluesy, come pure la voce femminile di Chrissy Flatt, mentre il pianino intrigante non demorde e il sound è quasi stonesiano. Beaujolais ha un suono più denso e garage, grazie all’organo che prende il post del piano, mentre le chitarre continuano a deragliare con grinta e potenza macinando riff e soli senza pietà. Drivin’ Around, viceversa, è un bellissimo mid-tempo, una sorta di ballata vagamente country, più gentile e melodica dei brani che l’hanno preceduta, ma sempre ricca di qualità musicali, grazie anche agli intrecci sonori delle armonie vocali, molto raffinate.
Molto bella anche Just Like All The Rest, un brano byrdsiano, grazie al jingle-jangle delle chitarre e alla voce alla McGuinn di Escovedo, poi si ritorna al rock con la poderosa Just Like All The Rest, dalla costruzione sonora che potrebbe ricordare i Replacements, ma anche alcune cose dei True Believers, loro contemporanei, e, perché no, anche gli Stones, “babbi” di tutti, comunque lo prendi, altro gran bel brano. Diciamo che la parte centrale del disco è la migliore, ma anche Bad And Good, che urla “viulenza” con le sue chitarre cattive e la batteria in overdrive non fa calare la tensione, Poi ribadita in una Gypsy Son che non ha nulla da invidiare agli episodi più duri di Green On Red o Dream Syndicate e che ha un riff di chitarra (e non solo quello) che mi ha ricordato Paranoid dei Black Sabbath https://www.youtube.com/watch?v=uKfVeVTopJY . La conclusione è affidata a Searchin’ For You, ballatona elettroacustica che potrebbe ricordare tanto alcuni brani di Elliott Murphy, molto bello l’uso della doppia tastiera e della chitarra acustica, quanto i brani più raccolti del fratello Alejandro, in ogni caso altra canzone sopra la media. Cataloghiamo sotto sorprese di inizio anno (e ce ne saranno altre nei prossimi giorni, visto che ho individuato alcuni album interessanti da proporvi).
Bruno Conti
Il Miglior Disco Del 2016? Forse E’ Presto, Ma… Lucinda Williams – The Ghosts Of Highway 20
Lucinda Williams – The Ghosts Of Highway 20 – 2 CD Highway 20/Thirty Tigers
Ovviamente è presto per fare pronostici, ma Lucinda Williams ci aveva lasciato nell’ottobre del 2014 con quello che poi si era rivelato, probabilmente (come si sa, ognuno ha i suoi gusti), come uno dei migliori dischi dell’anno, Down Where The Spirit Meets The Bones, un formidabile doppio album che aveva confermato il suo status come una delle migliori cantautrici sulla faccia del pianeta http://discoclub.myblog.it/2014/09/30/il-buon-vino-invecchiando-migliora-sempre-piu-lucinda-williams-down-where-the-spirit/ , ed ora, a poco più di un anno, ne pubblica un altro, The Ghosts Of Highway 20, sempre doppio, ma con 14 canzoni rispetto alle 20 del precedenti, che è altrettanto bello, forse un filo meno immediato e quindi da assimilare magari più lentamente. Le canzoni dell’album ruotano attorno alla Highway 20, la cosiddetta Interstate 20, che dal South Carolina porta al Texas, attraverso gli Stati del Sud degli States Come al solito per Lucinda, storie di perdenti, amanti, paesaggi che gravitano intorno alla strada e si intrecciano con il suo percorso, personaggi veri ed inventati, passati e presenti, “fantasmi” che popolano l’immaginario dei suoi brani, sempre imbevuti da un’anima musicale profondamente rock: 86 minuti di musica divisi su due compact, dove i suoi compagni di avventura sono più o meno i soliti, Tom Overby, il marito della Williams, è sempre, con lei, il produttore del disco, e firma anche la title-track, Greg Leisz, con tutte le sue chitarre, soprattutto lap e pedal steel, di cui ormai è maestro incontrastato, questa volta è anche co-produttore, e divide con Bill Frisell il ruolo di solista.
Val McCallum, impegnato anche con Jackson Browne, appare solo in due brani, come chitarrista aggiunto, mentre la sezione ritmica è affidata ai soliti, e solidi, Butch Norton, alla batteria e David Sutton al basso, niente tastiere questa volta, visto che anche la Williams è impegnata a chitarre acustiche ed elettriche: solo nell’ultimo brano Faith And Grace, il più lungo, con i suoi quasi 13 minuti, appaiono come ospiti Carlton “Santa” Davis (il vecchio batterista di Peter Tosh) e il percussionista Ras Michael, all’hand drum. Partiamo proprio da questo pezzo, uno dei più ritmati, tinto, come era ovvio, vista la presenza di un batteria giamaicano, di ritmi reggae e caraibici, che chi mi legge saprà non prediligo particolarmente, se non presi in piccole dosi, ma in questo caso ci sta, visti in un’ottica jam che comunque mi piace: Greg Leisz in questo pezzo è più defilato, con la chitarra di Frisell che fa da contraltare alla voce di Lucinda nelle lunghe elucubrazioni di questa canzone, che conclude degnamente un album che adesso andiamo a vedere nella sua interezza.
Il paragone con il vino che invecchia l’ho già usato per il vecchio album, ma rimane valido anche per questo The Ghosts Of Highway 20, che si apre con un brano, Dust, ispirato da un poema di Miller Williams, il papà di Lucinda, scomparso circa un anno fa, il 1° gennaio del 2015, poeta, traduttore ed editore, che ha lasciato una profonda influenza sulla figlia: la canzone che prende lo spunto dalla polvere che ricopre le strade ha la classica andatura di molte delle canzoni della Williams, lenta e maestosa, si dipana sul lavoro delle chitarre di Leisz e Frisell che poi nella parte centrale e finale del brano si lanciano nella classiche jam chitarristice che spesso contraddistinguono i suoi brani. E se il buongiorno si vede dal mattino anche la successiva House Of Earth, una ballata lenta, dolente e notturna, è una gran canzone, meno rock e tirata, ma sempre affascinante nel suo dipanarsi elettroacustico, ancora caratterizzato dal finissimo lavoro di cesello dei due chitarristi, il testo è di Woody Guthrie, con Lucinda Williams che ha aggiunto la musica. La forma della ballata, quella che forse Lucinda predilige viene ripresa anche nella successiva I Know All About It, qui messa in musica con un approccio quasi western, con tocchi jazz, dei due solisti, sempre soffuso e delicato il loro lavoro, in grado di dare forza alle liriche. Testi che sono importantissimi anche in Place In My Heart, brano dolcissimo che vive sull’interpretazione molto calda e malinconica della voce della Williams, accompagnata solo dalle due chitarre che sottolineano lo spirito delicato del brano, una sorta di valzer minimale. Eccellente anche Death Came (ma ci sono brani brutti?), che parte ancora solo con le due chitarre ma poi si anima leggermente con l’ingresso della sezione ritmica, sempre discreta e raffinata. Doors Of Heaven, più mossa e bluesy, ha anche uno spirito country e swampy nel suo Dna, grazie al lavoro intricato delle due chitarre, con Leisz alla slide, brano che fa da preludio alla lunga Louisiana Story, che ci porta nei territori natali della nostra amica, una ballata che riprende in parte i temi di Baton Rouge e li sviluppa, sempre in modo gentile e raffinato, attraverso un lento e meditato dipanarsi che si gusta con ripetuti ascolti, nei vecchi vinili questo segnerebbe la fine del primo album, ma vale anche in questo caso, per il doppio CD.
Si riparte con la title-track, The Ghosts Of Highway 20, uno dei due brani dove appare Val McCallum alla chitarra e qui il tessuto sonoro si fa decisamente più rock, con i solisti che si fronteggiano sui due canali dello stereo, fino alla immancabile coda strumentale, in una di quelle canzoni epiche che sono tipiche della musica di Lucinda Williams. Bitter Tears, di nuovo in solitaria con Frisell e Leisz, è un pezzo country fatto e finito, dal tempo veloce ed incalzante, una riflessione amara sui tempi passati. Poi c’è la sorpresa che non ti aspetti: una cover di Factory, proprio il pezzo di Bruce Springsteen, che però la nostra amica fa alla Williams, con il tempo rallentato ed avvolgente, solo la chitarra di Frisell a disegnare la melodia in modo acido e jazzato (ricordo un suo assolo memorabile in una versione di Going Going Gone di Dylan, cantata da Robin Holcomb per un tributo per i 40 anni della Elektra https://www.youtube.com/watch?v=ALM2SI0GZj8). Viceversa in Can’t Close The Door On Love è la melodia a fare da trave portante al tessuto sonoro della canzone, questa volta più ottimista e positiva, una ballata elettrica stupenda, una delle canzoni più belle del disco, da sentire e risentire.
Ci avviciniamo alla conclusione, rimangono If My Love Could Kill, brano giocato intorno all’elegante groove della batteria di Butch Norton, altra riflessione poetica sugli effetti dell’amore malato e senza futuro. di nuovo impreziosito dal lavoro dei due chitarristi, che poi lasciamo spazio a Val McCallum che torna per la solare e malinconica (sembra un contrasto insanabile, ma nelle canzoni della Williams non lo è) If There’s A Heaven, altro tassello della costruzione sonora di questo album che conferma, ribadisco, lo status di Lucinda Williams come una delle più grandi in assoluto nella musica che conta. Last but not least, come detto, troviamo i ritmi vagamente reggae-rock della lunghissima Faith And Grace che conclude in gloria un disco che si candida fin da ora tra i migliori del 2016! Esce venerdì 22 gennaio, in questi giorni è in tour in Europa, ma niente Italia.
Bruno Conti
Un’Aquila Ha Preso Il Volo: E’ Morto Anche Glenn Frey!
Raramente ricordo un periodo così nefasto per il mondo della musica mondiale come quello compreso tra la fine del 2015 e l’inizio di questo 2016: nel giro di poco tempo abbiamo avuto la scomparsa di Lemmy dei Motorhead, di David Bowie, oltre che di Natalie Cole (e del soulman Otis Clay, che come previsto non se lo è filato nessuno). Come se non bastasse, ieri sera è giunta all’improvviso la notizia della morte di Glenn Frey, cantante, chitarrista e membro fondatore degli Eagles, una delle band più popolari del pianeta, la punta di diamante del country-rock (e pop) californiano degli anni settanta, un mondo musicale a parte, ma anche uno stile di vita vero e proprio, fatto di musica, festini, donne, alcol e cocaina, che le Aquile avevano immortalato alla perfezione in due dei loro maggiori successi (di cui Frey era co-autore), cioè Hotel California e Life In The Fast Lane; proprio la vita nella corsia di sorpasso alla lunga è passata da Glenn a farsi pagare il conto, sotto forma di una serie di problemi assortiti (polmonite, artrite reumatoide e colite ulcerosa, ma anni fa il musicista aveva subito anche un trapianto di fegato), ponendo in pratica fine alla storia della band, che negli ultimi vent’anni aveva inciso poco ma era stata parecchio attiva dal vivo: difficile infatti che Don Henley, Joe Walsh e Timothy B. Schmit decidano di proseguire come trio, anche per il fatto che molti dei loro brani più noti (Take It Easy, Tequila Sunrise, New Kid In Town, Peaceful, Easy Feeling, Already Gone, Lyin’ Eyes) erano ormai legati a doppio filo alla figura di Glenn.
Originario del Michigan (alla fine l’unica Aquila, presente e passata, nata in California è Schmit), Glenn esordisce come backing vocalist e chitarrista in Ramblin’ Gamblin’ Man di Bob Seger (con il quale anni dopo scriverà l’hit degli Eagles Heartache Tonight), poi, spostatosi a Los Angeles, collaborerà con J. D. Souther, con il quale inciderà un disco in duo a nome Longbranch Pennywhistle, venendo poi preso sotto l’ala protettiva di Jackson Browne, con il quale scriverà proprio Take It Easy, che darà il via al volo delle Aquile (nel frattempo Frey aveva infatti fatto amicizia con Henley, ed i due avevano collaborato già come componenti della backing band di Linda Ronstadt, insieme anche a Bernie Leadon e Randy Meisner, praticamente gli Eagles al completo prima che diventassero una vera band).
Il resto è storia: i dischi, i concerti, il grande successo (il loro Greatest Hits è ancora oggi uno degli album più venduti di tutti i tempi), ma anche la droga, i problemi di ego, le incomprensioni ed i litigi, che porteranno il gruppo a sciogliersi in modo non amichevole nel 1980: passeranno ancora14 anni prima che i cinque (Don Felder era ancora con loro) si riunissero per il comeback album live (ma con quattro pezzi nuovi in studio, tra cui la bella e countryeggiante The Girl From Yesterday di Glenn) Hell Freezes Over, e susseguente tour, una nuova carriera che si è protratta fino ai giorni nostri con molti concerti ed un solo disco, il discontinuo Long Road Out Of Eden del 2007.
Decisamente popolari anche dalle nostre parti, gli Eagles hanno davvero segnato un’epoca, anche se buona parte della critica musicale “intelligente” non li aveva mai potuti digerire molto a causa del loro successo e di certe scelte musicali troppo pop, specie nella parte finale degli anni settanta: Glenn è sempre stato il frontman del gruppo, con la sua aria da personaggio alla Miami Vice (serie per la quale ha anche inciso dei brani negli anni ottanta e partecipato in veste di attore), ma ne ha anche sempre curato gli affari, ed è stato in prima linea a tutelare gli interessi della band nella disputa contro Felder.
Come solista non è stato mai molto prolifico (quattro album di materiale originale dal 1982 al 1992, un live ed un poco riuscito disco di standard, After Hours, nel 2012), ma ha avuto un ottimo successo con il brano The Heat Is On (inserito nella colonna sonora del film Beverly Hills Cop), un tipico esempio di pop californiano anni ottanta un po’ plastificato.
Io vorrei ricordarlo in maniera diversa, e cioè non con un classico assodato delle Aquile ma un suo brano degli anni ottanta che all’epoca avevo amato molto, ed anche adesso in quanto mi fa ricordare un periodo in cui avevo trent’anni di meno…
So long, Glenn: adesso l’Aquila potrà davvero volare libera.
Marco Verdi
Dal Vivo Sempre Bravissimi! Avett Brothers – Live Vol. 4
Avett Brothers – Live Vol. 4 – CD+DVD American Recordings/UMG
Gli Avett Brothers sono quasi dei clienti fissi del Blog, http://discoclub.myblog.it/2012/09/22/pop-in-excelsis-deo-avett-brothers-the-carpenter/ e http://discoclub.myblog.it/2010/11/04/temp-38e44dc3108786660152b6bd09f62fa0/, ma anche dei concerti dal vivo, visto che questo Live Vol.4, come recita il titolo, è già il quarto capitolo della serie dedicata alle esibizioni in concerto, dal primo Live At The Double Inn del 2002, quando erano degli illustri sconosciuti. Per questa nuova puntata delle loro avventure concertistiche hanno deciso di abbinare nella confezione sia il CD come il DVD, mentre per esempio nel 3° volume i due formati erano usciti divisi. e, purtroppo, come al solito, il doppio non è edito né in Europa, né tanto meno in Italia. Oltre a tutto essendo stato pubblicato il 18 dicembre, nelle immediate vicinanze del Natale non ha fatto neppure in tempo ad entrare in molte classifiche dei migliori dischi dell’anno, magari almeno per i Live.
Il concerto è stato registrato il 31 dicembre del 2014 alla PNC Arena, a Raleigh, Carolina del Nord, quindi nella tana del lupo, a casa loro, dove la band è popolarissima, e i ventimila presenti praticamente pendevano dalle loro labbra. Non che ne abbiamo bisogno, visto che dal vivo (ma pure in studio) sono bravissimi, una delle migliori band del nuovo rock a stelle e strisce, sempre in bilico tra country, Americana, Bluegrass e, dal vivo, anche moltissimo rock: i due fratelli Scott e Seth Avett hanno delle bellissime voci e anche il resto dei componenti del gruppo contribuiscono a questo suono fresco, frizzante e di eccellente qualità. Se proprio un appunto si può fare al CD è quello che essendo un tipico concerto “festivo”, la gag del vecchio “Father Time” che si aggira per le strade e sul palco e della sua compagna Mother Nature, viene tirata un po’ per le lunghe e anche le versioni del traditional Auld Lang Syne, preceduta dal countdown di fine anno e del vecchio brano di Roy Rogers, Happy Trails, non mi sembrano particolarmente memorabili. Per il resto pollice alzato.
L’apertura, sulle immagini del pubblico che entra nell’arena, è affidata a una lunga intro batteria e violino, suonato dalla bravissima Tania Elizabeth, con il resto dei componenti che salgono sul palco a mano a mano, sulle note di una inedita, e indiavolata, dato il nome del brano, Satan Pulls The Strings, che illustra il loro lato più bluegrass/country, tra banjo, chitarre acustiche, un secondo violino, il cello di Jim Kwon, il contrabbasso e la batteria di Mike Marsh. tutti vestiti in nero da bravi cowboys. Laundry Room è un bellissima ballata elettro-acustica e malinconica che era sull’album prodotto da Rick Rubin, quell’ I And Love And You che li ha fatti diventare popolarissimi negli States e piuttosto conosciuti nel resto del mondo, senza concessioni alla musica pop e con quelle armonie vocali e crescendo strumentali che sono il loro marchio di fabbrica. Another Is Waiting, altra canzone bellissima era su Magpie And The Dandelion, l’ultimo album del 2013, anche questo recensito sul Blog http://discoclub.myblog.it/2013/11/01/sono-sempr-5747492/. Shame era su Emotionalism, il quinto ultimo, l’ultimo primo della fama globale, ma quando erano giù una band formata e dalle eccellenti aperture folk, confermate in questa calda versione (il brano era anche nel precedente Live Vol.3).
Poi inizia la parte più elettrica del concerto: Kick Drum Heart è un formidabile pezzo rock, quasi springsteeniano, ideale per gasare il pubblico, sempre da I And Love And You, con fioriture di piano, organo e violino, oltre all’elettrica di Seth che si produce in un veemente assolo nella parte finale del brano, mentre anche l’altra canzone nuova, Rejects In the Attic, conferma la sempre eccellente vena compositiva dei fratelli, ben coadiuvati da Bob Crawford, il bassista storico e co-autore della gran parte dei brani della band, in questo caso una delle loro tipiche ballate melodiche ed avvolgenti, tipico brano “invernale” che ben si inserisce anche metaforicamente nel periodo più freddo dell’anno. Ancora dal loro album di maggior successo, dopo un altro intermezzo di Father Time, ecco la dolcissima ed acustica, solo due chitarre, Ten Thousand Words, dove la sorella Bonnie si aggiunge alle formidabili armonie vocali della famiglia Avett. Talk On Insolence, di nuovo a tutto bluegrass, viene dal loro non dimenticato passato di grande band country-folk, di nuovo in in un florilegio di banjo, acustiche, violini e continui cambi di tempo che esaltano il pubblico presente che viene trascinato in un gorgo di divertimento.
Di Auld Lang Syne che arriva dopo il conto alla rovescia di fine anno e l’ennesima apparizione di Father Time, con la sua clessidra, si è detto, molto più travolgente una fantastica versione di The Boys Are Back In Town dei Thin Lizzy, di cui Phil Lynott il suo autore, sarebbe stato orgoglioso: cantata da Valient Thorr, il leader dell’omonima band locale, e con i fratelli alle twin leads conferma il suo status di grande pezzo di R&R. Poi c’è ancora tempo per due brani tratti da I And Love And You, la travolgente Slight Figure Of Speech, con vari finti finali e la title-track di quel disco che è una ballata tra le più belle mai firmate dagli Avett Brothers. Chiude il tutto Happy Trails. Luca Carboni una volta disse che Dustin Hoffman non sbagliava un film, ma poi ha iniziato a “ciccarli” a ripetizione, i nostri amici, per il momento, viceversa, non sbagliano un disco!
Bruno Conti
P.s Filmati ufficiali del concerto in rete non se ne trovano per cui ho inserito materiale da altri concerti, passati e recenti.
Supplemento Della Domenica: Se La Musica E’ Bella Che Importa Se E’ Datata? The Mamas And The Papas – The Complete Singles: 50th Anniversary Collection
The Mamas And The Papas – The Complete Singles: 50th Anniversary Collection – Real Gone/Universal 2CD
The Mamas And The Papas, per chiamarli con il loro nome completo, uno dei gruppi cardine del cosiddetto movimento hippy della seconda metà degli anni sessanta, e tra i principali esponenti della Summer Of Love, sono stati negli anni il soggetto per innumerevoli antologie, la migliore delle quali è senza dubbio il box quadruplo, intitolato appunto Complete Anthology, uscito nel 2004.
Questo doppio CD da poco uscito per la Real Gone, intitolato The Complete Singles (che celebra i 50 anni dalla nascita del quartetto), si piazza però subito dietro: esso ripercorre, come suggerisce il titolo, la carriera del gruppo guidato da John Phillips prendendo in esame i brani usciti su 45 giri, comprendendo anche i lati B (alcuni di essi mai usciti su CD prima d’ora), ed aggiungendo anche i rari singoli da solista di tre dei quattro membri della band, il tutto presentato nell’ormai introvabile missaggio in mono, tranne cinque pezzi, (*NDB, ma io preferisco quello stereo, vedi e senti il video sotto) per un totale di ben 53 canzoni. I Mamas & Papas, che oltre a Phillips (songwriter principale, ed autore tra l’altro anche dell’inno hippy San Francisco di Scott McKenzie https://www.youtube.com/watch?v=i9xVMjjjg0Ued organizzatore del primo festival rock della storia, quello di Monterey) erano formati dalla bellissima Michelle Gilliam-Phillips (seconda moglie di John), la monumentale (in tutti i sensi) “Mama” Cass Elliott e da Denny Doherty, hanno legato il loro nome a doppio filo al loro più grande successo, quella California Dreamin’ per la quale non è esagerato parlare di canzone simbolo di un’epoca, ma, come dimostra questa antologia, la bravura del quartetto nel coniugare folk, pop e rock con uno squisito gusto melodico e splendide armonie vocali (unita alla sapiente produzione del grande Lou Adler) andava ben oltre quel singolo brano.
Il primo CD prende in esame il periodo d’oro della band, quello dal 1965 al 1968, anno in cui si separarono, pare soprattutto per problemi familiari tra John e Michelle, che infatti divorziarono (sembra che alla bionda cantante piacesse, per così dire, mettere in pratica le teorie dell’amore libero – si narra di storie con lo stesso Doherty e con l’ex Byrd Gene Clark – ma che John non approvasse molto): a noi però interessa la musica, è qui ce n’è di bellissima, anche se in certi punti gli arrangiamenti possono suonare un tantino fuori moda; ad accompagnare i quattro ci sono fior di musicisti, come P.F. Sloan, Hal Blaine, Joe Osborn, lo straordinario pianista Larry Knetchel e Jim Horn.
Già l’iniziale Go Where You Gonna Go, fresca ed estremamente orecchiabile, fa capire che i nostri non perdevano tempo, ed infatti la terza e la quarta canzone sono già i loro due più grandi hits, cioè appunto California Dreamin’ e Monday Monday (che inizialmente ebbe anche più successo della precedente https://www.youtube.com/watch?v=h81Ojd3d2rY ); ma poi abbiamo anche l’irresistibile I Saw Her Again, tra Beatles e Beach Boys https://www.youtube.com/watch?v=9zBMK5OAGyE , la languida Look Through My Window, la bizzarra ma divertente Once Was A Time I Thought (uno scioglilingua più che una canzone), la strepitosa Words Of Love, tra rock e vaudeville https://www.youtube.com/watch?v=OouK3QOzW6Q (seguita dal suo lato B, una brillante versione di Dancing In The Streets di Martha & The Vandellas), l’eterea Dedicated To The One I Love https://www.youtube.com/watch?v=4M7gKZqgHn4 , la deliziosa ed autoironica (“no one’s getting fat except Mama Cass”) Creeque Alley, altro grande successo del quartetto.
Ma poi come non citare anche Did You Ever Want To Cry, dall’andamento quasi dixieland, la quasi spectoriana Twelve Thirty, la diretta e fluida Hey Girl, la sinuosa e bucolica Dancing Bear, una squisita versione dell’evergreen Dream A Little Dream Of Me, con Mama Cass perfetta alla voce solista https://www.youtube.com/watch?v=ajwnmkEqYpo , per finire con Strange Young Girls, uno splendido folk dal sapore tradizionale inglese, che li fa sembrare più vicini ai Pentangle che alle loro abituali sonorità californiane.
Sul secondo CD troviamo l’ultimo singolo prima del breakup (due buone cover di Do You Wanna Dance di Bobby Freeman e di My Girl dei Temptations) e l’unico tratto dal loro poco riuscito comeback album del 1971, People Like Us, con Step Out e Shooting Star, due pezzi che risentono di uno stile un po’ leccato e troppo commerciale, poco adatto al gruppo. Poi, come già accennato, ci si concentra sui brani solisti usciti nel periodo dopo la prima separazione (1968-1971) di tre quarti della band (Michelle in quel periodo farà solo da corista on stage per Leonard Cohen nel 1970 e poi si dedicherà quasi totalmente alla carriera cinematografica), con Mama Cass che fa la parte del leone con ben sedici pezzi, tutti piuttosto gradevoli e non molto distanti dallo stile della sua ex band, anche se manca la penna di Phillips (Move A Little Closer, Baby ricorda un po’ gli Abba qualche anno prima della loro nascita): c’è anche Make Your Own Kind Of Music, peraltro molto bella, tornata di recente alla ribalta in quanto contenuta in alcuni episodi della popolare serie televisiva Lost https://www.youtube.com/watch?v=PEQxEJ5_5zA . Per finire abbiamo due brani del mitico primo album solista di John Phillips, ed unico pubblicato in vita, John, The Wolfking Of L.A. (uno dei miei cinque dischi da isola deserta), la vivace Mississippi e la sublime April Anne (ma anche Topanga Canyon era un pezzo da novanta), e quattro pezzi del 1971 di Doherty, tutti piuttosto gradevoli e countryeggianti, nel pieno spirito country-rock californiano che da lì ad un anno vedrà esordire gli Eagles (ed il produttore di queste quattro canzoni è Bill Szymczyk – cambiare cognome no? – che più avanti legherà il suo nome proprio alle Aquile).
Da lì in poi le strade dei quattro si incontreranno solo saltuariamente: Mama Cass morirà tragicamente d’infarto nel 1974, Michelle (l’unica ancora in vita) sposerà l’attore Dennis Hopper (il secondo di cinque mariti), proseguendo la carriera di attrice e pubblicando un unico album nel 1977, John inciderà ancora (ma tutti lavori che verranno pubblicati dopo la morte avvenuta nel 2001), tenterà di rivitalizzare la vecchia band negli anni ottanta per alcuni tour (con solo lui e Doherty come membri originali) e rimarrà invischiato in brutte storie di droga ed addirittura incesto con la figlia avuta dalla prima moglie, mentre Doherty sparirà un po’ dai radar, fino alla morte per aneurisma avvenuta nel 2007.
Ma a me piace ricordarli quando erano giovani ed attivi, e The Complete Singles è il modo migliore per farlo.
Marco Verdi
In Studio O Dal Vivo, Sempre un Gran Chitarrista! Tom Principato – Live And Still Kickin’
Tom Principato – Live And Still Kickin’ – Powerhouse CD+DVD
Lo avevamo lasciato un paio di anni fa, nel 2013, con l’ottimo Robert Johnson Told Me So http://discoclub.myblog.it/2013/10/15/mi-manda-eric-clapton-tom-principato-robert-johnson-told-me/ , e quindi non vi tedierò di nuovo con vita, morte e miracoli del nostro: mi limito a confermarvi che questo signore è uno dei migliori chitarristi/cantanti attualmente in circolazione in quel ambito che sta fra blues e rock, a maggior ragione in una dimensione concertistica dove si possono godere le sue virtù di grande solista e portatore della memoria storica del passato, due fra tutti nel suo caso, Roy Buchanan e Danny Gatton, entrambi molto presenti nel DNA musicale di Tom Principato. Questo disco dal vivo è l’ideale prosecuzione di un Live And Kickin’ uscito nel lontano 2000 e presenta materiale registrato nel corso del tour che nel 2014 lo ha portato in Europa: infatti si tratta di estratti di due diversi concerti, il primo a Vienna al Barns Of Wolf Trap, con una formazione arricchita da una sezione fiati in alcuni pezzi, e il secondo a Les Escales St. Nazaire in Francia, dove è molto popolare, solo i tre brani finali. Il tutto, che è stato filmato anche per un DVD allegato al CD, viene pubblicato dalla etichetta personale di Principato, la Powerhouse.
E non posso che confermare, oltre alle influenze dei due musicisti ricordati (e di tutti i grandi del blues), una sorta di affinità con Eric Clapton, sin dalla postura con cui Tom si propone sia dal vivo che in foto, ma soprattutto a livello musicale, con questo stile che pesca da tutte le nuances del blues-rock e attraverso la penna e la sensibilità di Principato viene riversato con gusto, grinta e una notevole dose di tecnica sugli ascoltatori dei suoi concerti. Per intenderci, come nel caso di Manolenta, i brani sono costruiti per farci arrivare all’assolo che è il clou della canzone, ma nello stesso tempo, a differenza di quelli della categoria degli “esagerati”, l’assolo è un fine e non un mezzo per farci vedere quanto sono bravi, c’è tanto altro intorno. Tom Principato ovviamente non è il salvatore del blues-rock tout court, ma uno dei praticanti dell’arte di riproporre e reiterare una musica che abbiamo sentito mille volte ma che vive grazie alla capacità del musicista di farlo con i giusti riferimenti, cercando di metterci qualcosa di proprio, magari poco, soprattutto nella interpretazione.
E allora, pescando a caso dalla scaletta del repertorio, ecco scorrere il delizioso assolo con wah-wah che incornicia la ritmata e quasi reggata In the Middle Of Night, dove le tastiere di Tommy Lepson e le percussioni di Josh Howell, altrove anche alla armonica, provvedono a quel tocco caraibico che insaporisce il menu blues, o il r&r fiatistico e ad alta concentrazione boogie della iniziale Call Of The Law, sempre con l’organo a ben spalleggiare le mosse della solista di Principato, che poi fa la sua parte come si deve. O ancora le traiettorie santaneggianti della sinuosa Bo Bo’s Groove, uno strumentale che sembra uscire dai solchi di uno dei primi tre dischi dei Santana, quelli migliori. Hey Now Baby ha la giusta quota funky-soul, mentre Don’t Wanna Do It, sempre con la massiccia presenza dei fiati, è un altro esempio della bella calligrafia delle ri-scritture di Principato dei canoni blues-rock, con Helping Hand che propone il lato blues & soul revue. Cross Cut Saw, una delle rare cover della serata, viene dal repertorio di Albert King, quindi occasione peri indulgere in un lato più blues, anche grazie all’armonica di Howell. Molto piacevoli puree Sweet Angel e la tiratissima Return Of The Voodoo King (un omaggio a Jimi) https://www.youtube.com/watch?v=7lFv7AqBUCo che chiudono la parte del concerto registrata a Vienna. Nei tre brani parigini non c’è la sezione fiati, e quindi lo spazio per la chitarra di Principato è ancora più evidente, a partire da un sontuoso lento come The Rain Came Pouring Down che evidenzia le influenze di Buchanan, con la solista che disegna traiettorie di grande fascino e tecnica. Le conclusive If Love Is Blind e Robert Johnson Told Me So (con uso di slide), uno dei due brani tratti dall’ultimo album, sono entrambe molto vicine allo spirito di Clapton e quindi estremamente godibili e ricchi di spunti chitarristici di gran classe. Che è quello che si chiede in fondo ad un disco come questo, uno dei migliori Live dell’anno appena concluso.
Bruno Conti
Un Sano Disco Di Pop…Dal Texas! Wild Child – Fools
Wild Child – Fools – Dualtone CD
I Wild Child sono una band di sette elementi proveniente da Austin, Texas, un gruppo che però non è country, né rock, ne blues, ma bensì fa del pop puro e semplice, un genere non molto in voga nel Lone Star State. Se poi guardiamo alla formazione, notiamo delle particolarità: oltre a strumenti classici come basso, batteria, pianoforte e violino (rispettivamente Chris D’Annunzio, Drew Brunetti, Evan Magers e Kelsey Wilson, che è anche la voce solista femminile, e principale, del gruppo), troviamo pure ukulele (Alexander Beggins, co-leader insieme alla Wilson e voce maschile) e cose molto meno texane come cello e tromba (Sadie Wolfe e Matt Bradshaw); avrete quindi notato la totale assenza di chitarre (anche se l’ukulele viene spesso usato alla stessa guisa), e sappiamo che una band texana senza chitarre è un po’ come un ristorante messicano che non usi peperoncino, eppure dopo due o tre canzoni ci si rende conto che la musica dei Wild Child ha senso e sta in piedi da sola, con elementi talvolta beatlesiani, talvolta simili a gruppi come Of Monsters & Men ed Edward Sharpe & The Magnetic Zeros ed altre volte più personali, un uso spesso particolare della sezione ritmica e delle melodie fresche e godibili.
Fools è il loro terzo album, dopo Pillow Talk del 2011 e The Runaraound del 2013 che hanno ottenuto ottime recensioni ed un discreto successo locale, ed è prodotto da Peter Mavrogeorgis (già collaboratore di The National e Philip Glass) e dal musicista indie David Plakon. La title track, che apre il CD, è un power pop molto particolare, con diverse soluzioni strumentali e melodiche ed un bel crescendo ritmico, un pezzo in cui le similitudini con gli Of Monsters & Men sono abbastanza chiare. The Cracks non è facilissima da descrivere: inizio quasi roots con l’ukulele in evidenza, poi entrano le voci, il piano e la sezione ritmica e l’atmosfera si fa eterea, quasi ipnotica; Bullets all’inizio è quasi cameristica e dall’aria molto beatlesiana (sullo stile di For No One, Eleanor Rigby), ma la melodia è molto più scorrevole e diretta che nel brano precedente https://www.youtube.com/watch?v=it4hd9B6aBs , mentre Stones vede le voci dei due leader sovrapporsi in una sorta di filastrocca pop accattivante, con un altro cambio di ritmo che a questo punto inizia a diventare uno dei marchi di fabbrica del gruppo.
Un delicato arpeggio di ukulele introduce Meadows (i titoli dei brani sono un po’ laconici), una canzone fresca e quasi bucolica dagli elementi folk; la pianistica Break Bones è puro pop, raffinato e con un refrain fruibile https://www.youtube.com/watch?v=4xcKP0wnNLw , mentre la cadenzata Take It è tutta incentrata sulla voce di Kelsey ed una strumentazione dosata con parsimonia. Pop texano: prima dell’ascolto ero un po’ scettico, ed invece il disco si sta rivelando una piccola sorpresa; la rilassata Saving Face vede i due leader armonizzare su un bel tappeto ritmico e misurati interventi di piano ed ukulele, e quest’ultimo è il protagonista di Reno, dove è quasi l’unico strumento ad accompagnare la voce della Wilson, a parte una leggera percussione ed il cello nel finale. L’album si chiude con la solare Oklahoma, uno dei motivi più orecchiabili del CD, la mossa Bad Girl, che potrebbe dire la sua anche alla radio, e la scorrevole e liquida Trillo Talk.
I Wild Child dimostrano che in Texas si può fare anche del pop, e con una certa classe e credibilità.
Marco Verdi
Segnali Di Vita Dal Passato. Lee Michaels – Heighty Hi The Best Of Lee Michaels
Lee Michaels – Heighty Hi The Best Of Lee Michaels – Manifesto Records
Il caso di Lee Michaels è diverso da quelli di molti artisti che periodicamente vengono “scoperti”, grazie alle ristampe di dischi di culto che magari ai tempi non avevano neppure avuto una circolazione adeguata o erano stati pubblicati a livello underground, o più spesso ancora si erano persi nei meandri dell’epoca d’oro del rock. Per questo signore la storia è diversa: nato a Los Angeles nel 1945, la sua carriera musicale inizia a metà anni ’60 quando si sposta poco più a nord, in quel di San Francisco e forma la sua prima band, i Sentinals, con Johny Barbata (futuro batterista di Turtles, Jefferson Airplane e Starship, nonché di CSN&Y), ma anche Joel Scott Hill poi con i Canned Heat, e Bob Mosley dei Moby Grape, a seguire arrivano i Family Tree con Bob Segarini, e nel 1967 firma un contratto come solista con la A&M. Ha fatto anche il sessionman come organista con Hendrix ed aveva come manager Matthew Katz, lo stesso di Jefferson Airplane, It’s A Beautiful Day e Moby Grape, quindi la possibilità di esibirsi in locali come l’Avalon Ballroom e il Fillmore West a fianco dei migliori musicisti californiani dell’epoca.
Il primo album, Carnival Of Life, uscirà per la A&M nel 1968, come pure i sei successivi, fino al doppio dal vivo del 1973, saranno per la stessa etichetta, entrando spesso nei Top 100 delle classifiche americane e producendo anche un singolo di successo come Do You Know What I Mean, giunto al 6° posto delle classifiche nel 1971 e un altro brano nei Top 40 come la cover di Can I Get A Witness di Marvin Gaye. Entrambi i brani si trovano in questa antologia della Manifesto che attraverso le sue venti canzoni ripercorre il periodo migliore di Michaels (che produrrà ancora tre album per la Columbia, salvo poi sparire completamente, aprendo un ristorante di successo a Marina Del Rey e un paio di timidi ritorni nel mondo della musica, tra il 1996 e il 2008, passati sotto silenzio). Anche a livello ristampe Lee Michaels non è stato trattato particolarmente bene: tre antologie pubblicate da Rhino e Shout, oltre ad una della One Way, che aveva ristampato anche i suoi singoli album, non in modo particolarmente brillante a livello sonoro e di contenuti, spariti in fretta https://www.youtube.com/watch?v=oCjgmM4ZUNs .
Ora la Manifesto records oltre alla antologia di cui ci occupiamo ha pubblicato anche un sontuoso ( e costoso) box da 7 CD, The Complete A&M Album Collection, che raccoglie tutti gli album fino al 1973. Dicevo all’inizio che il caso di Michaels è diverso da quelli di altre ristampe, in quanto l’artista ai tempi vendeva parecchio, i suoi dischi avevano ottime critiche ed erano indubitabilmente piuttosto buoni tutti. Uno stile che oscillava tra il rock classico dei tempi e una vena che potremmo definire “Blue-eyed soul”, non diversa da quella di artisti come il Todd Rundgren del primo periodo, con la sua miscela di tastiere, piano e organo erano gli strumenti di Michaels, venati di rock anni ’70 (a tratti ricordando anche i primi Vanilla Fudge), pop melodico ma di ottima qualità, accenni psych e garage, e soprattutto molto soul bianco influenzato dalla Motown. I brani non sono in ordine cronologico, quindi si passa da uno stile all’altro dei diversi album, ma si apprezza comunque la qualità della musica: il rock-gospel, quasi alla Stephen Stills di Love The One You’re With, di Heighty Hi, con le sole tastiere e una batteria a tenere il tempo, oltre a dei coretti “neri”, il pop-rock gioioso di Do You Know What I Mean, con la bella voce di Michaels in evidenza, lo psych-rock di If I Lose You, con rare apparizioni di fiati e chitarre (si era agli inizi nel 1968) a fianco delle tastiere barocche di Lee.
La quasi classicheggiante The War (con echi dei Vanilla Fudge citati e continui florilegi di organo), la rara Goodbye, goodbye, una b-side d’epoca che evidenzia le influenze Motown. Hello, decisamente più rock e grintosa, Carnival Of Life, ricercata e acida, Uummm My Lady, una bella ballata pianistica, Keeps The Circle Turning, di nuovo quel gospel-rock che all’epoca funzionava, Thumbs, più complessa negli arrangiamenti, con chitarre acustiche ed elettriche a variare lo spettro sonoro, Can I Get A Witness, è il rock and soul che ci si potrebbe aspettare, mentre Hold On To Freedom https://www.youtube.com/watch?v=PzgPhEclDh4 segnala la svolta più rock del disco del 1972 Space And First Takes,e Murder In My Heart (For The Judge) è una bella cover del pezzo dei Moby Grape, West Coast acida al punto giusto https://www.youtube.com/watch?v=059KzboKC_A . Sounding The Sleeping è rock con inserti classicheggianti, e Michaels non si fa mancare neppure una deviazione nel blues alla Al Kooper con Stormy Monday https://www.youtube.com/watch?v=rqWgSn45hIY o nelle dolcezze di What Now America e No Part Of It, e di nuovo nello psych-rock della conclusiva Love https://www.youtube.com/watch?v=9FUk58acCT8 . Insomma non un genio ma un brillante musicista americano ingiustamente dimenticato dal tempo!
Bruno Conti
Recuperi Di Inizio Anno 6: Una Delle Sorprese di Fine 2015! Orphan Brigade – Soundtrack To A Ghost Story
Orphan Brigade – Soundtrack To A Ghost Story – Appaloosa / I.R.D.
Per chi scrive, è successo in passato, ed è successo di in questa occasione, è succederà certamente in futuro, di avere dei “colpi di fulmine musicali”, in quanto non credo che esistano dischi in grado di essere ascoltati solo in un determinato contesto, ma è altrettanto vero che certi dischi riescono a salire di tono ricordando emozioni anche soltanto immaginarie. Mi sembra questo il caso di Soundtrack To A Ghost Story degli Orphan Brigade (mi sono documentato, e come è abbastanza noto, il nome deriva da una brigata militare di quel periodo intorno a cui ruota tutta la storia), capitanati dal cantautore irlandese trapiantato negli States Ben Glover (di cui mi ero occupato a fine 2014 per il suo pregevole Atlantic http://discoclub.myblog.it/2014/11/15/vita-musicale-divisa-belfast-nashville-ben-glover-atlantic/ ), affiancato da due autori e musicisti americani, Joshua Britt e Neilson Hubbard (anche produttore del lavoro), che con l’aiuto di altri validi musicisti e collaboratori, tra cui spiccano Heather e Kris Donegan, Danny Mitchell, Dean Marold, Eamon McLoughlin e le brave, e forse meno conosciute di quanto meritino, cantanti Kim Richey http://discoclub.myblog.it/tag/kim-richey/ e Gretchen Peters, che, tutti insieme si sono ritrovati a incidere (a loro insaputa) in quella che viene considerata la casa colonica più “infestata” d’America, la Octagon Hall Franklin nel Kentucky, sessanta miglia a nord di Nashville https://www.youtube.com/watch?v=TAwEyiBWY9Y . Tutto questo progetto parte da una serie di documenti ritrovati (lettere, diari e poesie scritti dai militari della Orphan Brigade), messi in musica da questi baldi cantautori di talento, che hanno sfornato l’album rivelazione di fine 2015.
Per impostare il contesto im cui si svolge la vicenda, il disco si apre con i rintocchi funebri del piano in Octagon Hall Prelude, seguiti subito dalla meravigliosa Pale Horse, con un tamburo militare ad accompagnare una solenne melodia, passando poi al “groove” della sferragliante Trouble My Heart (Oh Harriett), con il banjo e la seconda voce della Richey in evidenza, il pungente country-walzer di I’ve Seen The Elephant, addolcito dalla voce di Gretchen Peters, e una intrigante marcetta a ritmo di gospel come Sweetheart (con una tromba lacerante nel finale). Dopo una buona “disinfestazione” le storie ripartono con il lamento delicato di Last June Light e il dolce mandolino che accompagna le voci femminili in The Story You Tell Yourself (su tutte quella della Richey), mentre We Were Marching On Christmas Day è una ballata palpitante, seguita dalla strumentale e fischiettata Whistling Walk.
Il racconto prosegue ancora con Good Old Flag un tipico brano dall’andatura mid-tempo, per poi passare al lamento in salsa irlandese di una Cursed Be The Wanderer (dove si nota lo zampino di Glover), che ci mette del suo (con solo voce e chitarra) anche nel tradizionale accorato Paddy’s Lamentation, arrivando infine al termine del racconto con la struggente bellezza di Goodnight Mary, una sognante e intensa ninna-nanna del duo Hubbard e Richey, e una finale The Orphans cantata da Glover e Donegan (supportati nuovamente dalle voci femminili), doveroso omaggio ai soldati che hanno ispirato il nome di questo magnifico “combo”.
Soundtrack To A Ghost Story è la perfetta colonna sonora di una storia vera, che rappresenta uomini veri, ambientata a cavallo della guerra civile americana, ma è anche una “ghost story” cantata e narrata logicamente con forti influenze letterarie. La cosa particolare di questo lavoro è che ascolto dopo ascolto, le trame del disco si sviluppano in modo diverso, con arrangiamenti che spaziano dal folk al rock, dal gospel al country, con bellissimi testi che raccontano di vita e di morte (e che trovate acclusi meritoriamente tradotti in italiano nella versione della Appaloosa), con un percorso sonoro accattivante e coinvolgente.
Per chi ama le storie vere e la buona musica, un vero balsamo, credetemi. Imperdibile!
Tino Montanari