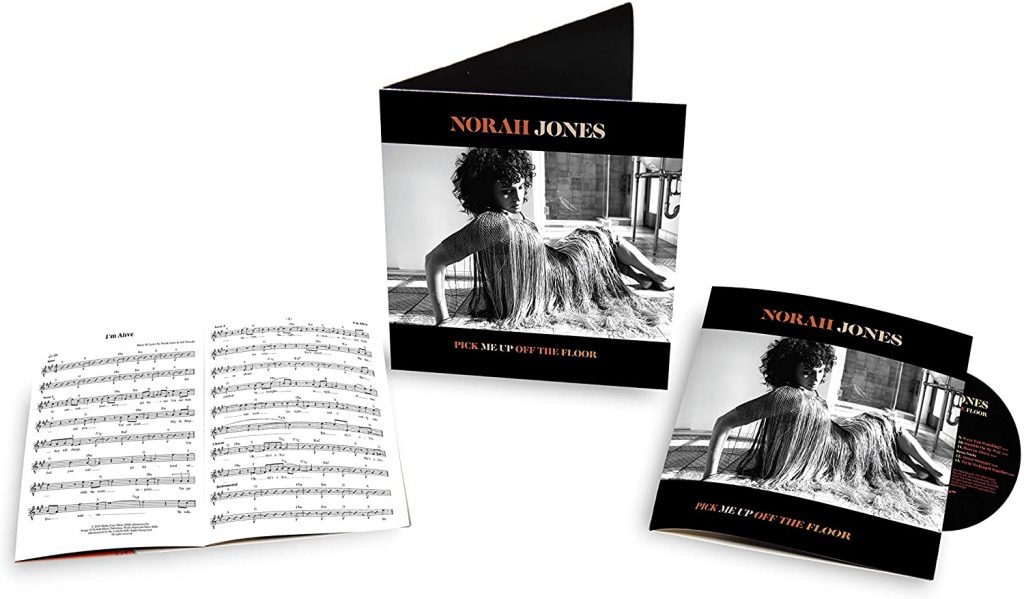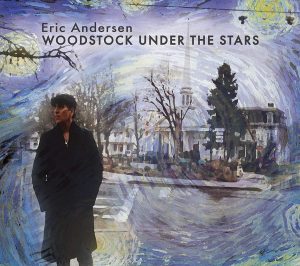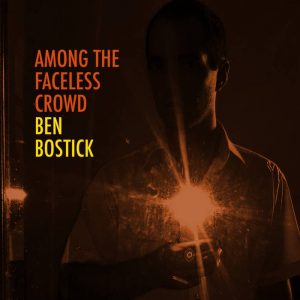*NDB Causa problemi tecnici di connessione, ovviamente non dipendenti dalla mia volontà, ma generalizzati nella zona di Milano, da cui opero con il Blog, per un paio di giorni non è stato possibile inserire aggiornamenti con nuovi Post. In extremis, visto il titolo, aggiorno con questo nuovo articolo scritto da Marco, sulla serie dei concerti ufficiali del Boss. Poi da domani, sperando che il problema sia risolto in modo definitivo, provvederò a recuperare i Post mancanti. Per il momento buona lettura, e scusate il titardo.
Bruce Springsteen – Stockholm 2005 – live.brucespringsteen.net/nugs.net 2CD – Download
Sono pronto a scommettere che se doveste chiedere a cento fans di Bruce Springsteen quale tournée tra quelle intreprese dal loro idolo sia la preferita, nessuno sceglierà i due tour acustici rispettivamente del 1995-1997 e del 2005: questo non perché in quelle due serie di spettacoli in solitaria il Boss abbia deluso, ma non si può ignorare che la fama di più grande intrattenitore dal vivo al mondo il nostro se la sia fatta come rocker a capo della E Street Band. Io stesso, che ho visto Bruce una decina di volte, pur avendone la possibilità non ho mai preso i biglietti per i due tour di cui sopra, in quanto a mio parere anche per un fuoriclasse come lui è dura mantenere desta l’attenzione per due ore e mezza da solo sul palco. Questo cappello serve per introdurre la penultima uscita della serie live tratta dagli archivi del Boss, che documenta appunto una serata presa dalla tournée del 2005 seguita alla pubblicazione dell’album Devils And Dust, e per l’esattezza uno show del 25 giugno all’Hovet, un impianto polisportivo che sorge a Stoccolma (comincio a pensare che tra i curatori di questa serie ci sia qualche scandinavo, dato che è la quinta uscita a riguardare un concerto tenuto nella penisola nordica, tre in Svezia e due in Finlandia).
Bruce come ho già detto in altre occasioni si presenta da solo (c’è però una tastiera “off-stage”, suonata da Alan Fitzgerald), ma a differenza del tour di The Ghost Of Tom Joad in cui si limitava a strimpellare la chitarra acustica ed a soffiare nell’armonica, qui si cimenta con chitarre sia acustiche che elettriche, ovviamente ancora armonica, ukulele, piano ed organo a pompa. Il pubblico svedese è caldo e partecipe, ed il Boss si presenta in buona forma anche se, come ho già accennato, lo Springsteen rocker è tutt’altra cosa rispetto alla versione folksinger: la classe però è la stessa e lo show è comunque godibile anche se qualche momento meno riuscito c’è, soprattutto a causa della decisione del nostro di stravolgere l’arrangiamento di alcuni pezzi con risultati alterni. I brani di Devils And Dust la fanno prevedibilmente da padroni, con ben otto selezioni (ed un cenno speciale lo meritano Long Time Comin’, Black Cowboys, Jesus Was An Only Son e Matamoros Banks), mentre stranamente da Tom Joad viene suonata solo la peraltro bellissima Across The River e da Nebraska (che poi è l’unico album di studio di Bruce veramente acustico) una Reason To Believe solo per armonica e voce filtrata, uno stravolgimento che reputo poco riuscito e difficilmente digeribile.
Ci sono altri arrangiamenti particolari, come l’opening track Downbound Train molto rallentata per voce ed organo, una The River pianistica (non male) ed una Point Blank in cui il Boss si accompagna al piano elettrico togliendole un pizzico di pathos; per contro, la My Hometown eseguita anch’essa al piano (acustico) è forse addirittura meglio di quella “lavorata” di Born In The U.S.A. Non mancano le rarità in scaletta, sia rispetto alle setlist abituali di questo tour (la discreta Empty Sky e la sempre stupenda Lucky Town) che in assoluto, come la b-side Part Man, Part Monkey e la pochissimo eseguita Walk Like A Man (tratta da Tunnel Of Love). E poi, visto che siamo pur sempre parlando di un concerto di Springsteen, ci sono anche diversi “magic moments” come la pianistica e toccante The Promise, un’intensa The Rising, convincente anche in questa veste spoglia, e la folkeggiante This Hard Land. La parte finale dello show inizia benissimo, con una coinvolgente Ramrod arrangiata quasi cajun, un’ottima Bobby Jean molto folk ed una pimpante ed energica Blinded By The Light, ma poi a mio parere si sgonfia negli ultimi due brani (cosa inaudita per un live del Boss, che è abituato a dare il meglio proprio nei bis), cioè una The Promised Land rallentatissima ed irriconoscibile (e francamente noiosa) ed una rilettura per voce ed organo di Dream Baby Dream dei Suicide, ripetitiva e troppo lunga.
Gli estimatori dello Springsteen elettrico (cioè tutti) si potranno ampiamente rifare con la prossima uscita, che documenterà una delle serate considerate migliori del famoso Reunion Tour del 1999 con la E Street Band.
Marco Verdi