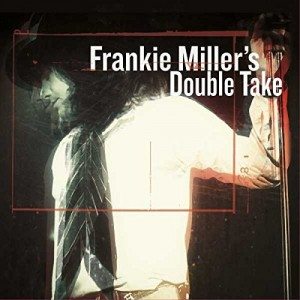Casey Donahew – All Night Party – Almost Country Rec./Thirty Tigers CD
Casey Donahew, texano di Burleson, è in giro ormai da dieci anni, ed in ambito country-rock è oggi uno degli acts più quotati dal vivo, sia in Texas che negli stati limitrofi. La sua miscela di country e rock’n’roll ad alto tasso elettrico e chitarristico può diventare letteralmente esplosiva on stage (come testimonia il suo unico live album, Raw-Real In The Ville, del 2008), e ciò si riflette anche nei suoi precedenti cinque album di studio, vere e proprie espressioni di puro Texas country’n’roll http://discoclub.myblog.it/2013/07/24/lassu-sulle-montagne-puro-texas-country-casey-donahew-band-s/ . All Night Party, già tutto un programma nel titolo, è il suo nuovissimo lavoro, e non sfugge certo alla regola: musica elettrica, diretta, senza passaggi a vuoto o momenti sdolcinati, con la ritmica quasi sempre a palla, un perfetto disco da bar band, da suonare a volume alto e magari in compagnia di una birra ghiacciata. I musicisti coinvolti non sono molti, meno di una decina, ma suonano forte ed in maniera tosta (tra di loro spiccano le chitarre di Kenny Greenberg e Rob McNelly e la sezione ritmica formata da Steve Mackey al basso e Nir Z alla batteria), il tutto con la produzione curata di Josh Leo, uno che ha già lavorato con Lynyrd Skynyrd, Restless Hearts, Alabama e Jo-El Sonnier.
Non c’è molto altro da aggiungere se non esaminare i dieci pezzi che compongono All Night Party: se siete abituali lettori di queste pagine virtuali avrete capito perfettamente di che tipo di musica sto parlando. Kiss Me si apre con un arpeggio di banjo, poi entra il resto della band (ed il ritmo è subito alto), un brano molto elettrico con il nostro che srotola una melodia diretta ed uno di quei ritornelli che non fanno prigionieri (e c’è anche un pregevole assolo chitarristico). Country Song aggiunge una buona dose di rock al titolo, c’è anche un violino, oltre ad un refrain forse un po’ ruffiano ma di indubbia efficacia https://www.youtube.com/watch?v=9Ygi4VwmD08 ; College Years è introdotta da un riff alquanto duretto e da una ritmica possente, una rock song a tutto tondo con un’anima southern, chitarre ruspanti e stacchi che di country hanno poco, mentre What Cowboys Do è la prima ballata, ma non aspettatevi niente di languido, il drumming rimane tosto e l’accompagnamento molto ricco, anche se il motivo centrale è abbastanza canonico.
La roboante Feels This Right dimostra che Casey dà il suo meglio nei pezzi più mossi, e ancora meglio fa con la trascinante That’s Why We Ride, un rockin’ country perfetto e dal ritmo acceso, con un ritornello vibrante ed un gustoso doppio assolo delle due chitarre soliste: se dovessi scegliere io, il singolo sarebbe questo. That Got The Girl è più pacata e cantata in maniera distesa, anche se il sapore del Sud è molto presente, mentre Josie Escalido è uno strepitoso tex-mex tune, con una melodia di primissima qualità ed una base strumentale che sa di border lontano un miglio, completo di fisa e fiati mariachi ben in evidenza: un pezzo di bravura davvero brillante, che varrebbe da solo mezza stelletta in un ipotetico giudizio https://www.youtube.com/watch?v=XAEH_uVrfh4 . Il CD si chiude con le roccate e vigorose White Trash Bay e Going Down Tonight, con la seconda che risulta la più sudista del disco (il botta e risposta voce solista-coro femminile è molto Skynyrd), anche se la prima è a mio parere più riuscita e coinvolgente. All Night Party mantiene quello che promette nel titolo, vero country’n’roll texano just for fun, con la sorpresa di Josie Escalido che rivela che Casey Donahew non è solo bravo a mostrare i muscoli ma sa essere anche un bravo songwriter: ora secondo me sono maturi i tempi per un altro disco dal vivo, magari registrato al Billy Bob’s Texas.
Marco Verdi