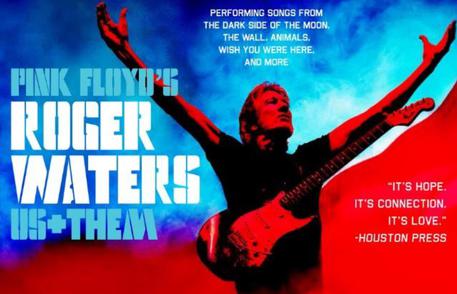Dawes – Good Luck With Whatever – Rounder Records
“Ascoltate questi ragazzi, sono davvero forti!” Questa frase, rivolta a me e ai miei quattro amici nel backstage del Jazzaldia Festival di San Sebastian, nell’ormai lontano 24 luglio 2011, veniva non certo da uno qualunque ma dall’illustre protagonista di quella fredda e piovosa serata, Jackson Browne, e si riferiva ai quattro giovani musicisti che avrebbero suonato con lui e prima di lui, i californiani Dawes, supportati per quel breve tour europeo anche dal loro produttore, l’ottimo Jonathan Wilson. E in effetti se la cavarono egregiamente, sia presentando i pezzi del loro secondo album Nothing Is Wrong nel set di apertura, sia suonando in modo impeccabile i classici del loro illustre mentore, For Everyman, The Pretender, Running On Empty e parecchi altri, chiudendo la serata con un inatteso quanto brillante omaggio al grande e sempre compianto Warren Zevon.
I due fratelli Griffin e Taylor Goldsmith, rispettivamente il batterista e il chitarrista, nonché lead vocalist e compositore, insieme al bassista Wylie Gelber e al tastierista Tay Strathairn (dopo breve tempo rimpiazzato da Alex Casnoff) avevano esordito nel 2009 con il promettente North Hills, facendo subito intendere le loro potenzialità nel riproporre un sound molto influenzato dal folk rock westcoastiano degli anni settanta. Seguirono, con un notevole crescendo qualitativo, altri tre lavori, il già citato Nothing Is Wrong (2011), Stories Don’t End (2013) e quello che tuttora considero il migliore della loro discografia, All Your Favorite Bands, pubblicato nel 2015 https://discoclub.myblog.it/2015/06/03/from-los-angeles-california-the-dawes-all-your-favourite-bands/ . L’anno seguente giunse, del tutto inatteso, il vero passo falso della loro ancor breve carriera. We’re All Gonna Die (già dal titolo non esattamente beneaugurante) esibiva una serie di canzoni modeste, soffocate da una valanga di overdubs, suoni sintetizzati e pattern elettronici. Dall’ imbarazzante singolo When The Tequila Runs Out e relativo video si ricavava la spiacevole impressione che i nostri quattro si fossero presi una colossale sbronza in campo creativo. Per fortuna, almeno sul palco, aggiustarono il tiro come dimostra il discreto live album, venduto solo sul loro sito, We’re All Gonna Live.
Senza dubbio una delle cause del loro rinsavimento va attribuita al ritorno in cabina di regia di Jonathan Wilson che ha determinato il ritorno a suoni e arrangiamenti adeguati alle loro caratteristiche nel positivo Passwords, uscito un paio d’anni fa https://discoclub.myblog.it/2018/08/04/al-solito-buon-rock-californiano-ma-possono-fare-meglio-dawes-passwords/ .
Per produrre il nuovo Good Luck With Whatever, i Dawes si sono affidati nientemeno che a Dave Cobb, un nome una garanzia, come dimostrano le innumerevoli brillanti pubblicazioni discografiche da lui curate negli ultimi anni, e il risultato si vede, e sente, eccome! I suoni e le armonie vocali tornano a risplendere, Lee Pardini, ultimo tastierista aggregatosi al gruppo quattro anni fa, lascia perdere sintetizzatori e amenità del genere per dedicarsi con ottimi esiti soltanto al pianoforte e all’hammond e, non ultimo, la qualità dei brani torna ad essere degna del loro passato. Si parte subito col piede giusto nell’iniziale Still Feel Like A Kid, il singolo più recente pubblicato a fine agosto, un robusto e accattivante inno all’eterna giovinezza che deriva dal suonare in una band, con tanto di coretti che citano i Beach Boys, in omaggio all’età dell’oro del sound californiano. Piano e chitarra elettrica aprono la title-track, un bel mid tempo che ci rituffa negli anni settanta come solo i Jayhawks e pochi altri hanno saputo fare oltre a loro.
Between The Zero And The One è una sontuosa ballatona che si colloca tra le cose migliori che Taylor Goldsmith sia stato capace di scrivere finora, mi riferisco a gioiellini come Fire Away, Most People o Things Happen dei precedenti dischi, con quell’incedere maestoso e classico che si fa immediatamente apprezzare, scandito dai limpidissimi tocchi del piano e dalla incalzante batteria del fratello Griffin. None Of My Business viaggia veloce al ritmo dei mitici Creedence e Taylor regala una performance vocale degna dell’icona John Fogerty (date un’occhiata su You Tube al duetto tra discepolo e maestro in Someday Never Comes, al David Letterman Show, e avrete la conferma di tali affinità).
Quasi a fare da spartiacque tra le due parti vitali ed energiche dell’album, troviamo la tonificante oasi acustica di St. Augustine At Night, per voce, chitarra acustica e delicati contrappunti di basso e pianoforte. Poi i Dawes riaccendono i motori col primo singolo uscito alla fine di luglio Who Do You Think You’re Talking To? a cui possiamo perdonare quella ritmica un po’ “finta” a fronte di un riff indovinato e un ritornello accattivante che ti entra subito nella testa https://www.youtube.com/watch?v=4O7VVDxb_us . Didn’t Fix Me possiede invece il timbro intenso ed avvolgente che ritroviamo in tanti capolavori usciti dalla penna di brother Jackson Browne, con il piano e le chitarre che giocano a rincorrersi su una linea melodica seducente e malinconica. Free As We Wanna Be, altri tre minuti di pura piacevolezza sonora con il piano ancora splendido protagonista, potrebbe essere considerato l’accorato saluto dei Dawes ad un altro gigante mai abbastanza rimpianto, Tom Petty, mentre la conclusiva Me Especially è un lento spezzacuori che dimostra quanto Taylor e soci abbiano interiorizzato gli insegnamenti della premiatissima ditta Don Henley & Glenn Frey.
Ottimo lavoro Mr. Cobb! I Dawes sono tornati nel lotto delle my favorite bands.
Marco Frosi