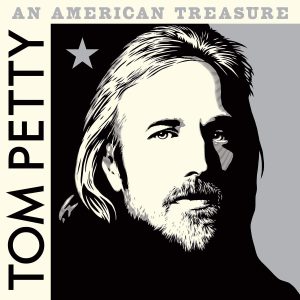Hawks And Doves – From A White Hotel – Jullian CD
Gli Hawks And Doves sono in realtà l’ultima creatura di Kasey Anderson, rocker di Portland, Oregon, che ha già all’attivo tre album come solista e due come leader di un’altra band, The Honkies. Anderson è anche però un personaggio molto particolare, da prendere con le molle, in quanto nel 2012 è stato dichiarato affetto da disordine bipolare (e ha dovuto dunque affrontare una terapia decisamente intensa), ed in seguito si è fatto pure due anni di galera (era stato condannato a quattro), per aver chiesto finanziamenti al fine di produrre un fantomatico album a scopo benefico, arrivando addirittura a falsificare le mail di Jon Landau, potente manager di Bruce Springsteen. Non esattamente uno stinco di santo quindi, ma il mio dovere è quello di giudicare la sua musica, e devo riconoscere che in From A White Hotel, album di debutto degli Hawks And Doves (nome preso da un disco del 1980 di Neil Young, invero non memorabile) di musica buona, ed a tratti ottima, ce n’è parecchia.
Kasey, che è il compositore, cantante e chitarrista ritmico del gruppo, è affiancato da Jordan Richter, chitarra solista, Ben Landsverk, basso, tastiere e viola, e Jesse Moffat, batteria, oltre ad essere coadiuvato da qualche ospite selezionato, tra i quali spiccano il sassofonista Ralph Carney, Kurt Bloch, già musicista per conto proprio, e soprattutto Eric Ambel, ex chitarrista dei Del Lords. From A White Hotel è un bel disco di puro rock americano, chitarristico e diretto, con canzoni che piacciono al primo ascolto e che si rifanno ai luminari di questo tipo di suono; Anderson sa comporre, ha il senso della melodia ed è anche creativo, in quanto il disco non è per nulla monotematico, ma invade qua e là anche territori diversi dal rock puro e semplice, ma senza mai dare la sensazione di dispersività. L’inizio è davvero ottimo con The Dangerous Ones, un brano rock elettrico di presa immediata, chitarristico e trascinante, che ricorda molto lo Steve Earle del periodo Copperhead Road, anche per la similarità del timbro vocale di Kasey con quello di Steve. Decisamente bella anche Chasing The Sky, altra rock song pulsante e diretta, che stavolta fa pensare al compianto Tom Petty: puro rock’n’roll chitarristico, davvero godibile (e la presenza di Ambel ha un senso, qui è nel suo elemento); Every Once In A While è cadenzata, con un sapore errebi dato da una piccola sezione fiati ed un’atmosfera vintage, mentre Get Low è annerita, bluesata e paludosa, ancora con i fiati che fanno capolino ed un feeling notevole, un pezzo che fa capire che il nostro ha ascoltato molto anche Tom Waits.
Geek Love è una ballata pianistica decisamente intensa, con un mood romantico che contrasta con la voce roca di Kasey, ma riesce lo stesso a toccare le corde giuste (ed anche qui Waits fa capolino, il suo lato più melodico), mentre con Bulletproof Hearts torniamo al rock di stampo californiano, un brano terso, vibrante e che coinvolge fin dalle prime note; Lithium Blues è scura e cupa, un blues che pare influenzato dalle paludi della Louisiana, un pezzo di grande fascino e suonato in maniera splendida. A Lover’s Waltz è una canzone suggestiva, per voce, organo e viola, un brano di grande pathos che dimostra che Anderson non è solo un rocker, ma un musicista a tutto tondo; il CD si chiude con la lenta Clothes Off My Back, dalla calda atmosfera southern soul, e con la title track, uno slow elettrico dalla ritmica quasi tribale. Forse Kasey Anderson potrebbe non essere la persona più adatta alla quale prestare dei soldi, ma se vorrete dare un ascolto ai suoi Hawks And Doves secondo me non ve ne pentirete.
Marco Verdi