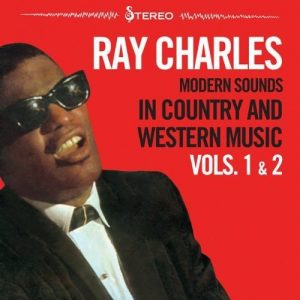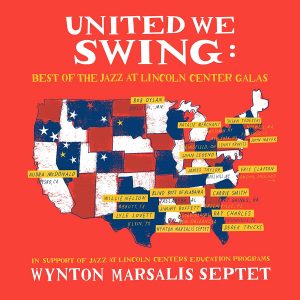Ella Fitzgerald – The Lost Berlin Tapes – Verve/Universal CD
Mack The Knife: Ella In Berlin, live album uscito nel 1960, è stato uno dei dischi di maggiore successo della grandissima Ella Fitzgerald, semplicemente una delle massime cantanti di tutti i tempi, al punto da convincerla a tornare nella metropoli tedesca sia nel 1961 (anno in cui venne costruito il famigerato muro) che nel 1962. Se il concerto del ’61 verrà pubblicato con trent’anni di ritardo (Ella Returns To Berlin), di quello del ’62 non si saprà più nulla, al punto da far pensare che quella registrazione fosse andata persa per sempre. Fortunatamente non è stato così, ed oggi finalmente possiamo godere di quella performance grazie a The Lost Berlin Tapes, un CD che documenta il concerto del 25 marzo del 1962 allo Sportpalast, nato grazie all’iniziativa di Gregg Field, batterista jazz dal fantastico pedigree (Frank Sinatra, la Count Basie Orchestra e la stessa Fitzgerald) ed affermato produttore ed organizzatore di concerti (c’è lui dietro lo show Ella At 100, che si è tenuto nel 2017 al mitico Apollo Theatre di New York per celebrare il secolo dalla nascita della grande cantante ed è stato pubblicato su CD qualche mese fa).
Una volta messe le mani sui nastri originali della serata, Field ha svolto un lavoro certosino insieme al produttore Ken Druker, remixando completamente il tutto ed affidando poi il lavoro finito alle sapienti mani del mitico Greg Calbi per il mastering: il risultato è un album dal vivo con un sound davvero spettacolare, come se fosse stato registrato da poche settimane e non quasi 60 anni fa. Ma il suono da solo non basterebbe se non ci fosse anche la qualità della performance, e The Lost Berlin Tapes è forse addirittura superiore al disco pubblicato nel 1960: Ella, qui al massimo della sua potenza vocale ed interpretativa (all’epoca del concerto non aveva neanche 45 anni), ammalia il pubblico con una prestazione davvero strepitosa tirando fuori il meglio dalla sua fantastica ugola, presentandosi con alle spalle un terzetto formidabile composto da Paul Smith, pianista superbo (già presente nel live del ’60), e dai “nuovi” Wilfred Middlebrooks al basso e Stan Levey alla batteria (NDM: rispetto a Mack The Knife manca il chitarrista, ma il livello del concerto non ne risente). Grande band quindi, ma la differenza la fa Ella, una che davvero avrebbe potuto cantare qualsiasi cosa con la massima naturalezza, con una voce che è un vero e proprio strumento aggiunto.
Ascoltiamo quindi (con una resa sonora, ripeto, spettacolare) classici senza tempo come Cheek To Cheek (sentite come canta e come la segue il trio, già l’inizio è da cinque stelle), la raffinatissima My Kind Of Boy, una superlativa versione della celeberrima Cry Me A River e via via titoli come I Won’t Dance (che classe), Angel Eyes, Taking A Chance On Love, C’Est Magnifique, Good Morning Heartache, tutti interpretati in modo magnifico e suonati dal trio con grande eleganza e robuste dosi di swing (ed il pubblico, decisamente caldo, applaude sempre più convinto man mano che la serata prosegue). C’è anche una divertita ripresa di Hallelujah, I Love Her So di Ray Charles (che Ella vira al femminile cantando quindi “I love him so”), eseguita addirittura due volte di fila e con un accenno a Hit The Road, Jack, ed una breve ma intensissima rilettura del classico di George Gershwin Summertime, semplicemente sublime. Dopo una soffusa Mr. Paganini, in cui Ella gigioneggia piacevolmente, il concerto si chiude con l’immancabile Mack The Knife e con una fluida Wee Baby Blues, cantata tanto per cambiare senza sbavature e con una eccellente prova di Smith al piano.
The Lost Berlin Tapes è un live album strepitoso, grande musica che va aldilà del genere jazz e che ci fa riassaporare nuovamente il talento cristallino di Ella Fitzgerald: non per niente la chiamavano “The First Lady Of Song”.
Marco Verdi