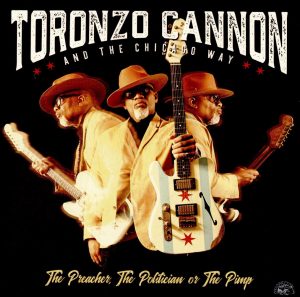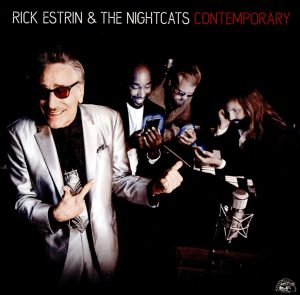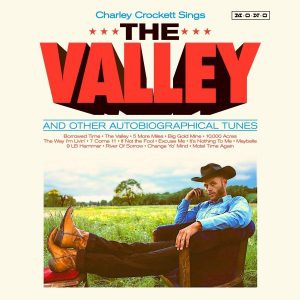The Hold Steady – Thrashing Thru The Passion – Frenchkiss Records
Sono passati cinque anni dalla pubblicazione dell’ultimo album degli Hold Steady, Teeth Dreams, un buon disco che aveva ricevuto critiche positive https://discoclub.myblog.it/2014/05/29/buongustai-del-rock-americano-the-hold-steady-teeth-dreams/ , ma che forse non raggiungeva le vette di quelli del periodo 2006-2008, Boys And Girls In America (forse il migliore) e Stay Positive: poi la band aveva pubblicato un live e ad inizio 2010 il pianista Franz Nicolay (che era l’altra stella del gruppo) aveva annunciato il suo abbandono. Nel frattempo, nel 2012, Craig Finn aveva iniziato anche una carriera solista parallela, che finora ha visto l’uscita di quattro album, l’ultimo dei quali, l’ottimo I Need A New War, è uscito da pochissimo, a fine aprile, e nel 2016 Nicolay è rientrato in formazione, portando la line-up a sei elementi. In questi anni in cui Finn pubblicava i suoi dischi solo, comunque la band , dalla fine del 2017, ha iniziato a pubblicare nuove canzoni, solo a livello digitale. Due a fine 2017, altre due l’anno successivo, e una a marzo di quest’anno, tutti brani inseriti nella seconda parte del nuovo album Thrashing Thru The Passion che, per chi non ama il download e quindi non conosceva già le canzoni, suona fresco e pimpante, come nelle loro migliori prove.
Il “solito” rock americano dove confluiscono le immancabili influenze springsteeniane, quelle del rock di Minneapolis, ma anche del primo Graham Parker, con in più i testi visionari e complessi di Finn, e quel suo tipico e laconico cantar parlando, mentre intorno ribolle il rock veemente creato dalla band che ogni tanto si stempera anche in splendide ballate. Il nuovo CD è edito dalla loro etichetta personale, quella che pubblicava i dischi ad inizio carriera, quindi un ritorno alle origini, come certifica anche il sound, a partire dalla iniziale Denver Haircut, energica anziché no, con Tad Kubler e Steve Selvidge che strapazzano le loro chitarre, mentre il batterista Bobby Drake percuote i suoi tamburi con voluttà, un pezzo degno di uno dei suoi eroi come Springsteen; anche Epaulets (ovvero “spalline”) ricorda il Boss, grazie all’uso dei fiati, ma forse ancor di più il Graham Parker anni ’70, con Nicolay che continua il suo ottimo lavoro al piano.
You Did Good Kid, il recente singolo, non entusiasma, troppa confusione e poca melodia, ma alla fine si ascolta con attenzione per i suoi ritmi sghembi, mentre Traditional Village, con intrecci di piano, chitarre e sax, ed un ritmo incalzante. ricorda ancora il Bruce anni ’80, sempre con il parlar cantando di Finn in evidenza; Blackout Sam è l’unica ballata, che narra di un pianista che si crede Randy Newman, introdotta dal piano di Nicolay poi entra il resto della band, mentre Franz lavora di fino anche all’organo, infine arriva il sax e il brano diventa sempre più intenso ed appassionato, fino all’intervento delle chitarre soliste gemelle, bellissima. Questi sono i pezzi “nuovi”, esclusivi per l’album, vediamo il resto:
T-shirt Tux, tutta riff e un groove alla Thin Lizzy, quando Lynott impiegava il suo stile più springsteeniano (eccolo di nuovo), non è mera imitazione, Finn ha una sua personalità, ma i punti di contatto ci sono, con piano e chitarre che impazzano di nuovo https://www.youtube.com/watch?v=qiRCCfQOrUk , con la precedente Entitlement Crew che è un altro incalzante e impetuoso rocker nella migliore modalità degli Hold Steady, batteria pimpante, organo vintage e fiati travolgenti. Star 18 cita nel testo Mick Jagger, Peter Tosh e pure gli Hold Steady, con Kubler che inchioda un ottimo breve assolo e Drake e il bassista Galen Polivka, che tengono il ritmo sempre alla grande, mentre Finn declama da par suo; The Stove And The Toaster è un altro poderoso esempio di ottimo rock and roll, con il basso che pompa di brutto, la batteria ovunque, i fiati all’unisono che impazzano, e un altro assolo da sballo di Kubler a seguire un breve intermezzo delle tastiere di Nikolay https://www.youtube.com/watch?v=L9tu5Jv-j4I . Chiude un altro pezzo tutto riif, Confusion In The Marketplace con una dichiarazione di intenti finale di Craig Finn , “I don’t want to dick around/I just want to devastate.”
Bentornati.
Bruno Conti