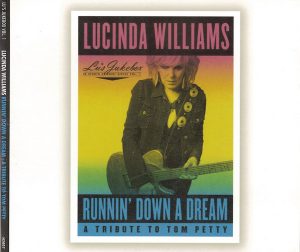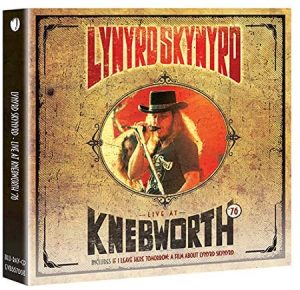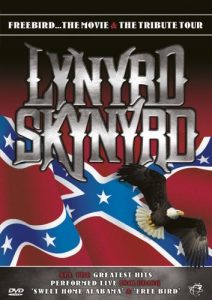VV.AA. – Dylan Revisited – Uncut/Bandlab UK CD
Tra meno di un mese, il 24 maggio, il grande Bob Dylan compirà 80 anni, e gran parte delle testate musicali nel mondo sono già da tempo in fibrillazione per festeggiare a modo loro l’evento. L’unico che sta brillando per il suo assoluto silenzio è proprio il diretto interessato, ma direi una bugia se mi dichiarassi sorpreso dal momento stiamo parlando di un personaggio che ha sempre detestato le autocelebrazioni (il famoso concerto-tributo del 1992 al Madison Square Garden era stato voluto dalla Columbia, e le immagini facevano capire benissimo che Bob avrebbe preferito di gran lunga essere da un’altra parte). Siccome anche la Sony non ha finora annunciato nulla a livello discografico, e non è detto che ci sia qualcosa in programma, vorrei parlarvi di un CD molto particolare oltre che bello, che non si trova nei negozi ma che non è neppure così difficile procurarsi. E’ tradizione delle riviste musicali inglesi, specialmente Classic Rock, Mojo ed Uncut, gratificare i suoi lettori con CD gratuiti allegati alle varie mensilità, perlopiù compilation di materiale già edito riguardanti solitamente uno specifico argomento.
Nel suo ultimo numero però Uncut ha fatto le cose in grande, regalando un dischetto intitolato Dylan Revisited che non è il solito tributo low-cost costruito con performances già note, ma una compilation di incisioni nuove di zecca realizzate apposta per la rivista, con la chicca di un inedito assoluto dello stesso Dylan! Una succosa opportunità di portarsi a casa un dischetto esclusivo, tra l’altro con una spesa minima: infatti l’uscita è acquistabile direttamente sul sito di Uncut, e per soli 12 euro (non pagate neanche la spedizione) riceverete a casa un numero molto interessante della rivista, oppure lo trovate nelle edicole e librerie piuù fornite. Un omaggio a Dylan a 360 gradi attraverso i ricordi di musicisti e produttori che lo hanno conosciuto, con più di un aneddoto divertente. E poi ovviamente c’è Dylan Revisited, in cui il Premio Nobel viene omaggiato da 14 belle riletture da parte di musicisti perlopiù emergenti, anche se non mancano i nomi di prima fascia, ma con tutte cover rispettose degli originali e nessuno sconfinamento in sonorità bislacche. Il CD si apre con il già citato inedito dylaniano: Too Late è una ballata acustica con una leggera percussione alle spalle tratta dalle sessions di Infidels (e che dovrebbe anticipare il sedicesimo volume delle Bootleg Series, dedicato proprio alle prolifiche sedute dell’album del 1983, in uscita pare entro l’anno, forse a luglio, visto che è in uscita anche un estratto in vinile per il Record Store Day), un brano che poi si sarebbe evoluto nella già nota Foot Of Pride. Una bella canzone eseguita in modo rilassato da Bob, che non somiglia molto a ciò che sarebbe diventata né come testo né come melodia (forse ricorda di più George Jackson, il raro singolo del 1971): dopo l’ascolto ho ancora più voglia del nuovo episodio delle Bootleg Series.
E partiamo con il tributo vero e proprio, che inizia col botto: Richard Thompson è un fuoriclasse assoluto, e This Wheel’s On Fire viene proposta con un bell’arrangiamento elettroacustico con l’ex Fairport che suona tutti gli strumenti, nel suo tipico stile tra folk e rock; Courtney Marie Andrews è ancora giovane ma già esperta, e ci delizia con un’interpretazione voce e chitarra della splendida To Ramona, forse un po’ scolastica ma meglio così che stravolta, mentre i Flaming Lips rivestono di una leggera patina pop-psichedelica l’eterea Lay Lady Lay, che mantiene però la sua struttura acustica. I canadesi Weather Station propongono Precious Angel, dal periodo “religioso” di Bob, in una rilettura molto diversa, pianistica e lenta, con la voce solista femminile di Tamara Lindeman quasi sussurrata che accentua il tono di preghiera del brano; rimaniamo in Canada con i grandi Cowboy Junkies, che fanno una scelta non scontata prendendo dal recentissimo Rough And Rowdy Ways la bella I’ve Made Up My Mind To Give Myself To You, che fanno diventare uno splendido valzer dal sapore folk con la voce inconfondibile di Margo Timmins che come al solito si rivela l’arma in più del quartetto: sembrano tornati di botto i Junkies di inizio carriera, una cover magnifica, meglio anche dell’originale.
L’ex Sonic Youth Thurston Moore non si perde in sonorità strane e rilegge Buckets Of Rain per voce e chitarra, da perfetto folksinger, la cantante e chitarrista originaria del Mali Fatoumata Diawara offre una versione tutta ritmo e colori di Blowin’ In The Wind (registrata a…Como!), molto diversa dall’originale ma piacevole, mentre invece la giovane irlandese Brigid Mae Power nel riproporre la bella One More Cup Of Coffee ricalca abbastanza le atmosfere di Desire, violino a parte. Knockin’ On Heaven’s Door è materia pericolosa, ma la indie band Low (che ha in comune con Dylan la città d’origine, Duluth) se la cava benissimo con una interpretazione convincente, lenta e ricca di pathos, facendola diventare una rock ballad notturna e misteriosa. Il duo folk formato da Joan Shelley e Nathan Salsburg rifà Dark Eyes in maniera rigorosa, Patterson Hood e Jay Gonzalez dei Drive-By Truckers sono bravi e lo dimostrano con una Blind Willie McTell sofferta, bluesata e desertica (ma l’originale dylaniano è insuperabile), e lo stesso fa l’ex Be Good Tanyas Frazey Ford con un’ottima The Times They Are A-Changin’ in veste folk-rock ballad elettrica, con chitarre ed organo al posto giusto.
Finale con Jason Lytle, frontman dei Grandaddy, che ci regala una buona versione rilassata di Most Of The Time, con chitarra acustica e piano a scontornare la melodia, e con Weyes Blood (nome d’arte di Nathalie Laura Mering) che affronta in maniera classica la lunga ed impegnativa Sad Eyed Lady Of The Lowlands, riuscendo a fornire una prova decisamente efficace. Un tributo perfettamente riuscito questo Dylan Revisited, serio e ben fatto, che meriterebbe una distribuzione ben più capillare che come allegato ad una rivista mensile.
Marco Verdi