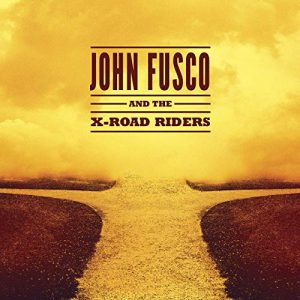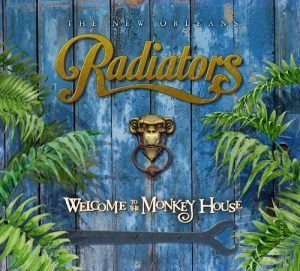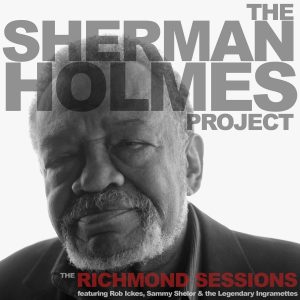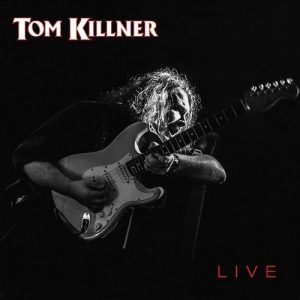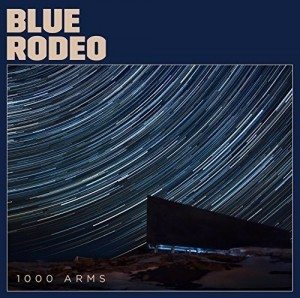John Fusco And The X-Road Riders – John Fusco And The X-Road Riders – Checkerboard Lounge Records
Il nome di John Fusco come musicista sicuramente dice poco ai più, ed in effetti questo album con gli X-Road Riders è il suo esordio. Ma se scaviamo più in profondità scopriamo che questo signore è colui che ha scritto il soggetto originale di Crossroads (in Italia Mississippi Adventure), l’ottimo film del 1986 di Walter Hill, che proponeva una versione romanzata del famoso patto siglato al crocevia tra Robert Johnson e il Diavolo, con la colonna sonora di Ry Cooder e Steve Vai nella parte di quel “diavolo” di un chitarrista che duella con Ralph Macchio. Fusco ha comunque scritto anche i soggetti di Young Guns I e iI, Hidalgo, Spirit, l’imminente Highwaymen di Kevin Costner, la serie televisiva Marco Polo per la Netflix, quindi non è il primo pirla che passa per strada, e comunque ha anche questa “passionaccia” per la musica, il blues(rock) nello specifico e per il suo esordio discografico si fa aiutare da Cody Dickinson dei North Mississippi Allstars, che nel CD suona chitarra, dobro, piano, basso e batteria, lasciando le tastiere a Fusco, che si rivela essere anche un notevole cantante, in possesso di una voce profonda, vissuta e risonante, ben sostenuta dalle gagliarde armonie vocali di Risse Norman, una vocalist di colore dal timbro intriso di soul e gospel, come dimostrano tutti insieme nella potente Rolling Thunder che apre l’album e dove la slide tangenziale di Dickinson è protagonista assoluta del sound.
Drink Takes The Man è anche meglio, con l’organo di Fusco e la chitarra di Cody a duettare, mentre John, con l’aiuto sempre della Norman, imbastisce un blues-rock quasi alla Allman Brothers, sapido e gustoso, sempre con le chitarre di Dickinson in grande spolvero. L’album è stato registrato ai Checkerboard Lounge Studios di Southaven, Mississippi, ed esce per l’etichetta dello stesso nome, al solito con reperibilità diciamo difficoltosa, ma vale la pena di sbattersi, perché il disco merita: in Poutine c’è anche una piccola sezione fiati guidata dalla tromba di Joshua Clinger, e il suono si fa più rotondo, con elementi soul sudisti, sempre caratterizzati dalla voce allmaniana di Fusco, dal suo organo scintillante, dalle chitarre di Dickinson e dalla calda vocalità della Risse. Hello Highway, con l’armonica dell’ospite Mark Lavoie in evidenza, più che un brano di Dylan (con cui ha comunque qualche grado di parentela) sembra un brano della Band, quando cantava Rick Danko, con il tocco geniale di un piano elettrico a rendere più intensa la resa sonora di questa bellissima canzone. E non è da meno anche A Stone’s Throw un’altra bella ballata gospel-rock che miscela il sound della Band e quello degli Allman, con la lirica solista di Dickinson a punteggiare splendidamente tutto il brano, mentre Fusco e la Norman si sostengono a vicenda con forza.
Non ci sono brani deboli in questo album, anche I Got Soul, quasi una dichiarazione di intenti, di nuovo con l’armonica di Lavoie e il sax solista di Bradley Jewett, ha ancora questo impeto del miglior blues sudista, con Fusco che rilascia un ottimo assolo di organo, senza dimenticare di lavorare di fino anche al pianoforte. Can’t Have Your Cake, sembra la sorella minore di Midnight Rider di Gregg Allman, un’altra southern ballad di grande fascino, cantata con impeto dal nostro amico, mentre la chitarra è sempre un valore aggiunto anche in questo brano https://www.youtube.com/watch?v=HAOlJvEL_lE ; Boogie On The Bayou, è un altro blues di quelli gagliardi, con piano elettrico, chitarra, ed organo a supportare con trasporto la voce vellutata e vibrante di Fusco. Anche Once I Pay This Truck Off non molla la presa sull’ascoltatore, questa volta sotto la forma di una ballata elettroacustica insinuante, sempre calda ed appassionata, grazie all’immancabile lavoro di grande finezza offerto da Cody Dickinson https://www.youtube.com/watch?v=roz27n9cTlU , che per il brano finale chiama a raccolta anche la solista del fratello Luther per una versione di grande forza emotiva del super classico di Robert Johnson Crossroad Blues, con la band che rocca e rolla di brutto sul famoso riff della versione dei Cream, e la slide che imperversa nel brano, grande anche la Norman, anche se forse avrei evitato il freestyle rap di Al Kapone che comunque non inficia troppo una grande versione https://www.youtube.com/watch?v=RgAWx9IhzU8 , all’interno di un album di notevole spessore complessivo.
Bruno Conti