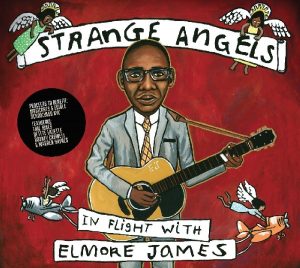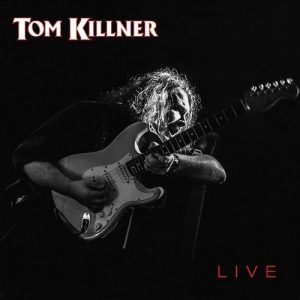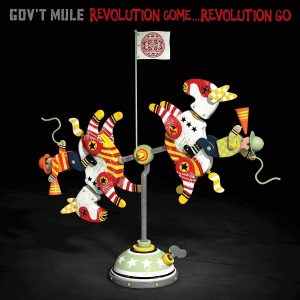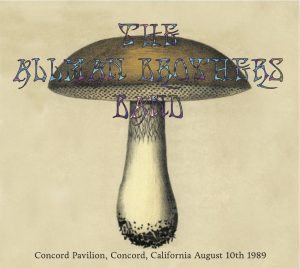Ann Wilson – Immortal – BMG CD
Mi sono sempre piaciute le Heart, duo femminile formato dalle sorelle Ann e Nancy Wilson, sia nelle loro espressioni più rock (spesso influenzate dai Led Zeppelin), sia nelle pagine più AOR della loro carriera (la seconda metà degli anni ottanta) https://discoclub.myblog.it/2016/12/24/un-po-di-sano-classic-rock-al-femminile-heart-live-at-the-royal-albert-hall/ , anche se non le ho mai seguito più di tanto né i loro progetti collaterali (The Lovemongers) né i loro album solisti. Sono stato però da subito incuriosito da questo Immortal, nuova fatica di Ann Wilson senza la sorella Nancy (ad undici anni dal suo primo solo album Hope & Glory, mentre i due EP a nome Ann Wilson Thing sono storia recente), in quanto trattasi di un album di cover. Fin qui nulla di strano, anche Hope & Glory non presentava brani originali, ma qui Ann ha deciso di omaggiare artisti che l’hanno influenzata od altri che semplicemente le piacciono, però con il comune denominatore del fatto che tutti i dieci nomi omaggiati sono ormai passati a miglior vita. Un tributo quindi sentito a musicisti che non sono più tra noi, con alcune scelte logiche ed altre decisamente più sorprendenti (lo dico subito, gli Zeppelin non ci sono, forse Ann ha considerato John Bonham un personaggio “collaterale” per quanto riguarda le composizioni dello storico gruppo).
Il disco, prodotto dalla Wilson insieme a Mike Flicker, è decisamente riuscito, in quanto Ann nella maggior parte dei casi reinterpreta brani più o meno noti con indubbia personalità, senza riproporre delle copie carbone degli originali, ed in più confermando di avere una delle più belle e potenti voci dell’intero panorama rock femminile. Un valido aiuto glielo ha dato anche la house band (Craig Bartok, chitarre, Andy Stoller, basso, Daniel Walker, tastiere, e Denny Fongheiser, batteria) ed un ridotto numero di validissimi ospiti che vedremo tra poco. Da un cover album di Ann Wilson mi sarei forse aspettato una preponderanza di omaggi a cantanti donne, ma in realtà ne troviamo solo due: You Don’t Own Me, grande successo della quasi dimenticata Lesley Gore, apre il CD in maniera splendida, con nientemeno che Warren Haynes alla chitarra solista, una versione solida, potente e bluesata, molto diversa dall’originale, cantata in maniera divina da Ann e con Warren che fende l’aria da par suo (e la mente va alle migliori pagine della collaborazione tra Beth Hart e Joe Bonamassa), mentre la nota Back To Black, di Amy Winehouse, è tutta giocata sulla vocalità profonda e ricca di sfaccettature della Wilson, un’interpretazione drammatica e densa di pathos (il languido violino è di Ben Mink, noto per le sue collaborazioni con k.d. lang) che rende giustizia nel modo migliore alla cantautrice inglese entrata a far parte del cosiddetto “Club dei 27”.
Ann si ricorda anche di Chris Cornell, ma non ripropone un pezzo dei Soundgarden, bensì degli Audioslave, I Am The Highway, che diventa una toccante rock ballad elettroacustica, cantata ancora splendidamente e con voce leggermente arrochita, mentre l’accompagnamento è limpido e scintillante, quasi di stampo californiano: bella canzone e grandissima interpretazione, una delle migliori del disco. Non viene dimenticato Tom Petty, anche se viene scelta la poco nota Luna (dal disco d’esordio del 1976 del biondo rocker), ancora con Haynes protagonista: la struttura del pezzo rimane “pettyana”, ma Warren le dona un tocco blues ed Ann canta in maniera decisamente sensuale, aiutata anche dal ritmo soffuso del brano. Grande classe. Anche I’m Afraid Of Americans non è tra i pezzi più noti di David Bowie (scritta dal Duca Bianco con Brian Eno, era sul controverso Earthling del 1997), ed Ann elimina le sonorità techno e drum’n’bass dell’originale e la indurisce oltremodo, con un mood quasi zeppeliniano (eccallà, direbbero a Roma), complici anche certi passaggi strumentali orientaleggianti: versione tosta di un brano comunque non memorabile. Con Politician (Cream, l’omaggio è chiaramente per Jack Bruce) la Wilson è invece nel suo ambiente naturale: canzone che già in origine era possente e granitica, e la “sorellona” non deve far altro che sfoderare la sua voce più “plantiana” per portare a casa il risultato, aiutata anche dagli ottimi interventi alla solista di Doyle Bramhall II https://www.youtube.com/watch?v=5qLRh6vYqqU .
Cambio completo di registro con la soffusa A Thousand Kisses Deep di Leonard Cohen, guidata ancora dal violino di Mink e con un background musicale da club jazz-lounge (ed anche i rumori di sottofondo sembrano provenire dall’interno di un bar), con la Wilson che mostra di saper usare anche il fioretto, modulando la voce con un tono confidenziale da femme fatale. Forse per omaggiare Glenn Frey c’erano canzoni più rappresentative di Life In The Fast Lane, che vede sì Glenn tra gli autori ma è sempre stata una canzone più di Henley e Walsh: Ann elimina il noto riff chitarristico, rallenta il tempo e le dona un sapore funky ed un arrangiamento moderno che non mi convince molto, anche se un mezzo scivolone si può perdonare. Come chiusura dell’album ecco due brani che non mi aspettavo: A Different Corner è un pezzo di George Michael, uno che non mi sarebbe mai passato per la testa di omaggiare, ma Ann non la pensa come me e ne fornisce una rilettura fin troppo sofisticata, che non solleva i dubbi del sottoscritto né sulla canzone né sull’arrangiamento un po’ artefatto; meglio Baker Street, il classico per antonomasia di Gerry Rafferty: ritmo accelerato, arrangiamento anche qui moderno ma con un marcato mood folk-rock, ed un notevole crescendo elettrico che rinuncia al celebre riff di sax: quasi un’altra canzone.
A parte un paio di incertezze, Immortal è quindi un gran bel disco, ed Ann Wilson conferma di avere una voce straordinaria, unita ad una capacità interpretativa non comune.
Marco Verdi