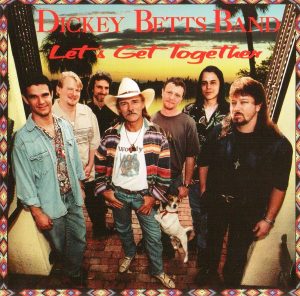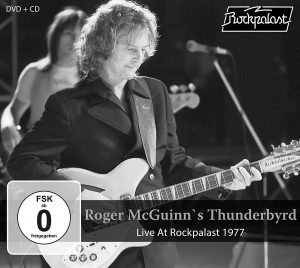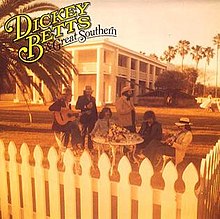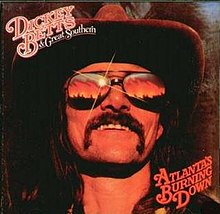Kris Barras Band – Light It Up – Mascot/Provogue
Kris Barras, da Toquay, contea del Devon, nel Sud dell’Inghilterra, è un personaggio dal passato avventuroso: combattuto (è il caso di dirlo) tra due passioni, quella per la musica, trasmessagli dal padre, e coltivata anche nella discoteca di famiglia, e quella per le arti marziali, di cui è stato campione sui ring di Tailandia e Las Vegas, nei combattimenti a mani nude. Poi ha saggiamente deciso di dedicarsi alla musica, pubblicando un mini ed un album a livello indipendente, prima di firmare per la Mascot/Provogue nel 2017 come Kris Barras Band, ed approdare, tramite gli auspici di Billy F. Gibbons, nella nuova formazione della Supersonic Blues Machine in sostituzione di Lance Lopez, per l’ultimo album dal vivo https://discoclub.myblog.it/2019/08/01/grande-rock-blues-tra-california-e-texas-per-un-trio-italo-anglo-americano-supersonic-blues-machine-road-chronicles-live/ , in cui Gibbons appare come guest in alcune canzoni. Barras ora pubblica questo Light It Up, secondo album per la Mascot e quarto in assoluto, accompagnato da Elliot Blackler al basso e da Will Beavis alla batteria, nonché da Josiah J. Manning, che oltre a produrre il disco suona anche le tastiere, ed è coautore con Kris di un paio di brani.
Devo dire che ero abbastanza prevenuto verso il super tatuato musicista inglese, che invece in questo album si conferma discreto cantante, con la classica voce da hard rocker, e buon chitarrista, mettendo a frutto gli amori del passato per Deep Purple, Stones, ma anche una propensione per il southern rock degli ZZ Top. La musica “sudista” (vista anche la collocazione geografica nel Regno Unito) e qualche tocco country-blues nell’iniziale “riffata” What You Get che ha pure qualche rimando a Bonamassa, e magari al gospel-rock è decisamente piacevole, con la slide e l’organo ben miscelati e un assolo che tanto mi ha ricordato il vecchio Alvin Lee. Broken Teeth (con un testo e un tiolo che rimandano ai suoi trascorsi di lottatore) è un ottimo esempio di rock sudista cantato a voce spiegata (con le backing vocalist impegnatissime), ritmi serrati, l’organo di Manning in bella evidenza, come pure la slide di Barras, veramente un bel pezzo rock con ulteriore grande accelerazione nel finale; niente male anche Vegas Son, un altro eccellente esempio di rock americano, groove marcato, riff di organo e chitarra e un refrain insinuante e orecchiabile, su cui si innesta un buon lavoro della solista di Kris.
La title track Ignite (Light It Up,) nonostante il lavoro dell’organo in primo piano e un suono più duro e riffato è più scontata, benché l’assolo di Barras cerchi di dargli maggiore consistenza; ancora organo e chitarra slide in azione in 6 AM, ma il suono rimane vicino all’AOR con qualche tocco sudista che ricorda il rock delle band più dure tipo 38 Special o Point Blank. Rain è una bella ballata dall’andatura elegante, sempre con tocchi sudisti e un sound più gentile, ancorato come sempre dall’organo di Manning e completato da un lirico assolo della chitarra del leader; mentre Counterfeit People vira verso un rock anni ’80, un po’ Huey Lewis un po’ Bon Jovi, niente per cui stracciarsi le vesti, con Let The River Run che introdotta da un riff “swampy” poi si perde di nuovo con qualche coretto ruffiano di troppo, benché la solista lavori sempre di fino. Bullet è un altro buon esempio del southern rock venato di hard dei migliori brani della Kris Barras Bard https://www.youtube.com/watch?v=5kYNH2sAd2E , anche se al solito a tratti gli arrangiamenti sono fin troppo ridondanti, ma chitarra e organo se le “suonano” ripetutamente di gusto negli intermezzi strumentali, Wound Up, ancora con slide in evidenza, questa volta insieme al piano, non sarebbe male, ma quegli intermezzi vocali leggerini sono sempre piuttosto prevedibili, What A Way To Go è sempre classico e piacevole hard rock ‘70’s style a tutto riff, e anche Not Fading è della stessa parrocchia, organo-chitarra e pedalare, mentre la conclusiva Pride Is Forever è viceversa una bella hard ballad, più consistente e meno scontata, con una bella melodia.
Che dire, buono nell’insieme, ma con alti e bassi.
Bruno Conti